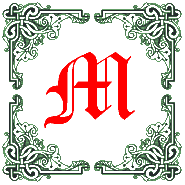Liturgia
Glossario liturgico
«Di seguito trovate un elenco delle più comuni parole riguardanti la liturgia tradizionale»
A
 Abito corale.
Abito corale.
L'abito corale è una veste ecclesiastica utilizzata dal Clero cattolico, usata nel coro dai consacrati. Prende il nome dal fatto che è l'abito indossato dai consacrati quando assistono alle celebrazioni liturgiche, cioè dal coro, per la celebrazione dell'Ufficio Divino o di un atto di devozione, per l'amministrazione dei Sacramenti se al di fuori della Messa.
L'abito corale viene indossato sia dal Papa, sia dai chierici ed anche dai seminaristi.
Le componenti ed i colori dei vari abiti corali variano a seconda del privilegio; di seguito è riportata una illustrazione degli abiti corali in funzione delle diverse dignità ecclesiastiche:







 Abito talare (o veste talare).
Abito talare (o veste talare).
L'abito talare (o, più semplicemente, la talare) è una lunga veste ecclesiastica abbottonata sul davanti, fermata spesso con una fascia, indossata da tutto il clero sia come veste ordinaria fuori dalla chiesa e dalle funzioni liturgiche, sia in chiesa durante le funzioni liturgiche sotto le vesti liturgiche. Il tipo del tessuto e il colore e quello dei paramenti connessi sono in funzione della dignità ecclesiastica. È generalmente nera per il clero inferiore, viola per i vescovi, rossa per i cardinali, rossa o bianca per il Papa.
La parola talare deriva dalla parola latina "talus", tallone. La talare, infatti, prende origine dalla veste dei sacerdoti ebraici che giungeva fino al tallone. Tale veste divenne, poi, tipica anche dei sacerdoti della cristianità a partire dal IV o V secolo d.C..
Come già detto, nella Chiesa Cattolica è la tipica veste ecclesiastica indossata al di fuori delle funzioni religiose. A seconda della circostanza in cui viene indossata, ad essa si possono aggiungere altri accessori che completano l'abito (abito piano, abito corale).
Ne esistono oggi vari modelli e tutti tra loro molto simili; in particolare, la classica talare romana ha maniche lunghe, è stretta fino alla vita come una giacca, prosegue fino a terra svasata e più ampia; il tutto chiuso da una striscia di bottoni sulla parte anteriore e, per finire, è solitamente chiusa da una fascia.
Viene indossata in differenti colori a seconda del grado:
L'abito talare non deve essere per forza sempre abbinato a una fascia portata alla vita, del colore corrispondente al grado. Vescovi, Cardinali e Papa sovrappongono poi una mantellina detta pellegrina, molto simile alla mozzetta, da cui si distingue per essere aperta sul davanti anziché chiusa da bottoni.
La veste talare nera viene anche indossata da alcuni laici, nell'esercizio di precise funzioni di ministero all'altare, come i seminaristi, gli accoliti e i ministranti: in questo caso, però, viene poi sovrapposta la cotta.
D'inverno, causa il gran freddo, sopra la talare s'indossa un lungo cappotto, detto greca.



 Abluzione (o purificazione).
Abluzione (o purificazione).
Nella Chiesa Cattolica sono previsti almeno tre tipi di purificazione corporale o abluzione da parte del sacerdote che si prepara a svolgere un'azione liturgica: la lavanda delle mani nel lavabo della sacrestia prima e dopo la celebrazione della Santa Messa, durante la Messa all'Offertorio prima di toccare le Sacre Specie dell'Eucaristia, il sacerdote purifica le mani attraverso un lavabo portatile composto di brocca con catino e manutergio, infine dopo l'atto della Comunione durante il quale il sacerdote purifica prima il Calice con il vino e in seguito le dita con il vino e con acqua.
Dopo la Messa il sacerdote può usare il lavabo della sacrestia per versarvi l'acqua residua della purificazione nonché per eliminare i residui delle sostanze benedette ridotte in cenere. Infatti, il lavabo della sacrestia è di solito collegato con il Sacrario della chiesa, una buca coperta da botola che mette a contatto direttamente con la terra di fondazione della chiesa, benedetta dal Vescovo durante la posa della prima pietra. In esso si getta qualsiasi cosa che sia stata benedetta o consacrata in modo che torni alla natura creata da Dio e sia l’usura a consumarla.
Il Sacrario è presente in tutte le Chiese costruite prima della riforma liturgica; qual'ora non ci fosse il Sacrario in sacrestia o non si avesse la certezza che lo scarico del lavabo sia collegato esclusivamente ad esso e non direttamente alla fogna, oppure sia stato chiuso dopo la riforma liturgica, è bene individuare un piccolo spazio di terra attiguo alla sacrestia, recintato e segnato magari con una piccola croce confitta nel terreno, che possa essere usato come Sacrario.
Nella Chiesa Cattolica, possono essere considerate forme di abluzione anche l'aspersione dei fedeli con l'acqua santa, il Battesimo e la lavanda dei piedi nel Giovedì Santo.


 Acqua Santa o Acqua benedetta.
Acqua Santa o Acqua benedetta.
L'Acqua Santa significa da sempre un rinnovamento e una rinascita in Cristo, come segno visibile del Battesimo.
Per tradizione ci si segna con l'Acqua Santa all'ingresso dei luoghi sacri. L'Acqua Santa è raccolta in speciali vasi di marmo o metallo chiamati "acquasantiere".
L'uso dell'Acqua Santa è previsto anche per le aspersioni durante la Messa o per amministrare speciali benedizioni.
La benedizione dell'acqua è effettuata seguendo il rito descritto dal "Rituale Romanum".

 Alba (detto anche Camice).
Alba (detto anche Camice).
Dal nome stesso, è una tunica di lino bianca senza aperture e lunga fino alle caviglie che simboleggia la veste del Battesimo.
Questo camice può essere decorato da bordi o galloni colorati o, per le occasioni più solenni, arricchito da un bordo in pizzo; è indossato dai ministri della Messa sotto le altre vesti liturgiche.
 (sotto lo scollo quadro va l'amitto)
(sotto lo scollo quadro va l'amitto)
Preghiera Ante Missam per indossare l'Alba: Ad Albam. Deálba me, Dómine, et munda cor meum; ut, in Sánguine Agni dealbátus, gáudiis pérfruar sempitérnis. *** Al camice. Puríficami, o Signore, e monda il mio cuore: affinché, purificato nel sangue dell’Agnello, io goda dei gaudii eterni.
 Almuzia.
Almuzia.
L'almuzia è un paramento liturgico compreso all'interno delle vesti cosiddette corali.
Detta anche "almuzio" o "almucio", è una mantellina nera, simile alla pellegrina, usata nei paesi nordici o a clima rigido, che veniva indossata sopra la veste talare e la cotta nelle celebrazioni liturgiche.
Oggi è caduta in disuso poiché in molti casi essa si trova a coincidere con la mozzetta, con la quale viene sostituita.
Attualmente essa è prevalentemente utilizzata dai canonici di alcuni capitoli minori come segno distintivo del proprio rango rispetto ai sacerdoti ordinari. In sostanza essa è divenuta un'insegna dei canonici che la portano come pellegrina oppure piegata su una spalla o sulle braccia, caso in cui assume foggia di stola.

 Altare (Altare maggiore).
Altare (Altare maggiore).
E' la superficie dove si celebra il Sacrificio Eucaristico. Ossia è la superficie in cui durante ogni Santa Messa si rinnova realmente, in modo non cruento, quindi senza spargimento di Sangue, il Sacrificio di Cristo Gesù sulla Croce. L’unico e perfetto Sacrificio che Nostro Signore Gesù Cristo ha compiuto di se stesso sul Golgota, offrendosi al Padre per la nostra Salvezza e per riacquistarci l’adozione a Figli di Dio e la vita eterna, perdute a causa del peccato originale (colpa realmente commessa dai nostri primogenitori, da noi contratta, non commessa, ma della quale portiamo tutte le conseguenze, anche dopo che viene cancellata per mezzo del santo Battesimo); questo Sacrificio, si rinnova sull'altare (che rappresenta il Golgota), dove Nostro Signore, durante la Santa Messa, si offre nuovamente in Sacrificio a Dio Padre (in unione ai nostri) per tramite del sacerdote (che agisce in persona Christi).
Il sacerdote, nell'accedere all'altare bacia le reliquie dei Santi contenute nella Pietra Santa; infatti l'altare, simbolo di Cristo, deve essere fatto di pietra, od almeno contenere una pietra in cui sono racchiuse le reliquie dei santi martiri. Questa Pietra Sacra vi viene inclusa dal Vescovo durante la consacrazione dell'altare, e vuol significare l'unione di Cristo e dei suoi membri nell'offerta del Santo Sacrificio.


 Ambone.
Ambone.
Nella chiesa, l'ambone è la struttura dalla quale vengono proclamate le letture. La sua superficie marmorea, o lignea, risulta sopraelevata in virtù del fatto che tale struttura è adibita alla proclamazione della Parola di Dio ed alla spiegazione del Vangelo.
L'ambone è solitamente chiuso da tre lati da un parapetto, aperto su una scala nel quarto lato. Nelle chiese vi sono in genere due amboni collocati rispettivamente ai lati dell'altare; in particolare, osservando l'altare, al lato destro (cornu Epistulae) si trova quello usato per la lettura dell'Epistola mentre al lato sinistro (cornu Evangelii) quello relativo alla lettura del Vangelo.
Essi possono essere decorati con teli del colore liturgico del giorno chiamati "copri-amboni".
Si differenzia dal pulpito, presente nelle chiese a partire dal XIV secolo circa: il pulpito infatti è più alto e soprattutto, essendo destinato alla sola predicazione, non si trova nel presbiterio, bensì nella navata.
Il termine ambone viene dal greco ambon, che indica ogni superficie convessa, panciuta: di fatto, molti amboni presentano una convessità in corrispondenza del leggio. Sinonimo di ambone è pergamo (dal greco pergamon, "luogo elevato").




 Amitto.
Amitto.
L'amitto è un panno di lino bianco e di forma rettangolare di dimensioni pari a circa 80x60 centimetri, che viene posto sulla testa e disposto intorno al collo e sulle spalle per coprire l'abito comune. Viene legato ai fianchi grazie a due fettucce, le quali possono essere cucite all’amitto o da esso separabili.
L'amitto è utilizzato dai sacri ministri (celebrante, diacono e suddiacono); al centro ha una croce che può essere baciata dal sacerdote prima di indossarlo.
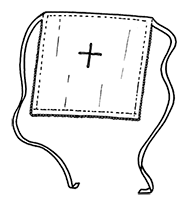
Preghiera Ante Missam per indossare l'Amitto: Ad Amictum. Impóne, Dómine, cápiti meo gáleam salútis, ad expugnándos diabólicos incúrsus. *** All'amitto. Imponi, o Signore, sul mio capo l’elmo della salvezza, per vincere gli assalti del demonio.
 Ampolline (vino e acqua per infusione e abluzione).
Ampolline (vino e acqua per infusione e abluzione).
Coppia di vasetti in vetro dotati di manico, solitamente forniti di copertura, appoggiati ad un piattino, che può essere adibito alla raccolta dell'acqua del lavabo, in cui sono contenuti il vino e l'acqua.
Ora, il vino e l'acqua sono usati dal celebrante al momenento dell'infusione quando si versano nel Calice per la celebrazione dell'Eucarestia od, ancora, durante la Messa all'Offertorio prima di toccare le Sacre Specie dell'Eucarestia, in tale momento il sacerdote si serve dell'acqua per purificare le mani (lavabo), infine dopo l'atto della Comunione durante il quale il sacerdote purifica prima il Calice con il vino e in seguito le dita con il vino e con acqua.

Al tradizionale corpo in vetro possono essere abbinate coperture decorative o manici in metallo nobile. L'uso delle ampolline è sempre stato radicato nella storia liturgica.
 Anàmnesi.
Anàmnesi.
Nella celebrazione della Santa Messa, l'anàmnesi è la parte della Grande Preghiera Eucaristica tra la Consacrazione e la Dossologia, in cui si ricorda l'opera della Salvezza; comincia con le parole «Unde et mémores...». Nel canone della Messa l'anàmnesi segue l'elevazione e ricorda la Redenzione per rendere accetto al Padre il Sacrificio Eucaristico; subito dopo la Consacrazione, ricorda la Passione, la Risurrezione e l'Ascensione di Gesù, contiene l'offerta al Padre, la domanda di accettare il Sacrificio, come quelli di Abele, Abramo e Melchisedech.
Dunque, per anàmnesi, in liturgia, si intende il memoriale dei misteri. Siamo nell'ambito della catàbasi divina, ossia dell'azione di Dio a servizio del suo popolo, che è la dimensione principale della liturgia della Chiesa. Alla catàbasi segue l'anàbasi, ossia l'ascesa dell'uomo a Dio. Quando parliamo di anàmnesi, tuttavia, ci riferiamo ad un'azione di Dio, il quale mediante il far memoria degli eventi salvifici da parte dell'uomo, entra sempre nuovamente nel tempo e attualizza l'evento di Salvezza grazie all'azione dello Spirito Santo. Perciò, la liturgia è anàmnesi, ossia memoriale dei misteri: l'evento di Salvezza che un tempo vissero altri uomini, oggi si rende realmente presente a noi nel mistero, dunque, in un altro modo, ma la Salvezza è per noi reale. Dall'anàmnesi scaturisce l'epìclesi, che appartiene alla dimensione anabatica della liturgia.
 Anello.
Anello.
L'anello è un simbolo molto usato nella liturgia. Possiamo distinguerne di quattro tipi:
Anello canonicale.
Si tratta di un tipo di anello, poi abolito da Papa S.Pio X, usato presso i capitoli delle cattedrali. E' a forma di scudo in cui si trova inciso il blasone del canonico stesso o quello del capitolo. In assenza di blasoni era possibile incidervi immagini sacre. Alla morte del canonico, l'anello poteva rimanere di proprietà del capitolo stesso.
Anello episcopale.
Il Vescovo indossa l'anello che sancisce il legame tra Lui e la Chiesa stessa.
I materiali utilizzati sono i più disparati, ma quello più frequente è l'oro.
Al centro poteva essere collocata l'arma del Vescovo od una pietra preziosa il cui colore indicava la dignità del Vescovo come segue:
- ametista (varietà di quarzo - minerale prezioso): color viola, Vescovo;
- topazio (minerale prezioso): color giallo, Arcivescovo;
- rubino o zaffiro (minerali preziosi): colori rispettivamente rosso e blu/azzurro, Cardinale;
Ora l'uso delle pietre è comunemente soppiantato da quello delle immagini sacre incise sul metallo nobile.

Anello per chiroteca.
E' un anello simile a quello episcopale ma più largo, in modo da essere agevolmente indossato dal Vescovo officiante sopra le chiroteche.
Per il suo uso è detto anche "pontificale" ed è attualmente quasi in disuso, poichè le chiroteche non sono più obbligatorie per i pontificali.
Spesso gli anelli per chiroteche hanno un meccanismo per regolarne le dimensioni.

Anello piscatorio (o del Pescatore).
E' il particolare anello riservato solo al Pontefice che lo usa per suggellare i documenti pontifici. L'anello, a contatto con la ceralacca, imprimeva il disegno ivi raffigurato, ovvero quello di S.Pietro pescatore e permetteva una maggiore aderenza della cera sul documento in pergamena.
Dall'antico Pontificale Romano.
Benedizione dell'anello.
Dopo la benedizione e la consegna del Pastorale al nuovo Vescovo eletto, il Consacrante Principale procede alla benedizione dell'Anello, da consegnare all'eletto, dicendo le seguenti parole:
"Oremus. Creator, et conservator humani generis, dator gratiae spiritualis, largitor aeternae salutis, tu, Domine, emitte bene✠dictionem tuam super hunc annulum; ut quicumque hoc sacrosanctae fidei signo insignitus incesserit, in virtute coelestis defensionis ad aeternam vitam sibi proficiat. Per Christum Dominum Nostrum. R. Amen."
Consegna dell'anello.
Dopo la benedizione dell'anello, il Consacrante Principale mette l'anello sull'anulare della mano destra dell'eletto mentre dice le seguenti parole: "Accipe annulum fidei scilicet signaculum: quatenus sponsam Dei, sanctam videlicet Ecclesiam, intemerata fide ornatus, illibate custodias. R. Amen."
La celebrazione poi prosegue con l'imposizione dell'Evangeliario sulle spalle del Vescovo eletto e con la consegna dell'Evangeliario nelle mani del Vescovo eletto.
Nel Rito Romano antico il Vescovo, ricevendo l'anello, recita la seguente preghiera (dal Messale Romano del 1962):
"Cordis et córporis mei, Dómine, dígitos virtúte décora, et septifórmis Spíritus sanctificatióne circúmda" *** "Decora con la virtù, o Signore, le dita del mio cuore e del mio corpo, e circondami con la santificazione del tuo Spirito settiforme."

 Anno liturgico (o Anno ecclesiastico).
Anno liturgico (o Anno ecclesiastico).
L'anno ecclesiastico incomincia con la prima domenica di Avvento e termina al sabato successivo all'ultima domenica dopo Pentecoste.
E' composto di tempi liturgici, che nel loro alternarsi formano il Proprio del Tempo o ciclo temporale. Esso ci fa rivivere i grandi misteri del Cristo nell'opera mirabile della nostra redenzione.
Vi è poi un secondo ciclo, chiamato Proprio dei Santi o ciclo santorale, ed è composto dalle feste di quelle anime sante, nelle quali si è compiuta la redenzione.
Il ciclo temporale, che dipende dalla festa di Pasqua, si compone soprattutto di feste a data variabile di anno in anno, mentre il ciclo santorale comprende in generale feste a data fissa.
Per giorno liturgico si intende ogni giorno santificato dalle azioni liturgiche, la principale delle quali è la Santa Messa, completata dal Divino Ufficio. Può essere di cinque specie: domenica, feria, vigilia, festa e ottava.
Esiste una classificazione dei giorni liturgici che, secondo la loro dignità ed importanza, sono divisi in quattro classi:
In particolare, nei sabati di IV classe si può dire la Messa di Santa Maria in sabato.
Nello svolgersi simultaneo dei cicli temporale e santorale avviene talvolta che due o più giorni liturgici ricorrono contemporaneamente. Questo fatto è denominato occorrenza.
Quando si verifica ciò, il giorno liturgico di classe superiore ha la prevalenza su quello di classe inferiore. Quest'ultimo è omesso, commemorato o trasferito, a seconda del caso.
Soltanto le feste di I classe possono essere trasferite in un altro giorno.
Le domeniche di I classe hanno la prevalenza su tutte le feste, eccetto la festa dell'Immacolata Concezione.
Le domeniche di II classe hanno la prevalenza sulle feste di II classe. Però le feste di I o II classe di Nostro Signore che ricorrono in domenica, vengono celebrate in luogo della domenica stessa, con ogni diritto e privilegio.
Le feste di III classe non sono mai celebrate in Quaresima.
 Armadietto degli Oli Santi o Tabernacolo degli Oli Santi.
Armadietto degli Oli Santi o Tabernacolo degli Oli Santi.
E' un piccolo mobile a muro o appeso presso l'altare maggiore, nel Battistero o nella Sacrestia, utilizzato per conservare gli Oli Santi. Gli Oli Santi sono tre, Santo Crisma, Olio dei catecumeni e Olio degli infermi e sono consacrati dal Vescovo; in particolare la consacrazione del Santo Crisma e la benedizione dell'Olio dei catecumeni e dell'Olio degli infermi vengono fatte il Giovedì Santo nella Messa Crismale. Si tenga presente che il Crisma è il più importante dei tre Oli Santi e, dopo la Messa Crismale, viene distribuito (insieme agli altri due Oli) ad ogni parrocchia per l'amministrazione dei Sacramenti e Sacramentali non riservati al Vescovo (ad esempio nel Battesimo o nell'Unzione degli infermi); i Vescovi lo usano per l'amministrazione dei Sacramenti e Sacramentali ad essi riservati (Cresima o Confermazione ed Ordine Sacro), nella dedicazione e consacrazione di una Chiesa per ungere le pareti e gli altari, e nella benedizione dei Vasi Sacri (Calice e Patena) usati per la celebrazione dell'Eucarestia. Nelle parrocchie i tre Oli Santi (Crisma, Olio dei catecumeni e Olio degli infermi) vengono di solito custoditi in un'apposita sede chiamata appunto "armadietto degli Oli Santi" o "tabernacolo degli Oli Santi". Sullo sportello, che deve rimanere chiuso a chiave, compare talora la scritta Olea Sancta.


 Arredi Sacri.
Arredi Sacri.
Sono gli oggetti che vengono usati dalla Chiesa Cattolica per il Culto Divino, specialmente quelli che più strettamente si riferiscono alla S.ma Eucaristia; servono sia per la persona del sacerdote (paramenti sacri), sia per la confezione e conservazione del S.mo Sacramento (Vasi Sacri), sia anche per ornare l'altare e la chiesa dove si celebra.
A titolo esemplificativo, di seguito ne sono riportati alcuni:
 Aspersione o Asperges.
Aspersione o Asperges.
E' il termine col quale durante la liturgia nella Forma Straordinaria del Rito Romano viene chiamato il rito dell'aspersione con acqua benedetta prima della Santa Messa (solo nelle Messe della domenica cantate o solenni). Prende il suo nome dalla prima parola dell'antifona, tratta dal Salmo 50, che viene cantata (al di fuori del tempo pasquale, ove viene sostituita dal "Vidi Aquam") durante tale rito per ricordare ai cristiani la santità del loro battesimo:
Aspèrges me, * Dòmine, hyssòpo et mundàbor: lavàbis me, et super nivem dealbàbor. *** Aspergimi, Signore, con l'issopo e sarò purificato; làvami e diverrò più bianco della neve.

 Aspersorio.
Aspersorio.
E' detto anche "Asperges" dal vocabolo iniziale dell'antifona in latino che durante la liturgia nella Forma Straordinaria del Rito Romano viene cantata durante il rito dell'aspersione prima della Messa.
E' l'oggetto usato per aspergere i fedeli con l'acqua benedetta, per ricordare ai cristiani la santità del loro battesimo. E' corredato solitamente di un opportuno secchiello per contenere l'acqua benedetta.


 Asta accendi-spegni candele (o accenditoio-spegnitoio).
Asta accendi-spegni candele (o accenditoio-spegnitoio).
Si tratta di un oggetto dottato di serbatoio a cera liquida che alimenta uno stoppino utile per accendere le candele d'altare, e dottato inoltre di un opportuno cappuccio utile per spegnere le candele. Tale oggetto è fissato all'estremità di un'asta in metallo (spesso regolabile in lunghezza) ed è usato da colui che è incaricato alla cura dell'altare prima e dopo ogni funzione liturgica.


 Asterisco.
Asterisco.
Piccolo oggetto di metallo dorato, costituito da lamine incrociate, che si colloca sull'ostia, deposta nella patena, nelle liturgie papali.
Nella Messa Papale antica, l'asterisco veniva utilizzato per evitare che l’ostia venisse accidentalmente a contatto con il velo omerale indossato dal suddiacono.
Oggi viene utilizzato, nelle Messe celebrate dal Papa all'aperto, per tenere ferma l'ostia sulla patena.

 Autentica.
Autentica.
E' un attestato in cui si certifica l'autenticità di una reliquia. Sull'autentica venivano riportate varie informazioni, come le caratteristiche fisiche delle reliquie e la qualità della teca destinata a custodirle. Potevano essere rilasciate dall'Ordinario diocesano, dal Postulatore delle cause dei Santi o dal Sacrista del Palazzo apostolico se queste erano custodite nel sacrario della sacrestia papale. Attualmente, in luogo del Sacrista, è il Maestro delle celebrazioni liturgiche che firma l'autentica.
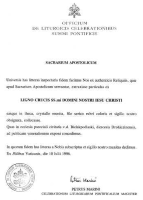
 Abito corale.
Abito corale. L'abito corale è una veste ecclesiastica utilizzata dal Clero cattolico, usata nel coro dai consacrati. Prende il nome dal fatto che è l'abito indossato dai consacrati quando assistono alle celebrazioni liturgiche, cioè dal coro, per la celebrazione dell'Ufficio Divino o di un atto di devozione, per l'amministrazione dei Sacramenti se al di fuori della Messa.
L'abito corale viene indossato sia dal Papa, sia dai chierici ed anche dai seminaristi.
Le componenti ed i colori dei vari abiti corali variano a seconda del privilegio; di seguito è riportata una illustrazione degli abiti corali in funzione delle diverse dignità ecclesiastiche:
 |
Papa
|
 |
Cardinali
|
 |
Arcivescovi e Vescovi
|
 |
Prelati superiori della Curia Romana e Protonotari apostolici numerari |
 |
Protonotari apostolici soprannumerari e Prelati d'onore di Sua Santità o Monsignori elevati dal vescovo |
 |
Cappellani di Sua Santità |
 |
Presbiteri, diaconi, seminaristi |







 Abito talare (o veste talare).
Abito talare (o veste talare). L'abito talare (o, più semplicemente, la talare) è una lunga veste ecclesiastica abbottonata sul davanti, fermata spesso con una fascia, indossata da tutto il clero sia come veste ordinaria fuori dalla chiesa e dalle funzioni liturgiche, sia in chiesa durante le funzioni liturgiche sotto le vesti liturgiche. Il tipo del tessuto e il colore e quello dei paramenti connessi sono in funzione della dignità ecclesiastica. È generalmente nera per il clero inferiore, viola per i vescovi, rossa per i cardinali, rossa o bianca per il Papa.
La parola talare deriva dalla parola latina "talus", tallone. La talare, infatti, prende origine dalla veste dei sacerdoti ebraici che giungeva fino al tallone. Tale veste divenne, poi, tipica anche dei sacerdoti della cristianità a partire dal IV o V secolo d.C..
Come già detto, nella Chiesa Cattolica è la tipica veste ecclesiastica indossata al di fuori delle funzioni religiose. A seconda della circostanza in cui viene indossata, ad essa si possono aggiungere altri accessori che completano l'abito (abito piano, abito corale).
Ne esistono oggi vari modelli e tutti tra loro molto simili; in particolare, la classica talare romana ha maniche lunghe, è stretta fino alla vita come una giacca, prosegue fino a terra svasata e più ampia; il tutto chiuso da una striscia di bottoni sulla parte anteriore e, per finire, è solitamente chiusa da una fascia.
Viene indossata in differenti colori a seconda del grado:
- nero per i sacerdoti, cui è possibile aggiungere il ferraiolo di medesimo colore in occasioni civili di particolare solennità;
- nero con occhielli, bottoni, bordi e fodera di colore paonazzo, per i monsignori di grado "Cappellano di Sua Santità";
-
nero con occhielli, bottoni, bordi e fodera rubino per i Prelati d'onore di Sua Santità, i Prelati Superiori dei Dicasteri della
Curia Romana che non hanno la dignità episcopale, gli Uditori della Sacra Rota Romana, il Promotore Generale di Giustizia e il
Difensore del Vincolo nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, i Protonotari Apostolici de numero, i Protonotari Apostolici
soprannumerari, i Chierici della Camera Apostolica, i Prelati dell’Anticamera Pontificia ed i vescovi. Tutti
questi prelati, eccettuato il Prelato d'onore di Sua Santità possono aggiungere il ferraiolone di colore paonazzo in occasioni civili
di particolare solennità (abito piano). Tali Prelati come abito corale devono indossare la talare di colore
paonazzo con occhielli, bottoni, bordi e fodera cremisi alla quale viene aggiunto il rocchetto, ma non dai
Protonotari Apostolici soprannumerari e dai Prelati d'onore di Sua Santità che indossano la cotta. La
mantelletta paonazza e la berretta nera con fiocco rosso non
possono invece essere indossate dai vescovi, dai Protonotari Apostolici soprannumerari e dai Prelati d'onore di Sua Santità.
I vescovi aggiungono invece la mozzetta paonazza, la croce pettorale
sostenuta da un cordoncino verde/oro e la berretta di colore paonazzo con fiocco del medesimo
colore, mentre i Nunzi Apostolici, che rappresentano la Santa Sede, portano
la berretta con fiocco e la fascia in seta moirée color paonazzo, che
li distingue dagli altri Vescovi.
Alcuni Arcivescovi per privilegio invalso usano ancora il colore cremisi (o rubino), ad esempio l'Arcivescovo metropolita di Udine erede dell'antico Patriarcato di Aquileia, come pure alcuni Arcivescovi Primati che portavano un rosso simile a quello cardinalizio, un po' più abbrunato, anche in seta moirée e il cordone pettorale in color oro/rosso anziché oro/verde come gli altri Vescovi e Arcivescovi. Gli Arcivescovi di Salisburgo, di Vercelli e il Patriarca di Venezia hanno il privilegio, concesso loro dal Pontefice romano da secoli e tuttora invalso, di portare un abito corale di colore cardinalizio, pur non essendo cardinali; - nero con occhielli, bottoni, bordi e fodera ponsò per i Cardinali; ad essa può essere aggiunto il ferraiolone di colore rosso marezzato, in occasioni civili di particolare solennità (abito piano); i Cardinali come abito corale devono indossare la talare rosso ponsò, alla quale vengono aggiunti il rocchetto, la mozzetta di colore rosso ponsò, la croce pettorale sostenuta da un cordoncino rosso/oro, e la berretta senza il fiocco e sempre di colore rosso in seta moirée come la fascia;
- bianco per il Papa che la porta in lanetta, con fascia bianco avorio in seta moirée e sopramaniche e zucchetto della stessa fattura e tinta. Esisteva anche la tradizione, sopravvissuta fino a tempi recenti, di una veste tutta in seta moirée bianca per il giorno dell'elezione del Pontefice e per alcune circostanze solenni (come analogamente per i cardinali rossa in seta moirée e per gli Arcivescovi Nunzi Apostolici paonazza in seta moirée, cioè le venature tipiche di questa seta trattata, nelle solennità più importanti). Il colore bianco può essere utilizzato anche dai sacerdoti, dai prelati, dai vescovi e dai cardinali in missione od in paesi caldi, a patto che occhielli, bottoni, bordi e fodera siano del grado corrispondente (ad esempio, un semplice sacerdote può indossarlo bianco ma con occhielli, bottoni, bordi e fodera neri);
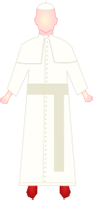 Papa |
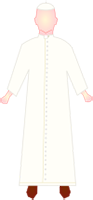 Papa Emerito |
 Cardinale |
 Vescovo |
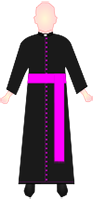 Monsignore |
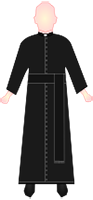 Presbitero, Diacono, Seminarista |
L'abito talare non deve essere per forza sempre abbinato a una fascia portata alla vita, del colore corrispondente al grado. Vescovi, Cardinali e Papa sovrappongono poi una mantellina detta pellegrina, molto simile alla mozzetta, da cui si distingue per essere aperta sul davanti anziché chiusa da bottoni.
La veste talare nera viene anche indossata da alcuni laici, nell'esercizio di precise funzioni di ministero all'altare, come i seminaristi, gli accoliti e i ministranti: in questo caso, però, viene poi sovrapposta la cotta.
D'inverno, causa il gran freddo, sopra la talare s'indossa un lungo cappotto, detto greca.



 Abluzione (o purificazione).
Abluzione (o purificazione). Nella Chiesa Cattolica sono previsti almeno tre tipi di purificazione corporale o abluzione da parte del sacerdote che si prepara a svolgere un'azione liturgica: la lavanda delle mani nel lavabo della sacrestia prima e dopo la celebrazione della Santa Messa, durante la Messa all'Offertorio prima di toccare le Sacre Specie dell'Eucaristia, il sacerdote purifica le mani attraverso un lavabo portatile composto di brocca con catino e manutergio, infine dopo l'atto della Comunione durante il quale il sacerdote purifica prima il Calice con il vino e in seguito le dita con il vino e con acqua.
Dopo la Messa il sacerdote può usare il lavabo della sacrestia per versarvi l'acqua residua della purificazione nonché per eliminare i residui delle sostanze benedette ridotte in cenere. Infatti, il lavabo della sacrestia è di solito collegato con il Sacrario della chiesa, una buca coperta da botola che mette a contatto direttamente con la terra di fondazione della chiesa, benedetta dal Vescovo durante la posa della prima pietra. In esso si getta qualsiasi cosa che sia stata benedetta o consacrata in modo che torni alla natura creata da Dio e sia l’usura a consumarla.
Il Sacrario è presente in tutte le Chiese costruite prima della riforma liturgica; qual'ora non ci fosse il Sacrario in sacrestia o non si avesse la certezza che lo scarico del lavabo sia collegato esclusivamente ad esso e non direttamente alla fogna, oppure sia stato chiuso dopo la riforma liturgica, è bene individuare un piccolo spazio di terra attiguo alla sacrestia, recintato e segnato magari con una piccola croce confitta nel terreno, che possa essere usato come Sacrario.
Nella Chiesa Cattolica, possono essere considerate forme di abluzione anche l'aspersione dei fedeli con l'acqua santa, il Battesimo e la lavanda dei piedi nel Giovedì Santo.


 Acqua Santa o Acqua benedetta.
Acqua Santa o Acqua benedetta. L'Acqua Santa significa da sempre un rinnovamento e una rinascita in Cristo, come segno visibile del Battesimo.
Per tradizione ci si segna con l'Acqua Santa all'ingresso dei luoghi sacri. L'Acqua Santa è raccolta in speciali vasi di marmo o metallo chiamati "acquasantiere".
L'uso dell'Acqua Santa è previsto anche per le aspersioni durante la Messa o per amministrare speciali benedizioni.
La benedizione dell'acqua è effettuata seguendo il rito descritto dal "Rituale Romanum".

 Alba (detto anche Camice).
Alba (detto anche Camice). Dal nome stesso, è una tunica di lino bianca senza aperture e lunga fino alle caviglie che simboleggia la veste del Battesimo.
Questo camice può essere decorato da bordi o galloni colorati o, per le occasioni più solenni, arricchito da un bordo in pizzo; è indossato dai ministri della Messa sotto le altre vesti liturgiche.
 (sotto lo scollo quadro va l'amitto)
(sotto lo scollo quadro va l'amitto) Preghiera Ante Missam per indossare l'Alba: Ad Albam. Deálba me, Dómine, et munda cor meum; ut, in Sánguine Agni dealbátus, gáudiis pérfruar sempitérnis. *** Al camice. Puríficami, o Signore, e monda il mio cuore: affinché, purificato nel sangue dell’Agnello, io goda dei gaudii eterni.
 Almuzia.
Almuzia. L'almuzia è un paramento liturgico compreso all'interno delle vesti cosiddette corali.
Detta anche "almuzio" o "almucio", è una mantellina nera, simile alla pellegrina, usata nei paesi nordici o a clima rigido, che veniva indossata sopra la veste talare e la cotta nelle celebrazioni liturgiche.
Oggi è caduta in disuso poiché in molti casi essa si trova a coincidere con la mozzetta, con la quale viene sostituita.
Attualmente essa è prevalentemente utilizzata dai canonici di alcuni capitoli minori come segno distintivo del proprio rango rispetto ai sacerdoti ordinari. In sostanza essa è divenuta un'insegna dei canonici che la portano come pellegrina oppure piegata su una spalla o sulle braccia, caso in cui assume foggia di stola.

 Altare (Altare maggiore).
Altare (Altare maggiore). E' la superficie dove si celebra il Sacrificio Eucaristico. Ossia è la superficie in cui durante ogni Santa Messa si rinnova realmente, in modo non cruento, quindi senza spargimento di Sangue, il Sacrificio di Cristo Gesù sulla Croce. L’unico e perfetto Sacrificio che Nostro Signore Gesù Cristo ha compiuto di se stesso sul Golgota, offrendosi al Padre per la nostra Salvezza e per riacquistarci l’adozione a Figli di Dio e la vita eterna, perdute a causa del peccato originale (colpa realmente commessa dai nostri primogenitori, da noi contratta, non commessa, ma della quale portiamo tutte le conseguenze, anche dopo che viene cancellata per mezzo del santo Battesimo); questo Sacrificio, si rinnova sull'altare (che rappresenta il Golgota), dove Nostro Signore, durante la Santa Messa, si offre nuovamente in Sacrificio a Dio Padre (in unione ai nostri) per tramite del sacerdote (che agisce in persona Christi).
Il sacerdote, nell'accedere all'altare bacia le reliquie dei Santi contenute nella Pietra Santa; infatti l'altare, simbolo di Cristo, deve essere fatto di pietra, od almeno contenere una pietra in cui sono racchiuse le reliquie dei santi martiri. Questa Pietra Sacra vi viene inclusa dal Vescovo durante la consacrazione dell'altare, e vuol significare l'unione di Cristo e dei suoi membri nell'offerta del Santo Sacrificio.


 Ambone.
Ambone. Nella chiesa, l'ambone è la struttura dalla quale vengono proclamate le letture. La sua superficie marmorea, o lignea, risulta sopraelevata in virtù del fatto che tale struttura è adibita alla proclamazione della Parola di Dio ed alla spiegazione del Vangelo.
L'ambone è solitamente chiuso da tre lati da un parapetto, aperto su una scala nel quarto lato. Nelle chiese vi sono in genere due amboni collocati rispettivamente ai lati dell'altare; in particolare, osservando l'altare, al lato destro (cornu Epistulae) si trova quello usato per la lettura dell'Epistola mentre al lato sinistro (cornu Evangelii) quello relativo alla lettura del Vangelo.
Essi possono essere decorati con teli del colore liturgico del giorno chiamati "copri-amboni".
Si differenzia dal pulpito, presente nelle chiese a partire dal XIV secolo circa: il pulpito infatti è più alto e soprattutto, essendo destinato alla sola predicazione, non si trova nel presbiterio, bensì nella navata.
Il termine ambone viene dal greco ambon, che indica ogni superficie convessa, panciuta: di fatto, molti amboni presentano una convessità in corrispondenza del leggio. Sinonimo di ambone è pergamo (dal greco pergamon, "luogo elevato").




 Amitto.
Amitto. L'amitto è un panno di lino bianco e di forma rettangolare di dimensioni pari a circa 80x60 centimetri, che viene posto sulla testa e disposto intorno al collo e sulle spalle per coprire l'abito comune. Viene legato ai fianchi grazie a due fettucce, le quali possono essere cucite all’amitto o da esso separabili.
L'amitto è utilizzato dai sacri ministri (celebrante, diacono e suddiacono); al centro ha una croce che può essere baciata dal sacerdote prima di indossarlo.
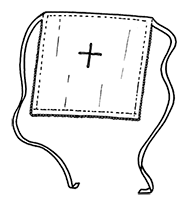
Preghiera Ante Missam per indossare l'Amitto: Ad Amictum. Impóne, Dómine, cápiti meo gáleam salútis, ad expugnándos diabólicos incúrsus. *** All'amitto. Imponi, o Signore, sul mio capo l’elmo della salvezza, per vincere gli assalti del demonio.
 Ampolline (vino e acqua per infusione e abluzione).
Ampolline (vino e acqua per infusione e abluzione). Coppia di vasetti in vetro dotati di manico, solitamente forniti di copertura, appoggiati ad un piattino, che può essere adibito alla raccolta dell'acqua del lavabo, in cui sono contenuti il vino e l'acqua.
Ora, il vino e l'acqua sono usati dal celebrante al momenento dell'infusione quando si versano nel Calice per la celebrazione dell'Eucarestia od, ancora, durante la Messa all'Offertorio prima di toccare le Sacre Specie dell'Eucarestia, in tale momento il sacerdote si serve dell'acqua per purificare le mani (lavabo), infine dopo l'atto della Comunione durante il quale il sacerdote purifica prima il Calice con il vino e in seguito le dita con il vino e con acqua.

Al tradizionale corpo in vetro possono essere abbinate coperture decorative o manici in metallo nobile. L'uso delle ampolline è sempre stato radicato nella storia liturgica.
 Anàmnesi.
Anàmnesi. Nella celebrazione della Santa Messa, l'anàmnesi è la parte della Grande Preghiera Eucaristica tra la Consacrazione e la Dossologia, in cui si ricorda l'opera della Salvezza; comincia con le parole «Unde et mémores...». Nel canone della Messa l'anàmnesi segue l'elevazione e ricorda la Redenzione per rendere accetto al Padre il Sacrificio Eucaristico; subito dopo la Consacrazione, ricorda la Passione, la Risurrezione e l'Ascensione di Gesù, contiene l'offerta al Padre, la domanda di accettare il Sacrificio, come quelli di Abele, Abramo e Melchisedech.
Dunque, per anàmnesi, in liturgia, si intende il memoriale dei misteri. Siamo nell'ambito della catàbasi divina, ossia dell'azione di Dio a servizio del suo popolo, che è la dimensione principale della liturgia della Chiesa. Alla catàbasi segue l'anàbasi, ossia l'ascesa dell'uomo a Dio. Quando parliamo di anàmnesi, tuttavia, ci riferiamo ad un'azione di Dio, il quale mediante il far memoria degli eventi salvifici da parte dell'uomo, entra sempre nuovamente nel tempo e attualizza l'evento di Salvezza grazie all'azione dello Spirito Santo. Perciò, la liturgia è anàmnesi, ossia memoriale dei misteri: l'evento di Salvezza che un tempo vissero altri uomini, oggi si rende realmente presente a noi nel mistero, dunque, in un altro modo, ma la Salvezza è per noi reale. Dall'anàmnesi scaturisce l'epìclesi, che appartiene alla dimensione anabatica della liturgia.
 Anello.
Anello. L'anello è un simbolo molto usato nella liturgia. Possiamo distinguerne di quattro tipi:
Anello canonicale.
Si tratta di un tipo di anello, poi abolito da Papa S.Pio X, usato presso i capitoli delle cattedrali. E' a forma di scudo in cui si trova inciso il blasone del canonico stesso o quello del capitolo. In assenza di blasoni era possibile incidervi immagini sacre. Alla morte del canonico, l'anello poteva rimanere di proprietà del capitolo stesso.
Anello episcopale.
Il Vescovo indossa l'anello che sancisce il legame tra Lui e la Chiesa stessa.
I materiali utilizzati sono i più disparati, ma quello più frequente è l'oro.
Al centro poteva essere collocata l'arma del Vescovo od una pietra preziosa il cui colore indicava la dignità del Vescovo come segue:
- ametista (varietà di quarzo - minerale prezioso): color viola, Vescovo;
- topazio (minerale prezioso): color giallo, Arcivescovo;
- rubino o zaffiro (minerali preziosi): colori rispettivamente rosso e blu/azzurro, Cardinale;
Ora l'uso delle pietre è comunemente soppiantato da quello delle immagini sacre incise sul metallo nobile.

Anello per chiroteca.
E' un anello simile a quello episcopale ma più largo, in modo da essere agevolmente indossato dal Vescovo officiante sopra le chiroteche.
Per il suo uso è detto anche "pontificale" ed è attualmente quasi in disuso, poichè le chiroteche non sono più obbligatorie per i pontificali.
Spesso gli anelli per chiroteche hanno un meccanismo per regolarne le dimensioni.

Anello piscatorio (o del Pescatore).
E' il particolare anello riservato solo al Pontefice che lo usa per suggellare i documenti pontifici. L'anello, a contatto con la ceralacca, imprimeva il disegno ivi raffigurato, ovvero quello di S.Pietro pescatore e permetteva una maggiore aderenza della cera sul documento in pergamena.
Dall'antico Pontificale Romano.
Benedizione dell'anello.
Dopo la benedizione e la consegna del Pastorale al nuovo Vescovo eletto, il Consacrante Principale procede alla benedizione dell'Anello, da consegnare all'eletto, dicendo le seguenti parole:
"Oremus. Creator, et conservator humani generis, dator gratiae spiritualis, largitor aeternae salutis, tu, Domine, emitte bene✠dictionem tuam super hunc annulum; ut quicumque hoc sacrosanctae fidei signo insignitus incesserit, in virtute coelestis defensionis ad aeternam vitam sibi proficiat. Per Christum Dominum Nostrum. R. Amen."
Consegna dell'anello.
Dopo la benedizione dell'anello, il Consacrante Principale mette l'anello sull'anulare della mano destra dell'eletto mentre dice le seguenti parole: "Accipe annulum fidei scilicet signaculum: quatenus sponsam Dei, sanctam videlicet Ecclesiam, intemerata fide ornatus, illibate custodias. R. Amen."
La celebrazione poi prosegue con l'imposizione dell'Evangeliario sulle spalle del Vescovo eletto e con la consegna dell'Evangeliario nelle mani del Vescovo eletto.
Nel Rito Romano antico il Vescovo, ricevendo l'anello, recita la seguente preghiera (dal Messale Romano del 1962):
"Cordis et córporis mei, Dómine, dígitos virtúte décora, et septifórmis Spíritus sanctificatióne circúmda" *** "Decora con la virtù, o Signore, le dita del mio cuore e del mio corpo, e circondami con la santificazione del tuo Spirito settiforme."

 Anno liturgico (o Anno ecclesiastico).
Anno liturgico (o Anno ecclesiastico). L'anno ecclesiastico incomincia con la prima domenica di Avvento e termina al sabato successivo all'ultima domenica dopo Pentecoste.
E' composto di tempi liturgici, che nel loro alternarsi formano il Proprio del Tempo o ciclo temporale. Esso ci fa rivivere i grandi misteri del Cristo nell'opera mirabile della nostra redenzione.
Vi è poi un secondo ciclo, chiamato Proprio dei Santi o ciclo santorale, ed è composto dalle feste di quelle anime sante, nelle quali si è compiuta la redenzione.
Il ciclo temporale, che dipende dalla festa di Pasqua, si compone soprattutto di feste a data variabile di anno in anno, mentre il ciclo santorale comprende in generale feste a data fissa.
Per giorno liturgico si intende ogni giorno santificato dalle azioni liturgiche, la principale delle quali è la Santa Messa, completata dal Divino Ufficio. Può essere di cinque specie: domenica, feria, vigilia, festa e ottava.
Esiste una classificazione dei giorni liturgici che, secondo la loro dignità ed importanza, sono divisi in quattro classi:
-
I CLASSE
- Domeniche: quattro di Avvento, quattro di Quaresima, due di Passione, Pasqua, domenica in albis e Pentecoste.
- Ferie: mercoledì delle ceneri, ferie della Settimana Santa.
- Vigilie: di Natale e di Pentecoste.
- Feste: quelle indicate nel calendario liturgico del ciclo santorale.
- Ottave: di Pasqua e di Pentecoste, e anche il giorno ottavo di Natale.
-
II CLASSE
- Domeniche: tutte le rimanenti che non sono di prima classe.
- Ferie: di Avvento dal 17 al 23 dicembre e delle Quattro Tempora di Avvento, di Quaresima e di settembre.
- Vigilie: dell'Ascensione, dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, della Natività di S.Giovanni Battista e dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo.
- Feste: quelle indicate nel calendario liturgico del ciclo santorale.
- Ottava: di Natale.
-
III CLASSE
- Ferie: di Avvento fino al 16 dicembre, di Quaresima e di Passione.
- Vigilia: di San Lorenzo martire.
- Feste: quelle indicate nel calendario liturgico del ciclo santorale.
-
IV CLASSE
- Ferie: tutte le rimanenti che non sono delle altre classi.
In particolare, nei sabati di IV classe si può dire la Messa di Santa Maria in sabato.
Nello svolgersi simultaneo dei cicli temporale e santorale avviene talvolta che due o più giorni liturgici ricorrono contemporaneamente. Questo fatto è denominato occorrenza.
Quando si verifica ciò, il giorno liturgico di classe superiore ha la prevalenza su quello di classe inferiore. Quest'ultimo è omesso, commemorato o trasferito, a seconda del caso.
Soltanto le feste di I classe possono essere trasferite in un altro giorno.
Le domeniche di I classe hanno la prevalenza su tutte le feste, eccetto la festa dell'Immacolata Concezione.
Le domeniche di II classe hanno la prevalenza sulle feste di II classe. Però le feste di I o II classe di Nostro Signore che ricorrono in domenica, vengono celebrate in luogo della domenica stessa, con ogni diritto e privilegio.
Le feste di III classe non sono mai celebrate in Quaresima.
 Armadietto degli Oli Santi o Tabernacolo degli Oli Santi.
Armadietto degli Oli Santi o Tabernacolo degli Oli Santi. E' un piccolo mobile a muro o appeso presso l'altare maggiore, nel Battistero o nella Sacrestia, utilizzato per conservare gli Oli Santi. Gli Oli Santi sono tre, Santo Crisma, Olio dei catecumeni e Olio degli infermi e sono consacrati dal Vescovo; in particolare la consacrazione del Santo Crisma e la benedizione dell'Olio dei catecumeni e dell'Olio degli infermi vengono fatte il Giovedì Santo nella Messa Crismale. Si tenga presente che il Crisma è il più importante dei tre Oli Santi e, dopo la Messa Crismale, viene distribuito (insieme agli altri due Oli) ad ogni parrocchia per l'amministrazione dei Sacramenti e Sacramentali non riservati al Vescovo (ad esempio nel Battesimo o nell'Unzione degli infermi); i Vescovi lo usano per l'amministrazione dei Sacramenti e Sacramentali ad essi riservati (Cresima o Confermazione ed Ordine Sacro), nella dedicazione e consacrazione di una Chiesa per ungere le pareti e gli altari, e nella benedizione dei Vasi Sacri (Calice e Patena) usati per la celebrazione dell'Eucarestia. Nelle parrocchie i tre Oli Santi (Crisma, Olio dei catecumeni e Olio degli infermi) vengono di solito custoditi in un'apposita sede chiamata appunto "armadietto degli Oli Santi" o "tabernacolo degli Oli Santi". Sullo sportello, che deve rimanere chiuso a chiave, compare talora la scritta Olea Sancta.


 Arredi Sacri.
Arredi Sacri. Sono gli oggetti che vengono usati dalla Chiesa Cattolica per il Culto Divino, specialmente quelli che più strettamente si riferiscono alla S.ma Eucaristia; servono sia per la persona del sacerdote (paramenti sacri), sia per la confezione e conservazione del S.mo Sacramento (Vasi Sacri), sia anche per ornare l'altare e la chiesa dove si celebra.
A titolo esemplificativo, di seguito ne sono riportati alcuni:
 Abito talare |
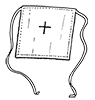 Amitto |
 Alba o Camice |
 Cingolo |
 Stola |
 Manipolo |
 Pianeta |
 Casula |
 Piviale |
 Cotta |
 Dalmatica |
 Tunicella |
 Berretta |
 Velo omerale o Continenza |
 Altare maggiore |
 Tovaglia copri altare |
 Pisside |
 Calice |
 Purificatoio |
 Patena |
 Palla (Animetta) |
 Velo del Calice |
 Borsa |
 Corporale |
 Croce d'altare |
 Tabernacolo |
 Lampada del Santissimo Sacramento |
 Ampolline (vino e acqua per infusione e abluzione) |
 Brocca con catino (per lavabo) |
 Manutergio |
 Piattino per Comunione |
 Ostensorio |
 Tronetto per esposizione Eucaristica |
 Reliquiario |
 Campanello |
 Incenso |
 Navicella porta incenso |
 Turibolo |
 Secchiello Acqua Benedetta |
 Aspersorio |
 Asta accendi-spegni candele |
 Candeliere |
 Candelabro |
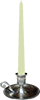 Bugia |
 Carte-gloria |
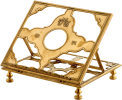 Leggio |
 Missale Romanum 1962 |
 Oli Santi |
 Conchiglia Battesimo con Saliera e Oli Santi |
|
 Bastone Pastorale o Vincastro |
 Lanterna per processione |
 Insegna priorale (di confraternita) |
 Aspersione o Asperges.
Aspersione o Asperges. E' il termine col quale durante la liturgia nella Forma Straordinaria del Rito Romano viene chiamato il rito dell'aspersione con acqua benedetta prima della Santa Messa (solo nelle Messe della domenica cantate o solenni). Prende il suo nome dalla prima parola dell'antifona, tratta dal Salmo 50, che viene cantata (al di fuori del tempo pasquale, ove viene sostituita dal "Vidi Aquam") durante tale rito per ricordare ai cristiani la santità del loro battesimo:
Aspèrges me, * Dòmine, hyssòpo et mundàbor: lavàbis me, et super nivem dealbàbor. *** Aspergimi, Signore, con l'issopo e sarò purificato; làvami e diverrò più bianco della neve.

 Aspersorio.
Aspersorio. E' detto anche "Asperges" dal vocabolo iniziale dell'antifona in latino che durante la liturgia nella Forma Straordinaria del Rito Romano viene cantata durante il rito dell'aspersione prima della Messa.
E' l'oggetto usato per aspergere i fedeli con l'acqua benedetta, per ricordare ai cristiani la santità del loro battesimo. E' corredato solitamente di un opportuno secchiello per contenere l'acqua benedetta.


 Asta accendi-spegni candele (o accenditoio-spegnitoio).
Asta accendi-spegni candele (o accenditoio-spegnitoio). Si tratta di un oggetto dottato di serbatoio a cera liquida che alimenta uno stoppino utile per accendere le candele d'altare, e dottato inoltre di un opportuno cappuccio utile per spegnere le candele. Tale oggetto è fissato all'estremità di un'asta in metallo (spesso regolabile in lunghezza) ed è usato da colui che è incaricato alla cura dell'altare prima e dopo ogni funzione liturgica.


 Asterisco.
Asterisco. Piccolo oggetto di metallo dorato, costituito da lamine incrociate, che si colloca sull'ostia, deposta nella patena, nelle liturgie papali.
Nella Messa Papale antica, l'asterisco veniva utilizzato per evitare che l’ostia venisse accidentalmente a contatto con il velo omerale indossato dal suddiacono.
Oggi viene utilizzato, nelle Messe celebrate dal Papa all'aperto, per tenere ferma l'ostia sulla patena.

 Autentica.
Autentica. E' un attestato in cui si certifica l'autenticità di una reliquia. Sull'autentica venivano riportate varie informazioni, come le caratteristiche fisiche delle reliquie e la qualità della teca destinata a custodirle. Potevano essere rilasciate dall'Ordinario diocesano, dal Postulatore delle cause dei Santi o dal Sacrista del Palazzo apostolico se queste erano custodite nel sacrario della sacrestia papale. Attualmente, in luogo del Sacrista, è il Maestro delle celebrazioni liturgiche che firma l'autentica.
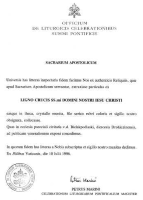
B
 Balaustra.
Balaustra.
La balaustra è l'elemento architettonico presente praticamente in tutte le chiese costruite prima della riforma liturgica che, ideato per favorire la distribuzione della Comunione in ginocchio senza nel contempo impedire la vista dell'altare, ha nel tempo svolto anche la funzione di delimitare l'area del presbiterio dalla navata, ossia di delimitare l'area sacra dei ministri sacri dall'area dei fedeli. Questo elemento è possibile osservarlo sia in prossimità dell'altare maggiore sia in prossimità degli altari minori nelle capelle laterali.

 Baldacchino.
Baldacchino.
E' un telo di tessuto di colore variabile che può essere rigido (cioè fissato ad una tavola di legno) o morbido (ovvero senza essere fissato), sorretto da quattro o sei aste in legno o metallo e fornito di quattro mantovane che scendono dai quattro lati. Il baldacchino è usato attualmente per le processioni eucaristiche, ma è previsto anche per accompagnare il Santo Padre nelle processioni all'interno della basilica vaticana o anche, come attestato da diverse fonti fotografiche, per la benedizione Urbi et Orbi alla balconata centrale della basilica. Il baldacchino è principalmente di colore bianco o oro, ma, in caso si portasse la reliquia della Santa Croce, può essere di colore rosso. Nell'uso ambrosiano è rosso in qualunque caso. Il tessuto del baldacchino di solito è solennemente ornato, soprattutto nella volta, in cui si trovano i ricami più preziosi di emblemi eucaristici ma anche dello Spirito Santo.



 Bastone pastorale (detto anche vincastro).
Bastone pastorale (detto anche vincastro).
Il pastorale (o vincastro) è una sorta di bastone dall'estremità spesso decorata e ricurva a simboleggiare il "raduno degli erranti" e che termina in basso con una punta perché "il pastore deve pungere i pigri e difendere i deboli", usato dal vescovo nei pontificali e nelle cerimonie più solenni.
Questo bastone simboleggia la funzione di cura della fede e della morale che l'ufficio episcopale ha sopra la porzione di popolo cristiano a lui affidata, e rimanda direttamente al Vangelo secondo Giovanni nel quale Cristo si autodefinisce "Buon Pastore". Poichè richiama il legame forte tra il pastore ed il suo popolo, il vescovo può usare il pastorale solo all'interno dei confini della propria diocesi, ossia nei confronti dei suoi fedeli, e non all'episcopato in genere (come è, invece, il caso delle altre insegne episcopali, anello, croce pettorale, mitria, che si portano sempre). I Vescovi che celebrano al di fuori della loro diocesi ed i Vescovi titolari possono usare il bastone pastorale solo col consenso dell'Ordinario del luogo.
Oltre ai Vescovi, anche i Cardinali (compresi quelli che hanno ottenuto dal Santo Padre la dispensa dall'ordinazione episcopale) fanno uso del bastone pastorale, senza dover sottostare ad alcun limite di confine, eccettuato il territorio della diocesi di Roma per via del solito principio secondo il quale è neccessario il consenso dell'Ordinario del luogo (in questo caso il Papa).
Il privilegio del pastorale è riservato anche agli abati di una comunità monastica.

Dal Pontificale Romano.
Consegna del pastorale.
Il Consacrante principale consegna il pastorale nelle mani dell'eletto con queste parole:
"Accipe baculum, pastoralis muneris signum, et attende universo gregi, in quo te Spiritus Sanctus posuit Episcopum regere Ecclesiam Dei." *** "Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore: abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come Vescovo a reggere la Chiesa di Dio."
 Battesimo.
Battesimo.
Il Battesimo è il Sacramento attraverso cui una persona entra a far parte della Chiesa di Gesù Cristo. Il Battesimo apre l'accesso agli altri sacramenti, esso è il primo dei sette sacramenti della Chiesa Cattolica che, insieme alla Confessione, alla Comunione ed alla Cresima, costituiscono l'iniziazione cristiana. Il Battesimo simboleggia il seppellimento dell'uomo "vecchio" nella morte di Cristo per la rinascita dell'uomo nuovo in Cristo.
Il sacramento del Battesimo opera la remissione dei peccati (originale e personali) e la nascita alla vita nuova, mediante la quale il battezzato diventa figlio adottivo di Dio, fratello di Cristo e coerede con Lui della gloria divina, dimora dello Spirito Santo, membro della Chiesa e partecipe del sacerdozio di Cristo, così da poter rendere a Dio il culto della perfetta adorazione. Secondo la volontà di Cristo, il Battesimo è necessario per la salvezza, come è necessaria la Chiesa, alla quale esso introduce; alla sua mancanza possono supplire la morte subita a causa della fede (Battesimo di sangue) o il Battesimo di desiderio, come può accadere nei catecumeni, che muoiono prima di ricevere il Battesimo, e in tutti gli uomini che, per divina grazia, cercano sinceramente Dio, senza conoscere la Chiesa, e si sforzano di essere a lui graditi. Però soltanto il sacramento del Battesimo imprime un sigillo spirituale indelebile, il carattere, e non può essere ripetuto. In caso di emergenza tutti possono battezzare utilizzando la formula battesimale trinitaria, perché il Battesimo è necessario alla salvezza, purchè chi battezza lo faccia nella fede della Chiesa, ossia abbia l'intenzione di fare quanto fa la Chiesa.
Materia fondamentale del Battesimo è l’acqua; il Battesimo può essere impartito per immersione (totale, rito più comune nell’antichità; parziale, nel rito ambrosiano), o per infusione (versando l’acqua sul battezzando), o per aspersione. In ogni caso, l’acqua deve bagnare il corpo del battezzando, tutto o in parte. L'abluzione con l'acqua è accompagnata dalla formula battesimale trinitaria «Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo», derivata dal precetto di Gesù agli apostoli. Tale formula è indispensabile alla validità.
Secondo la Chiesa Cattolica, i ministri ordinari del Battesimo sono il Vescovo e il Presbitero. Ma, in caso di necessità, chiunque può battezzare secondo quanto detto precedentemente. Nel caso del Battesimo dei bambini, i candidati designano o ricevono la designazione di uno o due padrini (o madrine): questi hanno la funzione di accompagnare i primi passi del nuovo battezzato, e soprattutto per i bambini piccoli di aiutare i genitori nell'educazione cristiana del battezzato.
Il Concilio di Trento stabilì che ogni parrocchia avesse il proprio fonte battesimale e si sollecitò l'amministrazione del sacramento ai bambini entro gli otto giorni dalla nascita.
Il rito del Battesimo, codificato nel Rituale Romano, sostanzialmente è strutturato nel modo seguente:



 Battistero o fonte battesimale.
Battistero o fonte battesimale.
In passato era il luogo, separato dall'edificio sacro, atto alla celebrazione del battesimo. Il termine "battistero" indica altresì la vasca marmorea (ma talvolta anche in metallo), meglio nota come fonte battesimale, in cui viene raccolta l'acqua per il battesimo. Il fonte battesimale è solitamente sormontato da una copertura metallica a cupola.





 Benedizione.
Benedizione.
La benedizione è un'invocazione della grazia e del favore divino su qualcuno o qualcosa. Come indica la parola, consiste in un'invocazione di bene a favore di persone o cose.
Nella religione cristiana la benedizione è una formula rituale con cui il sacerdote invoca la protezione e la grazia divina da esercitare su persone o cose; sia chiaro che è Dio che elargisce la sua benedizione servendosi della persona del sacerdote che a sua volta agisce attraverso formule verbali spesso accompagnate da opportune azioni o gesti. In questo modo l'uomo può essere "di benedizione" per altri.
Nel cattolicesimo esistono varie tipologie di benedizioni utilizzate per diversi momenti della vita od in relazione a diversi tipi di oggetti o beni, sacri o per uso profano. Le formule di benedizione, unitamente a stralci della Bibbia e preghiere appropriate sono generalmente raccolte in un rituale noto come Rituale Romanum.
Di particolare rilievo sono la:

 Berretta clericale (tricorno), berretta cardinalizia e berretta papale.
Berretta clericale (tricorno), berretta cardinalizia e berretta papale.
La berretta è un copricapo degli ecclesiastici la cui forma, il tessutto ed il colore dipendono dal privileggio ecclesiastico. Questo cappello ha forma quadrata ed è munito di tre alette rigide (dette anche spicchi, punte, corni) e presenta alla sommità un fiocco o un cordone.
Come già detto, le peculiarità di questo copricapo dipendono dalla dignità ecclesiastica di chi lo indossa; gli ecclesiastici dei gradi gerarchici inferiori al rango cardinalizio usano la berretta clericale o tricorno, con il fiocco.
La berretta fa parte dell'insieme di abiti e insegne ecclesiastiche del Clero e anche se, purtroppo, il suo utilizzo nei tempi attuali è divenuto un po' raro, è possibile utilizzare ampiamente questo copricapo ecclesiastico, poichè l'uso non è stato mai abolito. Essa è indossata in modo tale che un'aletta punti sulla fronte, una verso la destra e una sul retro della testa; è usata dal celebrante, diacono e suddiacono per andare e venire dall'altare ed è portata anche dai chierici. Ancor oggi può essere usata come copricapo ordinario durante le mansioni ordinarie fuori dalla liturgia, all'esterno della chiesa, nelle processioni e nelle funzioni sacre all'aperto, ma anche durante l'azione liturgica (ad esempio per andare e venire dall'altare e durante l'omelia).
Tuttavia anche per i cardinali ed il Papa esiste una berretta, senza fiocco e dotata alla sommità di un cordone; quella dei cardinali è detta "Berretta Cardinalizia", poi esiste una "Berretta Papale" il cui uso risale a Papa San Giovanni XXIII durante le sue passeggiate private.



Di seguito riportiamo alcuni esempi di utilizzo della berretta:







 Berretta cardinalizia.
Berretta cardinalizia.
Copricapo simile alla berretta dei prelati di grado ecclesiastico inferiore a quello cardinalizio, ma priva di fiocco e munito alla sommità di un cordoncino, che il Santo Padre consegna ai neo-cardinali con l'anello.
La berretta cardinalizia poteva essere anticamente consegnata anche dal capo di stato della nazione di cui il neo-cardinale era Nunzio apostolico.
Attualmente, in alternativa alla consegna effettuata dal Pontefice, può essere consegnata dal Decano o da un altro cardinale su mandato del Santo Padre.
La berretta cardinalizia è confezionata in seta moirè ed è di color porpora. Questo copricapo ecclesiastico non può essere chiamato tricorno in quanto questo sostantivo è attribuibile ai soli copricapi ecclesiastici degli ordini inferiori a quello di Cardinale (chierici, suddiaconi, diaconi, presbiteri, vescovi, ecc.).

 Bibbia.
Bibbia.
La Bibbia è il testo sacro della religione ebraica e di quella cristiana, ossia una raccolta di libri sacri considerati testimonianza della rivelazione di Dio all'uomo. In particolare, la Bibbia Cristiana Cattolica comprende l'Antico Testamento (o Vecchia Alleanza), i cui testi sono stati scritti prima del "ministero" di Gesù ed il Nuovo Testamento (o Nuova Alleanza) che descrive l'avvento del Messia, cioè la parte relativa a Gesù e alla nascente Chiesa apostolica. La parola "Testamento" presa singolarmente significa "patto", un'espressione utilizzata dai cristiani per indicare il patto, ossia l'"alleanza", stabilito da Dio con gli uomini per mezzo di Gesù e del suo messaggio.
Esiste differenza tra Bibbia ebraica e Bibbia cattolica, a questo proposito si parla di Bibbia secondo il canone ebraico e Bibbia secondo il canone cattolico. Sostanzialmente la differenza sta nei libri che si vogliono considerare essere parte integrante di essa. Ma, una caratteristica comune ad ambedue i canoni è rappresentato senza dubbio dal valore che hanno tutti i libri contenuti in esse, ossia l'ispirazione divina, cioè la partecipazione di Dio alla loro redazione.
Secondo il canone ebraico la Bibbia (ebraica) è formata di 39 libri, scritti tutti prima di Cristo. Tradizionalmente è suddivisa in tre grandi sezioni:
- La Torah o Legge (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio);
- I Profeti detti anteriori (Giosuè, Giudici, 1-2 Samuele, e 1-2 Re) ed i Profeti posteriori (Isaia, Geremia, Ezechiele ed i dodici profeti "minori" da Osea a Malachia);
- Gli Scritti (Salmi, Proverbi, Giobbe, Cantico dei Cantici, Rut, Lamentazioni, Qohelet, Ester, Daniele, Esdra, Neemia, 1-2 Cronache).
Mentre, secondo il canone cattolico, la Bibbia (cattolica) riprende quella ebraica, aggiungendo alcuni libri all'Antico Testamento e completando la storia salvifica con gli scritti redatti nel I sec. d.C., ossia il Nuovo Testamento. La Chiesa Cattolica, complessivamente, conta 73 libri.
La prima parte della Bibbia cristiana, l'Antico Testamento, comprende 46 libri, suddivisi in quattro sezioni:
- Il Pentateuco corrispondente alla Torah della Bibbia ebraica;
- I libri storici, corrispondenti ai Profeti anteriori con l'aggiunta di Rut, 1-2 Cronache, Esdra, Neemia, Tobia, Giuditta, Ester e 1-2 Maccabei;
- I libri sapienziali (Giobbe, Salmi, Proverbi, Qohelet, Cantico dei Cantici, Sapienza, e Siracide);
- I libri profetici, corrispondenti ai Profeti posteriori della Bibbia ebraica, con l'aggiunta di Baruc e parti del libro di Daniele.
La seconda parte della Bibbia cristiana, il Nuovo Testamento, comprende 27 libri suddivisi tra Vangeli canonici (S.Marco, S.Matteo, S.Luca e S.Giovanni, i primi tre sono detti sinottici perchè molto somiglianti), Atti degli Apostoli (attribuiti generalmente all'Evangelista Luca), Lettere (S.Paolo, S.Pietro, S.Giovanni, S.Giacomo e S.Giuda Taddeo) e l'Apocalisse o Rivelazione.

 Borsa.
Borsa.
E' un oggetto liturgico cattolico di forma quadrata che serve per custodire il corporale.
La borsa è composta di due quadrati di cartone uniti ed aperti da un lato, proprio per contenere il corporale, inoltre è rivestita di tessuto dello stesso colore dei paramenti liturgici, ossia del colore liturgico del giorno. Essa può essere arricchita da ricami e decorazioni; spesso il tessuto, i ricami e le decorazioni si accostano a quelli dei paramenti liturgici di uno stesso completo. La parte interna è rivestita di lino o tessuto leggero.
La borsa è utilizzata per contenere il corporale, anche quando si deve distribuire la Comunione fuori dalla Messa, come ad esempio per portare la Comunione agli infermi, anche se in questo caso di solito è rotonda e più rigida per poter essere appesa al collo e per contenere anche la pisside.
La borsa fu introdotta dopo che vennero ridotte le dimensioni del corporale: infatti fino alle celebrazioni medioevali, quest'ultimo veniva custodito in apposite scatole di legno, perché era molto più grande di quello odierno. L'uso della borsa viene fatto risalire all'XI secolo, in applicazione di quanto stabilito nel Concilio di Reims.

 Breviario Romano *** Breviarium Romanum.
Breviario Romano *** Breviarium Romanum.
Il Breviarium Romanum (Breviario Romano) è un libro liturgico che contiene l'Ufficio Divino della Chiesa Cattolica, in altre parole in esso è codificata la Preghiera Liturgica che tutti i sacerdoti debbono recitare ogni giorno (Mattutino, Lodi, Ora Prima, Ora Terza, Ora Sesta e Ora Nona (rispettivamente alle ore 6:00, 9:00, 12:00 e 15:00 della giornata), Vespri e Compieta).
La Chiesa invita lodevolmente anche i fedeli laici alla recita del Breviario; infatti esso ha lo scopo di aiutare il Cristiano a vivere in Cristo la giornata, santificandone i vari momenti. Viene recitato sia nei luoghi di culto, in modo comunitario, sia in modo personale nelle proprie case. La Preghiera Liturgica trae la sua origine dal precetto di Gesù di pregare senza interruzione.
Il Breviarium Romanum ha una articolazione molto simile a quella del Missale Romanum; è composto da un Ordinario, che comprende le parti fisse che si recitano uguali ogni giorno, il Proprio del Tempo, che comprende le parti variabili che dipendono dal tempo liturgico, il Proprio dei Santi, che comprende le parti variabili in funzione delle singole feste dei santi, il Comune dei Santi, che comprende le parti variabili relative alle feste dei santi, ma che non si trovano nel Proprio dei Santi e sono accorpate per classi omogenee di santi, infine il Salterio che comprende il ciclo dei 150 salmi che si ripete identico ogni settimana.

 Brocca con catino (per lavabo).
Brocca con catino (per lavabo).
È un'anfora di metallo munita di un opportuno catino che si usa per portare all'altare l’acqua che serve a lavare le mani del sacerdote (abluzione o purificazione) quando durante la Santa Messa, all’Offertorio, il sacerdote deve purificare le mani prima di toccare le Sacre Specie dell'Eucaristia.


 Bugia.
Bugia.
E' un oggetto di argento o altro metallo che sorregge una candela. Serviva inizialmente per necessità pratiche nelle chiese in cui non ci fosse sufficiente luce per leggere. Nel corso dei secoli è divenuta un'insegna episcopale estesa anche ad alcuni prelati privilegiati (Vicari, ai Prefetti apostolici, ai Chierici della Camera apostolica, ai Prelati domestici ed ai Canonici dei Capitoli che godono di questo privilegio).
Si usa ogni volta che il prelato legge, eccetto al Venerdì Santo. Non si può usare in presenza di un altro prelato di grado superiore o per far luce al lettore o per la distribuzione della Comunione.
Nei pontificali la bugia era retta da un porta insegne che poteva, sopra la cotta, indossare il piviale del colore liturgico del giorno. Il chierico si pone sempre accanto al chierico porta libro ogni qual volta che questo si avvicina al Vescovo.

 Balaustra.
Balaustra. La balaustra è l'elemento architettonico presente praticamente in tutte le chiese costruite prima della riforma liturgica che, ideato per favorire la distribuzione della Comunione in ginocchio senza nel contempo impedire la vista dell'altare, ha nel tempo svolto anche la funzione di delimitare l'area del presbiterio dalla navata, ossia di delimitare l'area sacra dei ministri sacri dall'area dei fedeli. Questo elemento è possibile osservarlo sia in prossimità dell'altare maggiore sia in prossimità degli altari minori nelle capelle laterali.

 Baldacchino.
Baldacchino. E' un telo di tessuto di colore variabile che può essere rigido (cioè fissato ad una tavola di legno) o morbido (ovvero senza essere fissato), sorretto da quattro o sei aste in legno o metallo e fornito di quattro mantovane che scendono dai quattro lati. Il baldacchino è usato attualmente per le processioni eucaristiche, ma è previsto anche per accompagnare il Santo Padre nelle processioni all'interno della basilica vaticana o anche, come attestato da diverse fonti fotografiche, per la benedizione Urbi et Orbi alla balconata centrale della basilica. Il baldacchino è principalmente di colore bianco o oro, ma, in caso si portasse la reliquia della Santa Croce, può essere di colore rosso. Nell'uso ambrosiano è rosso in qualunque caso. Il tessuto del baldacchino di solito è solennemente ornato, soprattutto nella volta, in cui si trovano i ricami più preziosi di emblemi eucaristici ma anche dello Spirito Santo.



 Bastone pastorale (detto anche vincastro).
Bastone pastorale (detto anche vincastro). Il pastorale (o vincastro) è una sorta di bastone dall'estremità spesso decorata e ricurva a simboleggiare il "raduno degli erranti" e che termina in basso con una punta perché "il pastore deve pungere i pigri e difendere i deboli", usato dal vescovo nei pontificali e nelle cerimonie più solenni.
Questo bastone simboleggia la funzione di cura della fede e della morale che l'ufficio episcopale ha sopra la porzione di popolo cristiano a lui affidata, e rimanda direttamente al Vangelo secondo Giovanni nel quale Cristo si autodefinisce "Buon Pastore". Poichè richiama il legame forte tra il pastore ed il suo popolo, il vescovo può usare il pastorale solo all'interno dei confini della propria diocesi, ossia nei confronti dei suoi fedeli, e non all'episcopato in genere (come è, invece, il caso delle altre insegne episcopali, anello, croce pettorale, mitria, che si portano sempre). I Vescovi che celebrano al di fuori della loro diocesi ed i Vescovi titolari possono usare il bastone pastorale solo col consenso dell'Ordinario del luogo.
Oltre ai Vescovi, anche i Cardinali (compresi quelli che hanno ottenuto dal Santo Padre la dispensa dall'ordinazione episcopale) fanno uso del bastone pastorale, senza dover sottostare ad alcun limite di confine, eccettuato il territorio della diocesi di Roma per via del solito principio secondo il quale è neccessario il consenso dell'Ordinario del luogo (in questo caso il Papa).
Il privilegio del pastorale è riservato anche agli abati di una comunità monastica.

Dal Pontificale Romano.
Consegna del pastorale.
Il Consacrante principale consegna il pastorale nelle mani dell'eletto con queste parole:
"Accipe baculum, pastoralis muneris signum, et attende universo gregi, in quo te Spiritus Sanctus posuit Episcopum regere Ecclesiam Dei." *** "Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore: abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come Vescovo a reggere la Chiesa di Dio."
 Battesimo.
Battesimo. Il Battesimo è il Sacramento attraverso cui una persona entra a far parte della Chiesa di Gesù Cristo. Il Battesimo apre l'accesso agli altri sacramenti, esso è il primo dei sette sacramenti della Chiesa Cattolica che, insieme alla Confessione, alla Comunione ed alla Cresima, costituiscono l'iniziazione cristiana. Il Battesimo simboleggia il seppellimento dell'uomo "vecchio" nella morte di Cristo per la rinascita dell'uomo nuovo in Cristo.
Il sacramento del Battesimo opera la remissione dei peccati (originale e personali) e la nascita alla vita nuova, mediante la quale il battezzato diventa figlio adottivo di Dio, fratello di Cristo e coerede con Lui della gloria divina, dimora dello Spirito Santo, membro della Chiesa e partecipe del sacerdozio di Cristo, così da poter rendere a Dio il culto della perfetta adorazione. Secondo la volontà di Cristo, il Battesimo è necessario per la salvezza, come è necessaria la Chiesa, alla quale esso introduce; alla sua mancanza possono supplire la morte subita a causa della fede (Battesimo di sangue) o il Battesimo di desiderio, come può accadere nei catecumeni, che muoiono prima di ricevere il Battesimo, e in tutti gli uomini che, per divina grazia, cercano sinceramente Dio, senza conoscere la Chiesa, e si sforzano di essere a lui graditi. Però soltanto il sacramento del Battesimo imprime un sigillo spirituale indelebile, il carattere, e non può essere ripetuto. In caso di emergenza tutti possono battezzare utilizzando la formula battesimale trinitaria, perché il Battesimo è necessario alla salvezza, purchè chi battezza lo faccia nella fede della Chiesa, ossia abbia l'intenzione di fare quanto fa la Chiesa.
Materia fondamentale del Battesimo è l’acqua; il Battesimo può essere impartito per immersione (totale, rito più comune nell’antichità; parziale, nel rito ambrosiano), o per infusione (versando l’acqua sul battezzando), o per aspersione. In ogni caso, l’acqua deve bagnare il corpo del battezzando, tutto o in parte. L'abluzione con l'acqua è accompagnata dalla formula battesimale trinitaria «Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo», derivata dal precetto di Gesù agli apostoli. Tale formula è indispensabile alla validità.
Secondo la Chiesa Cattolica, i ministri ordinari del Battesimo sono il Vescovo e il Presbitero. Ma, in caso di necessità, chiunque può battezzare secondo quanto detto precedentemente. Nel caso del Battesimo dei bambini, i candidati designano o ricevono la designazione di uno o due padrini (o madrine): questi hanno la funzione di accompagnare i primi passi del nuovo battezzato, e soprattutto per i bambini piccoli di aiutare i genitori nell'educazione cristiana del battezzato.
Il Concilio di Trento stabilì che ogni parrocchia avesse il proprio fonte battesimale e si sollecitò l'amministrazione del sacramento ai bambini entro gli otto giorni dalla nascita.
Il rito del Battesimo, codificato nel Rituale Romano, sostanzialmente è strutturato nel modo seguente:
-
LE DOMANDE - GLI ESORCISMI.
Il sacerdote interroga il bimbo ed il Padrino risponde alle domande, il sacerdote conclude recitando una formula; seguono queste azioni, formule e orazioni da parte del sacerdote: il sacerdote soffia leggermente tre volte sulla faccia del bimbo e recita una formula; il sacerdote col pollice fa il segno di croce sulla fronte e sul petto del bimbo e recita una formula ed una orazione; il sacerdote pone la mano sul capo del bimbo e recita una orazione; il sacerdote mette un po' di sale benedetto sulle labbra del bimbo e recita alcune formule con una orazione; il sacerdote col pollice fa un segno di croce sulla fronte del bimbo e recita una formula; il sacerdote pone la mano sul capo del bimbo e recita una orazione; il sacerdote pone un lembo della stola sul bimbo e l'introduce in chiesa dicendo una formula. -
PROFESSIONE DI FEDE - RINUNZIA A satana.
Entrati in chiesa, il sacerdote ed il Padrino, recandosi verso il fonte battesimale, recitano insieme ad alta voce il Credo ed il Padre Nostro; prima di entrare nel battistero, il sacerdote dice l'Esorcismo; il sacerdote misticamente ripetendo il gesto miracoloso di Gesù Cristo che guarì il sordomuto, tocca l'orecchio destro poi quello sinistro del bimbo e recita una formula, poi tocca le narici del bimbo e soggiunge una formula; il sacerdote interroga nominatamente il bimbo, mentre il Padrino risponde per lui con la triplice rinuncia a satana; il sacerdote con l'Olio dei catecumeni fa una sacra unzione in forma di croce sul petto e tra le scapole del bimbo e recita una formula; il sacerdote deterge le parti toccate e, deposta la stola violacea, ne mette una bianca. -
INCORPORAZIONE AL CRISTO.
Il sacerdote interroga nominatamente il bimbo entro il battistero e il Padrino risponde per lui con il triplice Credo alle domande del sacerdote sulla professione di fede, infine il sacerdote domanda al bimbo se vuole essere battezzato ed il Padrino risponde "sì, lo voglio"; mentre il Padrino e la Madrina tengono il bimbo, il sacerdote gli versa sul capo l'acqua battesimale a tre riprese in forma di croce, accompagnando tale azione con le parole «N., io ti battezzo nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo»; il sacerdote, col Sacro Crisma, fa una sacra unzione in forma di croce sul capo del bimbo e recita alcune formule; il sacerdote deterge la parte toccata e poi dà al bimbo la candida veste recitando una formula; infine il sacerdote consegna al bimbo od al Padrino la candela accesa e conclude il rito con le opportune formule finali.



 Battistero o fonte battesimale.
Battistero o fonte battesimale. In passato era il luogo, separato dall'edificio sacro, atto alla celebrazione del battesimo. Il termine "battistero" indica altresì la vasca marmorea (ma talvolta anche in metallo), meglio nota come fonte battesimale, in cui viene raccolta l'acqua per il battesimo. Il fonte battesimale è solitamente sormontato da una copertura metallica a cupola.





 Benedizione.
Benedizione. La benedizione è un'invocazione della grazia e del favore divino su qualcuno o qualcosa. Come indica la parola, consiste in un'invocazione di bene a favore di persone o cose.
Nella religione cristiana la benedizione è una formula rituale con cui il sacerdote invoca la protezione e la grazia divina da esercitare su persone o cose; sia chiaro che è Dio che elargisce la sua benedizione servendosi della persona del sacerdote che a sua volta agisce attraverso formule verbali spesso accompagnate da opportune azioni o gesti. In questo modo l'uomo può essere "di benedizione" per altri.
Nel cattolicesimo esistono varie tipologie di benedizioni utilizzate per diversi momenti della vita od in relazione a diversi tipi di oggetti o beni, sacri o per uso profano. Le formule di benedizione, unitamente a stralci della Bibbia e preghiere appropriate sono generalmente raccolte in un rituale noto come Rituale Romanum.
Di particolare rilievo sono la:
- Benedizione eucaristica che avviene utilizzando una particola consacrata custodita generalmente in un ostensorio con il quale si traccia il segno della croce sui fedeli presenti;
- Benedizione Urbi et Orbi che viene impartita dal Sommo Pontefice in particolari occasioni come Natale o Pasqua;
- Benedizione solenne impartita al termine delle celebrazioni più importanti dell'anno liturgico.


 Berretta clericale (tricorno), berretta cardinalizia e berretta papale.
Berretta clericale (tricorno), berretta cardinalizia e berretta papale. La berretta è un copricapo degli ecclesiastici la cui forma, il tessutto ed il colore dipendono dal privileggio ecclesiastico. Questo cappello ha forma quadrata ed è munito di tre alette rigide (dette anche spicchi, punte, corni) e presenta alla sommità un fiocco o un cordone.
Come già detto, le peculiarità di questo copricapo dipendono dalla dignità ecclesiastica di chi lo indossa; gli ecclesiastici dei gradi gerarchici inferiori al rango cardinalizio usano la berretta clericale o tricorno, con il fiocco.
La berretta fa parte dell'insieme di abiti e insegne ecclesiastiche del Clero e anche se, purtroppo, il suo utilizzo nei tempi attuali è divenuto un po' raro, è possibile utilizzare ampiamente questo copricapo ecclesiastico, poichè l'uso non è stato mai abolito. Essa è indossata in modo tale che un'aletta punti sulla fronte, una verso la destra e una sul retro della testa; è usata dal celebrante, diacono e suddiacono per andare e venire dall'altare ed è portata anche dai chierici. Ancor oggi può essere usata come copricapo ordinario durante le mansioni ordinarie fuori dalla liturgia, all'esterno della chiesa, nelle processioni e nelle funzioni sacre all'aperto, ma anche durante l'azione liturgica (ad esempio per andare e venire dall'altare e durante l'omelia).
Tuttavia anche per i cardinali ed il Papa esiste una berretta, senza fiocco e dotata alla sommità di un cordone; quella dei cardinali è detta "Berretta Cardinalizia", poi esiste una "Berretta Papale" il cui uso risale a Papa San Giovanni XXIII durante le sue passeggiate private.



Di seguito riportiamo alcuni esempi di utilizzo della berretta:
- Berretta nera con fiocco nero: Presbiteri, Diaconi, Suddiaconi, Chierici e Seminaristi, Cappellani di Sua Santità, Protonotari apostolici soprannumerari e Prelati d'onore di Sua Santità o Monsignori elevati dal Vescovo;
- Berretta nera con fiocco rosso: Canonici e Prelati con particolari incarichi ecclesiastici;
- Berretta nera con fiocco paonazzo: Presbiteri con titolo monsignorile o di Canonico del Capitolo cattedrale, Prelati con particolari incarichi ecclesiastici, Prelati superiori della Curia Romana e Protonotari apostolici numerari;
- Berretta bianca con fiocco: Abati;
- Berretta paonazza con fiocco paonazzo: Vescovi, Arcivescovi;
- Berretta paonazza con seta marezzata (moirè) e fiocco paonazzo: Nunzi apostolici, ossia Vescovi con incarico di nunziatura apostolica;
- Berretta rossa con seta marezzata (moirè) e fiocco: Patriarca di Venezia e di Lisbona se non sono cardinali;
- Berretta rossa marezzata (moirè) senza fiocco e munita di cordone (Berretta cardinalizia): Cardinali;
- Berretta bianca marezzata (moirè) senza fiocco e munita di cordone (Berretta Papale): Papa (il suo uso risale a Papa San Giovanni XXIII durante le sue passeggiate private).








 Berretta cardinalizia.
Berretta cardinalizia. Copricapo simile alla berretta dei prelati di grado ecclesiastico inferiore a quello cardinalizio, ma priva di fiocco e munito alla sommità di un cordoncino, che il Santo Padre consegna ai neo-cardinali con l'anello.
La berretta cardinalizia poteva essere anticamente consegnata anche dal capo di stato della nazione di cui il neo-cardinale era Nunzio apostolico.
Attualmente, in alternativa alla consegna effettuata dal Pontefice, può essere consegnata dal Decano o da un altro cardinale su mandato del Santo Padre.
La berretta cardinalizia è confezionata in seta moirè ed è di color porpora. Questo copricapo ecclesiastico non può essere chiamato tricorno in quanto questo sostantivo è attribuibile ai soli copricapi ecclesiastici degli ordini inferiori a quello di Cardinale (chierici, suddiaconi, diaconi, presbiteri, vescovi, ecc.).

 Bibbia.
Bibbia. La Bibbia è il testo sacro della religione ebraica e di quella cristiana, ossia una raccolta di libri sacri considerati testimonianza della rivelazione di Dio all'uomo. In particolare, la Bibbia Cristiana Cattolica comprende l'Antico Testamento (o Vecchia Alleanza), i cui testi sono stati scritti prima del "ministero" di Gesù ed il Nuovo Testamento (o Nuova Alleanza) che descrive l'avvento del Messia, cioè la parte relativa a Gesù e alla nascente Chiesa apostolica. La parola "Testamento" presa singolarmente significa "patto", un'espressione utilizzata dai cristiani per indicare il patto, ossia l'"alleanza", stabilito da Dio con gli uomini per mezzo di Gesù e del suo messaggio.
Esiste differenza tra Bibbia ebraica e Bibbia cattolica, a questo proposito si parla di Bibbia secondo il canone ebraico e Bibbia secondo il canone cattolico. Sostanzialmente la differenza sta nei libri che si vogliono considerare essere parte integrante di essa. Ma, una caratteristica comune ad ambedue i canoni è rappresentato senza dubbio dal valore che hanno tutti i libri contenuti in esse, ossia l'ispirazione divina, cioè la partecipazione di Dio alla loro redazione.
Secondo il canone ebraico la Bibbia (ebraica) è formata di 39 libri, scritti tutti prima di Cristo. Tradizionalmente è suddivisa in tre grandi sezioni:
- La Torah o Legge (Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio);
- I Profeti detti anteriori (Giosuè, Giudici, 1-2 Samuele, e 1-2 Re) ed i Profeti posteriori (Isaia, Geremia, Ezechiele ed i dodici profeti "minori" da Osea a Malachia);
- Gli Scritti (Salmi, Proverbi, Giobbe, Cantico dei Cantici, Rut, Lamentazioni, Qohelet, Ester, Daniele, Esdra, Neemia, 1-2 Cronache).
Mentre, secondo il canone cattolico, la Bibbia (cattolica) riprende quella ebraica, aggiungendo alcuni libri all'Antico Testamento e completando la storia salvifica con gli scritti redatti nel I sec. d.C., ossia il Nuovo Testamento. La Chiesa Cattolica, complessivamente, conta 73 libri.
La prima parte della Bibbia cristiana, l'Antico Testamento, comprende 46 libri, suddivisi in quattro sezioni:
- Il Pentateuco corrispondente alla Torah della Bibbia ebraica;
- I libri storici, corrispondenti ai Profeti anteriori con l'aggiunta di Rut, 1-2 Cronache, Esdra, Neemia, Tobia, Giuditta, Ester e 1-2 Maccabei;
- I libri sapienziali (Giobbe, Salmi, Proverbi, Qohelet, Cantico dei Cantici, Sapienza, e Siracide);
- I libri profetici, corrispondenti ai Profeti posteriori della Bibbia ebraica, con l'aggiunta di Baruc e parti del libro di Daniele.
La seconda parte della Bibbia cristiana, il Nuovo Testamento, comprende 27 libri suddivisi tra Vangeli canonici (S.Marco, S.Matteo, S.Luca e S.Giovanni, i primi tre sono detti sinottici perchè molto somiglianti), Atti degli Apostoli (attribuiti generalmente all'Evangelista Luca), Lettere (S.Paolo, S.Pietro, S.Giovanni, S.Giacomo e S.Giuda Taddeo) e l'Apocalisse o Rivelazione.

 Borsa.
Borsa. E' un oggetto liturgico cattolico di forma quadrata che serve per custodire il corporale.
La borsa è composta di due quadrati di cartone uniti ed aperti da un lato, proprio per contenere il corporale, inoltre è rivestita di tessuto dello stesso colore dei paramenti liturgici, ossia del colore liturgico del giorno. Essa può essere arricchita da ricami e decorazioni; spesso il tessuto, i ricami e le decorazioni si accostano a quelli dei paramenti liturgici di uno stesso completo. La parte interna è rivestita di lino o tessuto leggero.
La borsa è utilizzata per contenere il corporale, anche quando si deve distribuire la Comunione fuori dalla Messa, come ad esempio per portare la Comunione agli infermi, anche se in questo caso di solito è rotonda e più rigida per poter essere appesa al collo e per contenere anche la pisside.
La borsa fu introdotta dopo che vennero ridotte le dimensioni del corporale: infatti fino alle celebrazioni medioevali, quest'ultimo veniva custodito in apposite scatole di legno, perché era molto più grande di quello odierno. L'uso della borsa viene fatto risalire all'XI secolo, in applicazione di quanto stabilito nel Concilio di Reims.

 Breviario Romano *** Breviarium Romanum.
Breviario Romano *** Breviarium Romanum. Il Breviarium Romanum (Breviario Romano) è un libro liturgico che contiene l'Ufficio Divino della Chiesa Cattolica, in altre parole in esso è codificata la Preghiera Liturgica che tutti i sacerdoti debbono recitare ogni giorno (Mattutino, Lodi, Ora Prima, Ora Terza, Ora Sesta e Ora Nona (rispettivamente alle ore 6:00, 9:00, 12:00 e 15:00 della giornata), Vespri e Compieta).
La Chiesa invita lodevolmente anche i fedeli laici alla recita del Breviario; infatti esso ha lo scopo di aiutare il Cristiano a vivere in Cristo la giornata, santificandone i vari momenti. Viene recitato sia nei luoghi di culto, in modo comunitario, sia in modo personale nelle proprie case. La Preghiera Liturgica trae la sua origine dal precetto di Gesù di pregare senza interruzione.
Il Breviarium Romanum ha una articolazione molto simile a quella del Missale Romanum; è composto da un Ordinario, che comprende le parti fisse che si recitano uguali ogni giorno, il Proprio del Tempo, che comprende le parti variabili che dipendono dal tempo liturgico, il Proprio dei Santi, che comprende le parti variabili in funzione delle singole feste dei santi, il Comune dei Santi, che comprende le parti variabili relative alle feste dei santi, ma che non si trovano nel Proprio dei Santi e sono accorpate per classi omogenee di santi, infine il Salterio che comprende il ciclo dei 150 salmi che si ripete identico ogni settimana.

 Brocca con catino (per lavabo).
Brocca con catino (per lavabo). È un'anfora di metallo munita di un opportuno catino che si usa per portare all'altare l’acqua che serve a lavare le mani del sacerdote (abluzione o purificazione) quando durante la Santa Messa, all’Offertorio, il sacerdote deve purificare le mani prima di toccare le Sacre Specie dell'Eucaristia.


 Bugia.
Bugia. E' un oggetto di argento o altro metallo che sorregge una candela. Serviva inizialmente per necessità pratiche nelle chiese in cui non ci fosse sufficiente luce per leggere. Nel corso dei secoli è divenuta un'insegna episcopale estesa anche ad alcuni prelati privilegiati (Vicari, ai Prefetti apostolici, ai Chierici della Camera apostolica, ai Prelati domestici ed ai Canonici dei Capitoli che godono di questo privilegio).
Si usa ogni volta che il prelato legge, eccetto al Venerdì Santo. Non si può usare in presenza di un altro prelato di grado superiore o per far luce al lettore o per la distribuzione della Comunione.
Nei pontificali la bugia era retta da un porta insegne che poteva, sopra la cotta, indossare il piviale del colore liturgico del giorno. Il chierico si pone sempre accanto al chierico porta libro ogni qual volta che questo si avvicina al Vescovo.

C
 Cerimoniale dei Vescovi *** Cæremoniale Episcoporum.
Cerimoniale dei Vescovi *** Cæremoniale Episcoporum.
Il Cæremoniale Episcoporum (Cerimoniale dei Vescovi) è un libro liturgico che raccoglie le regole delle cerimonie episcopali, ossia regola lo svolgimento delle liturgie presiedute dal Vescovo o celebrate alla sua presenza.
A titolo esemplificativo, nel Cæremoniale Episcoporum, si può trovare: l'abito e le altre cose che deve fare un Vescovo appena eletto; il primo ingresso di un Vescovo nella sua diocesi; l'abito ordinario che un Arcivescovo indossa nella sua provincia; benedizioni e altre prerogative...; le mansioni del sacrista; le mansioni del Cerimoniere; le mansioni del sacerdote “assistente” durante i vespri e la Santa Messa; l'"assistenza" di due canonici in veste diaconale mentre il Vescovo, in abito ordinario, presiede o non presiede; le mansioni del diacono durante la Messa solenne; le mansioni del suddiacono durante la stessa solenne Messa pontificale; il numero, la qualità e le mansioni dei ministri che servono il Vescovo nelle celebrazioni liturgiche, in particolare circa il libro, la candela, il pastorale...; l'ornamentazione della chiesa e dei preparativi in vista della venuta del Vescovo; il luogo dove devono prendere posto in chiesa i vescovi, i legati, i cardinali...; l'uso dell'ombrello ovvero del baldacchino; l'abito ecclesiastico del Vescovo e dei canonici; il loro ingresso in chiesa e la loro uscita dalla chiesa; il pallio; la mitria ed il bastone pastorale; le reverenze e le genuflessioni...; l'incensazione, l'ordine e il modo di congiungere le mani, disgiungerle, alzarle, tenderle da parte dei vescovi...; le preghiere o collette e i diversi toni per cantarle; l'organo, l'organista e i musici, e le norme che essi devono osservare; la Messa senza canto presieduta dal Vescovo; la Messa senza canto celebrata alla presenza di un Vescovo nel territorio di sua giurisdizione; le cerimonie da osservare nei sinodi provinciali e diocesani. Ancora: i primi vespri solenni; la compieta; il mattutino alla presenza del Vescovo; le lodi e le altre ore canoniche; la Messa solenne presieduta dal Vescovo; la Messa solenne celebrata alla presenza del Vescovo; i vespri e il mattutino dei defunti; la Messa pontificale per i defunti presieduta dal Vescovo, l'omelia e l'assoluzione dopo la Messa; le celebrazioni dei Misteri del Signore durante l'anno liturgico, il tempo di Avvento e della Natività del Signore, le feste tra Natale e la Purificazione che devono essere celebrate solennemente, la festa della Purificazione della Beata Vergine Maria, la benedizione e la distribuzione delle candele, la festa della Purificazione nelle cattedrali, con il Vescovo assente, e nelle collegiate, il tempo di Quaresima, l'Ufficio e la Messa il Mercoledì delle ceneri, quando presiede il Vescovo oppure quando non presiede ma è presente, il tempo di Passione, la Veglia Pasquale, il tempo Pasquale, il tempo Ordinario; le Rogazioni e le Quattro Tempora...; i Sacramenti, Cresima o Confermazione e Ordine Sacro...; i Sacramentali, benedizione dell'Abate, consacrazione delle vergini, istituzione dei Lettori e degli Accoliti, dedicazione e benedizione di una Chiesa, benedizione dei Vasi Sacri (Calice e Patena), benedizione di una nuova Croce da esporre alla pubblica venerazione, rito di incoronazione di una immagine della Beata Vergine Maria, benedizione della campana, benedizione di un cimitero, le Processioni, esposizione Eucaristica e benedizione Eucaristica, benedizioni impartite dal Vescovo...; visita pastorale di una parrocchia; ingresso di un nuovo parroco; la malattia, la morte e il funerale di un Vescovo e le preghiere per ottenere da Dio un'opportuna elezione del nuovo Vescovo; ecc. ...

 Cerimoniale dei Vescovi *** Cæremoniale Episcoporum.
Cerimoniale dei Vescovi *** Cæremoniale Episcoporum. Il Cæremoniale Episcoporum (Cerimoniale dei Vescovi) è un libro liturgico che raccoglie le regole delle cerimonie episcopali, ossia regola lo svolgimento delle liturgie presiedute dal Vescovo o celebrate alla sua presenza.
A titolo esemplificativo, nel Cæremoniale Episcoporum, si può trovare: l'abito e le altre cose che deve fare un Vescovo appena eletto; il primo ingresso di un Vescovo nella sua diocesi; l'abito ordinario che un Arcivescovo indossa nella sua provincia; benedizioni e altre prerogative...; le mansioni del sacrista; le mansioni del Cerimoniere; le mansioni del sacerdote “assistente” durante i vespri e la Santa Messa; l'"assistenza" di due canonici in veste diaconale mentre il Vescovo, in abito ordinario, presiede o non presiede; le mansioni del diacono durante la Messa solenne; le mansioni del suddiacono durante la stessa solenne Messa pontificale; il numero, la qualità e le mansioni dei ministri che servono il Vescovo nelle celebrazioni liturgiche, in particolare circa il libro, la candela, il pastorale...; l'ornamentazione della chiesa e dei preparativi in vista della venuta del Vescovo; il luogo dove devono prendere posto in chiesa i vescovi, i legati, i cardinali...; l'uso dell'ombrello ovvero del baldacchino; l'abito ecclesiastico del Vescovo e dei canonici; il loro ingresso in chiesa e la loro uscita dalla chiesa; il pallio; la mitria ed il bastone pastorale; le reverenze e le genuflessioni...; l'incensazione, l'ordine e il modo di congiungere le mani, disgiungerle, alzarle, tenderle da parte dei vescovi...; le preghiere o collette e i diversi toni per cantarle; l'organo, l'organista e i musici, e le norme che essi devono osservare; la Messa senza canto presieduta dal Vescovo; la Messa senza canto celebrata alla presenza di un Vescovo nel territorio di sua giurisdizione; le cerimonie da osservare nei sinodi provinciali e diocesani. Ancora: i primi vespri solenni; la compieta; il mattutino alla presenza del Vescovo; le lodi e le altre ore canoniche; la Messa solenne presieduta dal Vescovo; la Messa solenne celebrata alla presenza del Vescovo; i vespri e il mattutino dei defunti; la Messa pontificale per i defunti presieduta dal Vescovo, l'omelia e l'assoluzione dopo la Messa; le celebrazioni dei Misteri del Signore durante l'anno liturgico, il tempo di Avvento e della Natività del Signore, le feste tra Natale e la Purificazione che devono essere celebrate solennemente, la festa della Purificazione della Beata Vergine Maria, la benedizione e la distribuzione delle candele, la festa della Purificazione nelle cattedrali, con il Vescovo assente, e nelle collegiate, il tempo di Quaresima, l'Ufficio e la Messa il Mercoledì delle ceneri, quando presiede il Vescovo oppure quando non presiede ma è presente, il tempo di Passione, la Veglia Pasquale, il tempo Pasquale, il tempo Ordinario; le Rogazioni e le Quattro Tempora...; i Sacramenti, Cresima o Confermazione e Ordine Sacro...; i Sacramentali, benedizione dell'Abate, consacrazione delle vergini, istituzione dei Lettori e degli Accoliti, dedicazione e benedizione di una Chiesa, benedizione dei Vasi Sacri (Calice e Patena), benedizione di una nuova Croce da esporre alla pubblica venerazione, rito di incoronazione di una immagine della Beata Vergine Maria, benedizione della campana, benedizione di un cimitero, le Processioni, esposizione Eucaristica e benedizione Eucaristica, benedizioni impartite dal Vescovo...; visita pastorale di una parrocchia; ingresso di un nuovo parroco; la malattia, la morte e il funerale di un Vescovo e le preghiere per ottenere da Dio un'opportuna elezione del nuovo Vescovo; ecc. ...

 Calice.
Calice. E' il Vaso Sacro che contiene il vino eucaristico della Messa, usato nell'offerta del Sacrificio. Il vino, dopo la consacrazione, rende realmente presente Nostro Signore Gesù Cristo in Corpo, Sangue, Anima e Divinità; del vino restano solo le specie (dette anche apparenze o accidenti), ossia la forma, l'odore, il sapore, il colore, il peso, ecc..
Il Calice è costituito nella parte superiore dalla coppa e nella parte inferiore dalla base o piede; il fusto, o stelo, è munito di un nodo o pomello centrale all'incirca equidistante dalla coppa e dalla base.
Il metallo utilizzato deve essere prezioso, soprattutto all'interno della coppa, così come prescrivono le norme liturgiche, secondo il quale deve essere sempre d'oro o dorato.
Poichè il Calice viene a contatto immediato con il vino eucaristico, tale vaso è consacrato dal Vescovo.

 Calzature liturgiche (calze, calzari e sandali pontificali e pantofole papali).
Calzature liturgiche (calze, calzari e sandali pontificali e pantofole papali). Le calzature liturgiche erano regolarmente in uso fino a prima della riforma liturgica. Queste coprono interamente il piede e la gamba; in particolare le calze avvolgono internamente il piede, mentre i calzari, essendo calze di maggiore ampiezza, coprono interamente la gamba fino al ginocchio, infine i sandali, essendo calzature esterne, coprono i piedi.
In particolare, le calze fanno parte dell'abbigliamento ecclesiastico, e seguono per il loro colore le regole delle vesti dei chierici, mentre i calzari, indossati sopra le calze ordinarie, hanno un uso esclusivamente liturgico e vengono adoperati nelle Messe pontificali dai cardinali, dai vescovi, dagli abati e dai prelati che ne hanno il privilegio. Non si portano nelle Messe funebri, né il Venerdì Santo. La loro forma è quella di una calza un poco più ampia, ed è in tessuto o in maglia, nei vari colori del tempo liturgico, salvo il nero. I calzari presentano dei lacci, nastri o cordoni, terminanti a volte con nappe, per legarle sopra il ginocchio; possono essere ricamate o decorate in filo d'oro o d'argento. Vengono indossate con i sandali pontificali. I sandali sono calzature esterne e chiuse che coprono il piede e sono prive di tacco; anch'essi sono usati durante le Messe pontificali dai prelati che godono dei privilegi pontificali. I sandali liturgici sono in seta, del colore del tempo liturgico, ad eccezione del nero, allacciati da lacci o da fettucce di seta, terminanti spesso con nappe il cui materiale e colore, come la decorazione presente sulla calzatura, variano secondo la dignità del prelato.
Il Sommo Pontefice porta le calze bianche sopra le quali nei pontificali indossa i calzari bianchi o rossi secondo il rito. Inoltre il Papa usa le pantofole papali, sia nelle funzioni liturgiche con i paramenti da chiesa, sia fuori della chiesa in tempo ordinario. Sono di pelle leggera, di lana pesante o di velluto, per l'inverno; di seta per l'estate; sono rosse o bianche ricamate sulla tomaia con una croce e fermate da un cordone d'oro con nappine dello stesso colore.
I cardinali hanno le calze rosse (porpora), eccetto il Venerdì Santo e durante la vacanza della Sede Apostolica, quando prendono quelle paonazze (violacee). I cardinali appartenenti ad ordini monastici o mendicanti non portano le calzature rosse, ma ritengono il colore dell'abito religioso. I patriarchi, arcivescovi, vescovi, hanno l'uso delle calze di seta paonazza (violacea), ma con quella medesima distinzione che si è detta dei cardinali religiosi. Nel tempo di Sede vacante ed il Venerdì Santo portano le calze nere. Tutti i prelati della Santa Sede portano le calze paonazze (violacee) con le eccezioni sopra riferite. I monsignori di mantellone usano le calze nere. I sacerdoti nei gradi del diaconato e del presbiterato usano le calze nere.
Oggi l’uso dei colori nelle calze non è più obbligatorio, tuttavia molti prelati le usano ancora secondo l’antica prescrizione; sia chiaro che per il Pontefice sono sempre bianche. Anche l'uso dei calzari non è più obbligatorio, inoltre il colore delle scarpe dei chierici al di fuori delle Messe pontificali e indipendentemente dal grado sacerdotale è ordinariamente il nero, per coloro che non godono dei privileggi pontificali è in genere sempre nero.







 Camauro.
Camauro. Berrettone di velluto rosso bordato di ermellino bianco o di piume di cigno; aveva forma di cuffia anche a riparo delle orecchie, che il Pontefice iniziò ad usare abitualmente dal periodo rinascimentale in inverno ed era portato talvolta anche sotto la tiara o triregno come ci è dato vedere in numerose iconografie.
Il camauro subì alcune insignificanti modifiche senza però perdere la forma originaria come pure ebbe alterne considerazioni nelle abitudini dei singoli papi che o lo usarono incondizionatamente oppure lo ignorarono.
Fino a quando Benedetto XVI ne ha ripristinato l’uso dopo qualche decennio, l’ultimo pontefice che ne fece uso fu il Santo Giovanni XXIII che ripristinò anche la tradizione di portare quello di damasco bianco che si usava solo entro l’Ottava di Pasqua (domenica in Albis).



 Camice (detto anche Alba).
Camice (detto anche Alba). Dal nome stesso, è una tunica di lino bianca senza aperture e lunga fino alle caviglie che simboleggia la veste del battesimo.
Il camice può essere decorato da bordi o galloni colorati o, per le occasioni più solenni, arricchito da un bordo in pizzo; è indossato dai ministri della Messa sotto le altre vesti.
 (sotto lo scollo quadro va l'Amitto)
(sotto lo scollo quadro va l'Amitto) Preghiere per indossare l'Alba: "Deálba me, Dómine, et munda cor meum; ut, in Sánguine Agni dealbátus, gáudiis pérfruat sempitérnis." (traduzione: Puríficami, o Signore, e monda il mio cuore: affinché, purificato nel sangue dell’Agnello, io goda dei gaudii eterni.)
 Campanello.
Campanello. Il campanello da parete è attaccato al muro vicino alla porta della Sacrestia e serve per avvisare i fedeli dell’inizio della celebrazione della Santa Messa.
Durante la Santa Messa viene usato il campanello da altare (detto anche tintinnabolo), che viene posto a terra a fianco dell'altare e viene suonato dal chierichetto per richiamare l'attenzione dei fedeli partecipanti su alcuni momenti fondamentali (ad esempio alla consacrazione ed elevazione delle Sacre Specie) della celebrazione liturgica:
- Alla recita o canto del Sanctus per tre volte, prima dell'inizio del Canone;
- Al Quam Oblatiònem, mentre il celebrante si reca sulla predella ed inginocchiandosi solleva per un lembo la pianeta;
- Alla Consacrazione del Corpo e Sangue di Cristo, una volta alla prima adorazione, tre volte all'elevazione, una volta alla seconda adorazione;
- Al termine della Consacrazione;
- Alla piccola elevazione;
- Al Domine, non sum dignus... per tre volte.
L'uso dei campanelli, o tintinnaboli, si potè notare già a partire dal sec. XII, quando si introdusse nella Messa l'elevazione delle Sacre Specie; tali oggetti erano già noti presso gli antichi popoli per richiamare l'attenzione dei fedeli. L'uso divenne comune con l'introduzione del Messale Romano sotto s. Pio V. Il Ritus celebrandi prescrive un segno di campanello al Sanctus ed all'Elevazione.
Fino alla metà del XX secolo veniva inoltre suonato sempre al Gloria del Giovedì Santo e del Sabato Santo. Durante i funerali e nell'azione liturgica del Venerdì Santo (Liturgia dei Presantificati) è sostituito dal Crotalo o Crepitacolo.
Il campanello è anche usato nel portare il S.mo Sacramento nelle case degli ammalati; infatti, secondo il monito del Rituale Romano, nel portare il S.mo Sacramento ad un ammalato, il chierico "campanulam iugiter pulset", per richiamare l'attenzione dei fedeli.



 Candelabro.
Candelabro. È un supporto generalmente realizzato in metallo prezioso (argento o rame argentato) simile al Candeliere ma dotato di tre o più braccioli sui quali vengono messe le varie candele. Generalmente i candelabri sono utilizzati per l’esposizione del SS. Sacramento e per l’intronizzazione della reliquia della Santa Croce.

 Candeliere.
Candeliere. È un supporto più o meno ornato che serve a reggere la candela o il cero durante le celebrazioni liturgiche. I candelieri, così come la croce, furono usati tardi sull’altare. Inizialmente, infatti, la “mensa Domini” ospitava soltanto i doni delle offerte.
Nella Chiesa occidentale non sembra siano mai stati usati prima del X secolo sopra l’altare. Anteriormente i candelieri, o meglio i candelabri, erano poggiati ai lati della mensa, sul pavimento o su mensole apposite oppure sulle stesse balaustre.
Solitamente erano di grandi dimensioni, con piede poggiante su zampe di animale, il fusto a colonna reggeva una tazza con spina che portava la candela.
Il papa Innocenzio III, per la prima volta, parla di due ceri da porre sull’altare ai lati della croce (1208) ed in un Ordo Romanus del 1254 è prescritto l’uso di sette ceri che nel sec. XV si riducono a sei per consentire meglio la simmetria. I sette candelieri rimasero in essere per le celebrazioni presiedute dal Vescovo diocesano, in questo caso il settimo avrebbe dovuto portare una candela più alta delle altre ed essere collocato dietro alla croce.

 Canonizzazione.
Canonizzazione. La Canonizzazione è l'atto liturgico e giuridico, riservato al Romano Pontefice, con il quale la Chiesa dichiara ufficialmente Santo un soggetto che in precedenza aveva già ottenuto il culto locale con il titolo di Beato, estendendo il suo culto alla Chiesa universale.
La maggior parte delle Canonizzazioni ha luogo in Vaticano (nella Basilica di San Pietro, o, per lo più, sul Sagrato della stessa), ma il rito può avvenire anche in altri luoghi. Condizione necessaria è la presenza del Papa; infatti, a differenza della Beatificazione, la Canonizzazione, avendo carattere universale, può essere presieduta solo dal Sommo Pontefice.
Con la canonizzazione, si proclama che la persona interessata si trova con certezza in Paradiso e in più, rispetto alla semplice beatificazione, ne permette la venerazione come santo nella Chiesa universale, mentre con il processo di beatificazione se ne permette la venerazione nelle Chiese particolari (ad esempio, prima che fosse canonizzato, il Santo Papa Giovanni Paolo II poteva essere venerato nella Diocesi di Roma, in quanto ne è stato il Vescovo, e nelle Diocesi polacche, perché nato in Polonia).
Nella Chiesa Cattolica, la canonizzazione avviene al termine di un'apposita procedura, che dura in genere molti anni, chiamata processo di canonizzazione (o processo canonico). Tra le altre cose, negli ultimi decenni, è richiesto che vengano riconosciuti dei miracoli attribuiti all'intercessione della persona oggetto del processo. La decisione finale sulla canonizzazione è in ogni caso riservata al Papa, che sancisce formalmente la conclusione positiva del processo canonico attraverso un atto pontificio.
Il riconoscimento di un nuovo santo è, per la Chiesa Cattolica, fonte di grande gioia in quanto considerato manifestazione speciale dell'operato di Dio: un nuovo santo è, nel cattolicesimo, un dono che Dio fa alla comunità. Il processo che porta la Chiesa a dichiarare un uomo od una donna santo/a richiede grande attenzione e responsabilità, perché la decisione che ne deriva influenza molte persone: il santo o la santa verrà infatti proposto alla venerazione di tutti i fedeli in tutto il mondo ed indicato come esempio da seguire.
Il processo di canonizzazione ha una durata variabile di parecchi anni, ma può arrivare a secoli. Segue due procedure, a seconda che il defunto da canonizzare sia morto di morte naturale o sia stato ucciso come martire. Per il Martire la procedura è in qualche modo semplificata, perché tenderà ad accertare soprattutto se si sia trattato di vero martirio, ossia di morte inflitta in esplicito odio alla Fede ed alla Chiesa, e dal martire liberamente e serenamente accettata e sopportata in testimonianza di fedeltà e di amore alla fede ed alla Chiesa.
Invece, se la persona per la quale si chiede il processo di canonizzazione è morta di morte naturale:
- il processo di canonizzazione ha origine dalle persone che hanno vissuto con il potenziale santo o santa, che ne conoscono l'operato e lo stile di vita: la comunità della parrocchia, la congregazione religiosa, la comunità in cui ha lavorato, eccetera;
- questi, detti Attori, incaricano una persona che ritengono adeguata a presentare richiesta al vescovo di riferimento perché apra l'Inchiesta Diocesana su una possibile beatificazione. Chi presenta la domanda viene detto Postulatore della Causa. Se la Santa Sede lo ritiene affidabile, diviene la persona di riferimento per la Congregazione per le cause dei santi, cioè l'organismo della Santa Sede che si occupa dei processi di beatificazione. L'inchiesta non può iniziare se non sono trascorsi almeno 5 anni dalla morte della persona, a meno che il Papa in persona non voglia autorizzare una eccezione (come nel caso di Giovanni Paolo II su disposizione di Benedetto XVI). Questo criterio di cautela tende a evitare di farsi trasportare da entusiasmi temporanei ed intende aiutare a valutare con criterio i fatti;
- la Congregazione per le Cause dei Santi valuta la richiesta del vescovo e risponde con un Nulla Osta (niente si oppone), autorizzandolo a procedere. Da questo punto in poi il potenziale santo o santa viene detto "Servo (o serva) di Dio";
- si procede intervistando quante più persone possibili, valutando documenti e testimonianze per capire se, tra quanti lo hanno conosciuto, ci sia una cosiddetta fama di santità. Se, durante la vita della persona sono avvenuti episodi inspiegabili che possano essere ritenuti "miracoli", questi verranno verificati e segnalati, sebbene non siano considerati fondamentali. Ne deriva una raccolta di documenti che viene inviata a Roma;
- la Congregazione per le Cause dei Santi controlla che la raccolta del materiale sia avvenuta in modo corretto, quindi nomina un Relatore della Causa che guiderà l'organizzazione del materiale nella Positio super virtutibus del Servo di Dio. La Positio è quindi un dossier dove si esprime con criterio la "dimostrazione ragionata" (Informatio) delle presunte virtù eroiche, usando le Testimonianze e Documenti raccolti nell'Inchiesta Diocesana (Summarium); Nel 1587 venne istituita una figura, contrapposta al relatore, di Pubblico Ministero (chiamato popolarmente l'Avvocato del Diavolo) che in questa fase cerca le prove contro la santità del candidato: errori nella dottrina della Fede, disobbedienze alla Chiesa, comportamenti palesemente od occultamente peccaminosi o viziosi. Questa figura è stata poi soppressa nel 1983 da parte di papa Giovanni Paolo II per snellire il processo di canonizzazione;
- si organizza una commissione di 9 teologi, detta Congresso dei Teologi, per l'esame della Positio del postulatore e delle Animadversiones dell'avvocato del diavolo. Se questi danno parere favorevole si ha una riunione di Cardinali e Vescovi della Congregazione dei Santi, terminata la quale il Papa autorizza la lettura del Decreto ufficiale sull'eroicità delle virtù del Servo di Dio. Questi d'ora in poi viene chiamato "venerabile". Questo chiude la prima fase del processo di canonizzazione;
- la fase successiva è la Dichiarazione di beatificazione, per arrivare alla quale deve essere riconosciuto un miracolo attribuito all'intercessione del venerabile. Qualcuno deve aver pregato la persona e questa deve aver "risposto" venendo in soccorso con un evento inspiegabile e "prodigioso": questo viene ritenuto dalla Chiesa segno inequivocabile che la persona è in Paradiso e di là può e vuole soccorrere i vivi. La cautela in questa fase è ancora maggiore. Perché un miracolo venga preso in considerazione dalla Congregazione dei Santi occorre una Inchiesta Diocesana, approfondita con lo stesso iter indicato sopra, che andrà consegnata alla Congregazione dei Santi;
-
tra gli episodi a cui la Chiesa Cattolica più frequentemente attribuisce carattere miracoloso vi sono:
l'incorruttibilità del corpo dopo la morte, come per santa Caterina da Bologna, il cui corpo è ancora integro
dopo quasi 550 anni dalla morte; la "liquefazione del sangue" durante occasioni particolari, come san Gennaro;
l'"Odore di Santità": il corpo emanerebbe profumo di fiori, anziché il consueto odore di morte, come nel caso di
santa Teresa d'Avila. Tuttavia il miracolo che si verificherebbe più spesso è quasi sempre una guarigione da
malattia grave. Questa deve essere istantanea, senza alcuna spiegazione medica plausibile, definitiva e totale.
La Positio sul miracolo viene quindi esaminata da 5 medici: se questi dichiarano di non sapere dare spiegazione razionale e scientifica dell'avvenimento, si configura la possibilità di ritenerla miracolo. L'avvenuto viene valutato da 7 teologi, quindi da vescovi e cardinali; - terminate queste riunioni, il Papa (o suo delegato, di norma un cardinale) proclama il venerabile beato o beata in una Messa solenne, quindi stabilisce una data della memoria nel calendario liturgico locale o della famiglia religiosa cui la persona apparteneva;
- se viene riconosciuto un altro miracolo, a seguito di una valutazione che ha lo stesso iter e la stessa severità del primo, il beato viene dichiarato santo e il suo culto viene autorizzato ovunque vi sia una comunità di credenti.
Riguardo al valore dell'atto pontificio, la maggior parte dei teologi cattolici attribuisce alla canonizzazione il carattere dell'infallibilità, mentre lo si esclude senz'altro per la beatificazione.
Ecco, nel dettaglio, le varie fasi del rito della santificazione (revisionato nel 2012):

Ancora prima dell'inizio della celebrazione, a differenza di quanto avviene per la Beatificazione (nella quale i volti dei Servi di Dio rimangono coperti fino a quando il Legato Pontificio ha terminato di pronunciare la formula di Beatificazione), gli arazzi con le raffigurazioni dei Beati che saranno canonizzati sono già scoperti, in quanto essi godono già di culto, seppur locale, in virtù della Beatificazione.

Mentre la processione di ingresso si dirige all'altare della celebrazione, si cantano le Litanie dei Santi.

Prima petitio
Il Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, accompagnato dai Postulatori, si reca dal Santo Padre e domanda che si proceda alla Canonizzazione:
"Beatissime Pater, instanter postulat Sancta Mater Ecclesia per Sanctitatem Vestram Catalogo Sanctorum adscribi, et tamquam Sanctos ab omnibus christifidelibus pronunciari Beatos N.N.." (traduzione: Beatissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede con forza che Vostra Santità iscriva i Beati N.N. nell'Albo dei Santi e come tali siano invocati da tutti i cristiani.)

Il Santo Padre: "Fratres carissimi, Deo Patri omnipotenti preces nostras per Iesum Christum levemus, ut, Beatae Mariae Virginis et omnium Sanctorum suorum intercessione, sua gratia sustineat id quod sollemniter acturi sumus." (traduzione: Fratelli carissimi, eleviamo le nostre preci a Dio Padre onnipotente per mezzo di Gesù Cristo, affinché, per intercessione della Beata Maria Vergine e di tutti i suoi Santi, sostenga con la sua grazia ciò che stiamo per compiere.)
-PAUSA DI SILENZIO-
Il Santo Padre: "Preces populi tui, quaesumus, Domine, benignus admitte, ut quod famulatu nostro gerimus et tibi placeat et Ecclesiae tuae proficiat incrementis. Per Christum Dominum nostrum." (traduzione: Ascolta, ti preghiamo o Signore benigno, le nostre preci, affinché quello che con il nostro servizio facciamo, sia a te gradito e sia di incremento alla tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.)
Seconda petitio
Il Prefetto: "Unanima precatione roborata, Beatissime Pater, Sancta Ecclesia instantius flagitat ut Sanctitas Vestra filios hos ipsius electos in Sanctorum Catalogo annumeret." (traduzione: Confortata dall'unanime preghiera, Beatissimo Padre, la Santa Chiesa torna a chiedere con maggior forza che Vostra Santità voglia iscrivere questi suoi eletti figli nell'Albo dei Santi.)
Il Santo Padre: "Spiritum vivificantem, igitur, invocemus, ut mentem nostram illuminet atque Christus Dominus ne permittat errare Ecclesiam suam in tanto negotio." (traduzione: Invochiamo dunque lo Spirito vivificante, perché illumini la nostra mente e Cristo Signore non permetta alla sua Chiesa di errare in un'opera così importante.)
- LA SCHOLA E L'ASSEMBLEA CANTANO ALTERNATIVAMENTE L'INNO Veni, creator Spiritus -
Terza petitio
Il Prefetto: "Beatissime Pater, Sancta Ecclesia, Domini promisso nixa Spiritum Veritatis in se mittendi, qui omni tempore supremum Magisterium erroris expertem reddit, instantissime supplicat Sanctitatem Vestram ut hos ipsius electos in Sanctorum Catalogum referat." (traduzione: Beatissimo Padre, la Santa Chiesa, confidando nella promessa del Signore di inviare su di essa lo Spirito della Verità, che in ogni epoca mantiene il supremo Magistero immune dall'errore, supplica con grandissima forza Vostra Santità di voler iscrivere questi suoi eletti figli nell'Albo dei Santi.)

Il Santo Padre: " formula di canonizzazione: Ad honorem Sanctæ et Individuæ Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicæ et vitæ christianæ incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione præhabita et divina ope sæpius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio, Beatos N.N. Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes eos in universa Ecclesia inter Sanctos pia devotione recoli debere. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti." (traduzione: Ad onore della Santissima Trinità, per l’esaltazione della fede cattolica e l’incremento della vita cristiana, con l’autorità di Nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, dopo aver lungamente riflettuto, invocato più volte l’aiuto divino ed ascoltato il parere di molti Nostri Fratelli nell’Episcopato, dichiariamo e definiamo Santi i Beati N.N. e li iscriviamo nell’Albo dei Santi e stabiliamo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati tra i Santi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.)
- L'ASSEMBLEA CANTA: Amen. -

Vengono collocate accanto all’altare le reliquie dei nuovi Santi insieme ai ceri.

Il Diacono incensa le reliquie.
Nel frattempo la schola e l'assemblea cantano alternativamente l'inno Te Deum.
Il Prefetto ringrazia il Santo Padre: "Beatissime Pater, nomine Sanctæ Ecclesiæ enixas gratias ago de pronuntiatione a Sanctitate Vestra facta ac humiliter peto ut eadem Sanctitas Vestra super peracta Canonizatione Litteras Apostolicas dignetur decernere." (traduzione: Beatissimo Padre, a nome della Santa Chiesa ringrazio Vostra Santità per la proclamazione e Vi prego di voler disporre che venga redatta la Lettera Apostolica circa la Canonizzazione avvenuta.)
Il Santo Padre: "Decernimus." (traduzione: Lo ordiniamo.)

Il Prefetto si avvicina al Santo Padre per un saluto riconoscente.
Si inizia quindi la Messa con il canto dell'Antifona di Ingresso ed i riti di introduzione.
Secondo l'uso delle più solenni celebrazioni papali, il Vangelo viene cantato due volte:

in latino dal Diacono di rito romano;

in greco dal Diacono di rito orientale.

Il Papa benedice l'assemblea con l'Evangeliario recatogli dal Diacono di rito orientale.
LA MESSA PROSEGUE NEL MODO SOLITO ...
Note: testo del rito della Canonizzazione tratto da: Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, Cappella Papale - XXIX Domenica del Tempo Ordinario - Rito della Canonizzazione e Celebrazione Eucaristica presieduti dal Santo Padre Benedetto XVI - Piazza San Pietro, 21 ottobre 2012 - Tipografia Vaticana, 2012 - immagini delle Canonizzazioni del 21 ottobre 2012 tratte da Fotografia Felici -
 Cantari.
Cantari. Sono candele, fissate su candelieri, normalmente usate dai chierichetti nei momenti processionali. Nel Rito Ambrosiano i chierichetti addetti al trasporto dei cantari sono chiamati “da terzo”.

 Cantore.
Cantore. Il cantore è una persona, laica o religiosa, appartenente ad una schola cantorum, ossia ad un gruppo di persone (coro) destinate ad accompagnare con le opportune parti musicali le funzioni religiose nella Chiesa Cattolica. All'interno della chiesa, alla schola cantorum è riservato uno specifico spazio detto cantoria, solitamente situato al di sopra della zona di ingresso della chiesa stessa.


 Cantoria.
Cantoria. Nella chiesa è spesso situata sopra la zona d'ingresso, in controfacciata, ove forma uno specifico luogo sopraelevato adibito appositamente per la schola cantorum, ossia l'area in cui prendono posto i cantori, sia laici che religiosi, che costituiscono il coro deputato a cantare le parti musicali della Santa Messa. Spesso in questo spazio vi si trova anche l'organo ed, in tal caso, la cantoria funge anche da balconata per lo stesso.



 Cappa Magna.
Cappa Magna. E' un ampio mantello con strascico (generalmente della lunghezza di metri 6) e cappuccio che veniva e ancor oggi può essere indossato dai prelati nelle più solenni cerimonie.
La "cappa magna" è munita di una sovramantelletta di pelliccia che viene usata per le cerimonie che si svolgono nei periodi invernali dell'anno, mentre è sostituita da una equivalente mantelletta di seta per gli altri periodi dell'anno.
Lo strascico è in misura del rango ricoperto e raggiunge la lunghezza di alcuni metri, rendendo d'obbligo l'uso di uno o più chierici incaricati di reggerlo; tale mansione assume la definizione di “caudatario”. La cappa magna prevostile non necessita di caudatario in quanto essa viene utilizzata ripiegata dietro la schiena. La cappa magna era d'obbligo quando alla cerimonia, nella quale partecipavano coloro che avevano diritto di indossarla, era presente un dignitario di grado maggiore, cioè dovevano rivestirla i vescovi se era presente un Cardinale oppure ogni prelato e porporato se era presente il Pontefice. L’uso della cappa magna non è mai stato abolito.
I vescovi possono indossarla solo nella propria diocesi, gli arcivescovi metropoliti nella loro provincia, i nunzi apostolici e i delegati apostolici nel luogo della loro legazione ed i cardinali ovunque. Tutti, però, avevano l'obbligo di indossarla durante la cappella papale, se o finché il Papa non indossava i paramenti della Messa se celebrava personalmente. L'uso della cappa magna oggi è facoltativo.


 Cartegloria.
Cartegloria. L’uso della Carta-gloria permette al celebrante di leggere particolari preghiere fisse che vengono ospitate entro cornici più o meno artistiche appoggiate alla mensa eucaristica.
L’origine di questa tradizione, scomparsa con la recente riforma liturgica, è incerta.
Alcuni autori la fanno risalire addirittura a dittici liturgici che derivavano da dittici consolari.
Una sola era la tabella prescritta e veniva posta sotto la croce, poi la comodità ne aggiunse altre due poste rispettivamente ai lati dell’altare:
- in cornu Epistolae: sono scritte le preci del Lavabo;
- in cornu Evangelii: il prologo di San Giovanni;
- al centro: le parole del Gloria in excelsis Deo, del Credo in unum Deum, di Suscipe Sancte Pater, Offerimus spiritu, Veni sanctificator, Suscipe Sancte Trinitas, Qui pridie, le tre orazioni prima della comunione e il Placet.

 Casula.
Casula. La casula è una veste propria per il sacerdote nella celebrazione della Messa e nelle altre azioni sacre ad essa collegate. È di varie fogge ed il tessuto è colorato a seconda del colore liturgico e ricopre le spalle e le braccia, arrivando fino ai polsi nella parte superiore e fino quasi ai piedi nella parte inferiore.
Le rubriche del Messale indicano la casula, parimenti alla pianeta, come veste propria del sacerdote celebrante, nella Messa e nelle altre azioni sacre ad essa collegate. Le norme prevedono inoltre che sotto la casula si indossino, in ordine: amitto (ove previsto), camice o alba, cingolo (ove previsto) e stola; sotto la casula il Vescovo nelle Messe pontificali aggiunge la dalmatica. Nelle celebrazioni dove non è prevista l'annessione al rito della Messa, il sacerdote può indossare il piviale o la semplice stola premettendo sempre il camice o la cotta.
Il nome di casula deriva, come indica Isidoro di Siviglia, da piccola cosa, nel senso di piccola tenda o di piccola casa. Questa spiegazione si adatta alla forma tipologica della veste che all’origine avvolgeva completamente chi la indossava; d’altra parte si definiva con questo nome la cella monastica abitata dal monaco e la piccola cappella campestre.
Questo indumento deriva, come tutti i paramenti sacri, dalle antiche vesti greche e romane; infatti la casula deriva dalla paenula romana, molto simile per forma e caratteristiche.
Nel medioevo la casula è quasi esclusivamente una veste monastica e in questo senso è definita da Rabano Mauro che la indica con l’espressione “casula pianeta”. Pare comunque che i due termini fossero adottati per lo stesso paramento che nell’Urbe era detto pianeta, mentre nell’Orbe era detto casula.
Questo paramento sacerdotale è stato chiamato in latino casula, planeta, paenula ed in antiche fonti galliche anche amphibalus. Di questi termini, i più comuni sono casula e planeta (pianeta).
La pianeta di fatto altro non è se una riduzione di ampiezza dell’antica veste liturgica che ebbe il sopravvento assoluto nel sec. XV e si mantenne prevalente sino al secolo scorso, quando dalla Germania iniziò un movimento mirato al ritorno della pianeta ad una dimensione più ampia (che con erroneo termine veniva definita gotica).
I libri liturgici hanno sempre usato questi due termini come sinonimi. Nelle edizioni del Messale Romano in uso prima del Concilio Vaticano II il termine «casula» appariva dodici volte e il termine «pianeta» undici volte. Il Rito dell'ordinazione presbiterale prescriveva che l'ordinando si presentasse avente «planetam coloris albi complicatam super brachium sinistrum», ma poi indicava che il vescovo «imponit Ordinando casulam usque ad scapulas» e poi, più tardi, «explicans casulam, quam Ordinatus habet complicatam super humeros, et induit illum».
Dal Concilio Vaticano II in poi, il termine «casula» è usato quasi esclusivamente, accompagnato però qualche rara volta con la parola «pianeta» come sinonimo («la casula o pianeta»).
Ciò nonostante, qualche libro di consultazione, mentre tratta i due termini come sinonimi, considera arcaico il termine «casula»: «antica denominazione della pianeta sacerdotale».
Nel corso del tempo la veste, che originariamente giungeva ai talloni, da tutte le parti del corpo subì delle variazioni nella lunghezza sulle braccia e sulle gambe. Divenne un indumento semi-rigido, foderato, che non copriva alcuna parte delle braccia e andava indossato allacciandolo sui fianchi.
Nel XX secolo è apparsa la tendenza di tornare invece ad una forma più ampia del paramento, pur mantenendo parzialmente l'accorciamento dei fianchi. L'uso di questa forma provocò da parte di alcuni una reazione negativa, per cui la Sacra Congregazione dei Riti emise, il 9 dicembre 1925, un giudizio negativo, che fu poi esplicitamente revocato con la dichiarazione Circa dubium de forma paramentorum del 20 agosto 1957, che lasciò la decisione al giudizio prudente degli Ordinari locali. Esiste una fotografia che mostra papa Pio XI che celebrava la Messa nella basilica di san Pietro già il 19 marzo 1930 indossando una pianeta dalla forma più ampia.
La tendenza di abbreviare i fianchi della casula è apparsa, ma molto limitatamente, nei secoli XIII e XIV. Nei secoli XV e XVI la casula adottò una forma molto simile a quella moderna, in cui i fianchi del paramento giungono non più al tallone ma solo al polso del braccio. Poi, verso la fine del XVI secolo, come si vedono in immagini di sant'Ignazio di Loyola e san Filippo Neri, si giunse ad una forma abbastanza simile a quella ancora più ridotta che predominava nei secoli XVIII e XIX, quando la casula non copriva più alcuna parte delle braccia (e in Spagna non copriva nemmeno interamente le spalle) ed era molto abbreviata anche davanti e di dietro.
Le antiche casule spesso tenevano un disegno a forma di Y, che copriva le cuciture che riunivano i pezzi del paramento, allora di forma conica. Le casule del periodo in cui le braccia rimanevano totalmente scoperte erano generalmente ornate di dietro con una croce o con un'immagine sacra, spesso riccamente ricamata.
Inizialmente, per utilizzare la casula al posto della pianeta era necessario il permesso dell'Ordinario del luogo (Decreto S.R.C. 20-8-1957). Nel 1962, con la pubblicazione della nuova edizione del Missale Romanum da parte del Santo Papa Giovanni XXIII, la casula fu equiparata in tutto alla pianeta (cfr Rubricae Generales, XIX, 133), abolendo qualsiasi disposizione contraria.
Ogni casula è corredata di stola propria e talvolta può essere confezionata in corredo ad altri paramenti quali mitria, dalmatica e piviale.


Quando la indossa il sacerdote recita questa preghiera: "Domine, qui dixisti: Iugum meum suave est, et onus meum leve: fac, ut istud portare sic valeam, quod consequar tuam gratiam. Amen." (traduzione: O Signore, che hai detto: Il mio giogo è soave e il mio carico è leggero: fa’ che io possa portare questo [indumento sacerdotale] in modo da conseguire la tua grazia. Amen).
 Catafalco.
Catafalco. Il catafalco era un complesso apparato costituito da una base di legno coperta da un drappo funebre nero su cui poggiava una finta bara, anch’essa coperta da una coltre nera. Attorno al catafalco venivano anche posizionati dei candelieri e spesso il numero di questi era relativo alla classe e importanza del morto.
L’uso del catafalco era duplice: si utilizzava nei riti esequiali per appoggiarvi il feretro all’interno della chiesa; oppure se dotato di bara finta, coperta da coltre nera (bianca in caso di bambini) era utilizzato nelle messe di suffragio (settima, trigesima ed anniversario) o il giorno della Commemorazione dei Defunti, per dare una caratteristica funebre alla celebrazione.
L’uso del catafalco non è mai stato abolito ma con l’avvento della riforma liturgica è andato quasi dappertutto in disuso.

 Cerimoniere.
Cerimoniere. È colui che è incaricato di preparare le celebrazioni più complesse. Coordina i diversi servizi e fa' in modo che tutto si svolga ordinatamente e con tranquillità. Il cerimoniere deve non solo conoscere le norme, ma anche, in base all'esperienza pastorale, saper aiutare a svolgere i riti in modo fruttuoso.
Il Cerimoniere può essere sia un ministrante, sia un consacrato (diacono o sacerdote).

 Cero Pasquale.
Cero Pasquale. È la grossa candela che si accende durante la funzione della Veglia Pasquale e per tutto il periodo fino al giorno della Ascensione. Il cero pasquale era anticamente confezionato in pura cera d’api e recava sul fusto molte decorazioni con simboli liturgici.
Durante la benedizione che si svolgeva nella solenne Veglia Pasquale, nel cero erano conficcati cinque grossi grani di incenso che segnavano i numeri e le lettere dell’anno liturgico corrente; a tal proposito occorre specificare che tale tradizione è ancora oggi praticata. Inoltre il cero pasquale è incensato prima del canto del Preconio Pasquale.
Il cero pasquale è simbolo della risurrezione di Cristo e in tempi passati veniva spento dopo la lettura del Vangelo durante la celebrazione della Messa solenne nel giorno della Ascensione. Oggi il cero pasquale si usa indistintamente nel corso dell’anno liturgico in diverse cerimonie, dal rito del Battesimo alla liturgia funebre, dove si indica la presenza viva del Salvatore.

 Ceroferari (detti anche Cilostri o Torce).
Ceroferari (detti anche Cilostri o Torce). Sono candelieri di grandi dimensioni con cui i ministranti, i confratelli del SS. Sacramento od i fedeli accompagnano l'Eucaristia od i simulacri della Madonna e dei Santi nelle processioni. I cilostri possono avere fogge diverse: di legno, di metallo, scoperti o con la candela racchiusa in un apposito vano di vetro. Data la loro pesantezza i cilostri vengono agganciati a robuste cinture di cuoio indossate dal ministrante o confratello, così da renderne agevole il trasporto.


 Chierichetto o ministrante.
Chierichetto o ministrante. Il chierichetto, o ministrante, è colui che svolge un servizio di assistenza ai sacerdoti e ai diaconi durante la liturgia.
Questi possono ad esempio portare la croce, il messale, le ampolline e quanto concerne l'altare; portano il turibolo e la navicella ed inoltre portano i cantari.
L’abito proprio del ministrante è la veste (nera o rossa) e la cotta. Spesso tale abito viene sostituito impropriamente dall’alba (camice bianco chiuso da cerniera) o dalla “Tarcisiana” (veste bianca dotata di due fasce rosse). Il patrono dei chierichetti è San Tarcisio da cui deriva anche la parola “Tarcisiana”.


 Chiesa.
Chiesa. La Chiesa Cattolica Romana (anche Chiesa Cattolica Latina) è la Chiesa Cristiana che riconosce il primato e l'autorità assoluta al vescovo di Roma sulla cattedra di Roma, in quanto Vicario di Cristo, successore dell'apostolo Pietro, primo Papa costituito tale direttamente da Nostro Signore Gesù Cristo, nonchè monarca assoluto dello Stato della Citta del Vaticano.
Il nome "Cattolica" richiama l'universalità della Chiesa fondata da Gesù Cristo, costituita dal "popolo di Dio" a sua volta formato da "tutte le nazioni della terra". La Chiesa Cattolica, forte delle parole di Gesù Cristo, è la sola a custodire la vera fede e a tendere incensantemente alla pienezza della verità, e si impegna a perseguire un'azione di conversione nei confronti di coloro che non ne riconoscono la dottrina. I suoi fedeli vengono chiamati cattolici ed in quanto tali riconoscono la sovranità assoluta del Papa (e dei vescovi in comunione con lui), quale essere capo visibile, a nome e per conto di Gesù Cristo - capo invisibile a cui lo stesso Ponteficie è sottomesso - e custode della Chiesa.
Sul piano teologico, le caratteristiche principali della Chiesa Cattolica sono l’indefettibilità (cioè la sua durata ininterrotta fino al ritorno di Cristo) e le potestà che rappresentano la continuazione dell’opera avviata da Cristo sulla terra: la potestà di insegnamento o di magistero (in quanto alla Chiesa è affidata la tutela della vera fede, che essa ha il diritto e il dovere di insegnare a tutte le genti), di santificazione (con il potere sacramentale, ossia il conferimento della grazia per mezzo dei sacramenti), di governo o di giurisdizione (comprendente le potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria).
La Chiesa Cattolica è organizzata secondo dei livelli gerarchici, con la distinzione tra clero (Chiesa docente) e laicato (Chiesa discente), ossia tra le persone che hanno ricevuto il Sacramento dell'Ordine e quelle che invece non hanno alcun Ordine Sacro.
In particolare, la Chiesa si può suddividere in Chiesa trionfante, Chiesa purgante e Chiesa militante. La Chiesa trionfante è composta dalle anime di tutti coloro che già godono della visione beatifica di Dio in Paradiso (Santi) e ovviamente vi trovano parte rispettivamente anche Maria Santissima e tutte le gerarchie angeliche fedeli a Dio. La Chiesa purgante è composta da tutte le anime di coloro che, morti in grazia di Dio, hanno ancora bisogno di purificazione per poter accedere al Paradiso, perciò si trovano in un luogo detto Purgatorio, nel quale le anime sono purificate da un fuoco d'amore detto non a caso fuoco purgatorio. Infine, la Chiesa militante è composta da tutti noi che ancora siamo sulla terra a militare, cioè a combattere la buona battaglia per la difesa della fede.
L’ordinamento gerarchico del clero è composto da vescovi, presbiteri/preti e diaconi, e vede al vertice il Papa, sovrano assoluto, che esercita l'autorità stessa di Cristo. In particolare, il Clero è l'insieme di tutti gli uomini che hanno ricevuto il Sacramento dell'Ordine in almeno uno dei quattro possibili gradi del sacerdozio che sono: sudiaconato, diaconato, presbiterato ed episcopato (pienezza del sacerdozio); questi ordini sacri sono detti ordini maggiori, non ne sono quindi incluse le suore e le monache, inoltre nel caso del sudiaconato, diaconato e presbiterato si parla di ordinazione sacerdotale, mentre nel caso dell'episcopato si parla di consacrazione sacerdotale. Originariamente esistevano anche quattro ordini minori, l'ordine degli ostiari, dei lettori, degli esorcisti e degli accoliti, poi sopressi da Papa Paolo VI e trasformati nei corrispondenti ministeri.
Orbene, la Chiesa Cattolica è composta da vari membri, ognuno dei quali è da considerarsi parte del Corpo Mistico di Cristo; ognuno secondo il proprio stato di vita è da considerarsi alter Christus (altro Cristo), in particolare ogni fedele cattolico laico (che non abbia ricevuto ordine sacro) in virtù del sacerdozio battesimale è alter Christus, e quindi chiamato a cercare di conformarsi a Cristo nell'adempiere, secondo le proprie possibilità, ai doveri del proprio stato (ascolto della Parola, frequantare i sacramenti, obbedire ai Pastori della Chiesa, ecc.). Quanto ai presbiteri, invece, la loro conformazione a Cristo, già iniziata con il battesimo, viene perfezionata dallo Spirito Santo per mezzo del Sacramento dell'Ordine; tale Sacramento imprime nella loro anima il carattere di ministri di Dio, conformandoli in modo particolare a Cristo, Sommo ed Eterno Sacerdote, abilitandoli a compiere le azioni sacre (celebrazione della Santa Messa, amministrazione dei sacramenti, Ufficio Divino, guidare, istruire e benedire i fedeli nel percorso verso la loro santificazione). Nel celebrare il Mistero Pasquale (che indica il compimento, nella Passione, Morte, Risurrezione e Ascensione di Gesù, del disegno di Dio di condurre tutti gli uomini alla salvezza e alla conoscenza della verità), ovvero nell'amministrare i sacramenti, il sacerdote agisce in persona Cristhi, ossia è Cristo che celebra ed amministra servendosi della persona del sacerdote che, quindi, è ipse Christus (Cristo stesso).
Con l'espressione Corpo Mistico nella dottrina della Chiesa Cattolica si intende la speciale unione che lega i cristiani a Gesù Cristo. Secondo questa dottrina tutti i credenti in Cristo, sia i vivi che i defunti che vivono nella pace di Dio (in Paradiso e in Purgatorio) sono a lui strettamente ed intimamente uniti per la vita della grazia, nello stesso rapporto di un unico corpo in cui egli è il capo e tutti gli altri sono le membra. Tale dottrina prende le mossa dall'esempio riportato da San Paolo nelle sue lettere: (Rom 12; 4-5) «Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri». La stessa dottrina altrove è illustrata con l'esempio di un'unica vite di cui Gesù Cristo è la pianta viva e tutti gli altri sono i tralci alimentati da lui (cfr. Gv 15; 5).
Un ruolo speciale e sommo, al di sotto di Cristo, spetta a Maria sua madre.
Per questa intima unione e unità, tutto il bene compiuto da un singolo membro si riversa in beneficio di tutti gli altri, mentre il male compiuto da uno è sofferenza di tutti, anche se non sarà mai tale da poter sminuire od offuscare l'infinita sorgente di grazia che è il Cristo.


 Chiroteche.
Chiroteche. Sono i guanti liturgici che possono essere usati dai prelati, dai vescovi, dai cardinali e dal Romano Pontefice.
Sono del colore liturgico del giorno e recano ornamenti coronati dalla croce.
Oltre a fasciare la mano, si allungano sull’avambraccio fino quasi al gomito.
Sopra le chiroteche viene indossato un anello particolare, fatto apposta di dimensioni maggiori per essere indossato con le chiroteche.




 Ciborio.
Ciborio. Il ciborio è un elemento architettonico a forma di baldacchino che sovrasta l'altare nelle chiese. Poggia generalmente su quattro supporti verticali raccordati mediante archi e reggenti una volta piana o cupoletta, destinata a custodire la pisside contenente le ostie consacrate.

 Cilostri (detti anche Ceroferari o Torce).
Cilostri (detti anche Ceroferari o Torce). Sono candelieri di grandi dimensioni con cui i ministranti, i confratelli del SS. Sacramento od i fedeli accompagnano l'Eucaristia od i simulacri della Madonna e dei Santi nelle processioni. I cilostri possono avere fogge diverse: di legno, di metallo, scoperti o con la candela racchiusa in un apposito vano di vetro. Data la loro pesantezza i cilostri vengono agganciati a robuste cinture di cuoio indossate dal ministrante o confratello, così da renderne agevole il trasporto.


 Cingolo.
Cingolo. Cordone ad uso liturgico, che serve per serrare attorno al corpo l'alba o camice.
Anticamente era un capo del vestiario romano, che è rimasto poi stabile nel vestiario liturgico della Chiesa.
Sembra certo che in origine il cingolo non avesse la forma di cordone, ma di cintura di 6-7 [cm] di larghezza, che spesso era anche ricamata. Il cingolo-cordone comincia ad apparire verso il XV secolo.
In quanto a materia il cingolo conviene che sia, come in origine, di lino o canapa, ma può essere anche di seta o di lana, e perfino di cotone, benché non sia raccomandabile.
Le estremità terminano in frange o in nappe, e il colore è di solito bianco, ma può essere anche, del colore dei paramenti liturgici.
Ne fanno uso tutti coloro che partecipano alle funzioni liturgiche indossando l'alba o camice, quindi anche i lettori e gli accoliti. In questo caso esso è di colore bianco. Usano il cingolo anche i diaconi, i presbiteri ed i vescovi, sotto le rispettive vesti. In questo caso il cingolo può essere di diversi colori, a seconda dei tempi liturgici. Ogni colore può essere combinato con il colore oro.
Secondo Principi e norme per l'uso del Messale Romano questo può essere omesso purché il camice sia fatto in modo tale da aderire da solo ai fianchi.
Nel rito di San Pio V il sacerdote mentre lo indossa prima della celebrazione eucaristica, recita la seguente preghiera: "Praecinge me, Domine, cingulo puritatis, et exstingue in lumbis meis humorem libidinis; ut maneat in me virtus continentiae et castitatis." (traduzione: "Cingimi, Signore, con il cingolo della purezza e liberami dalle passioni della libidine, affinché rimanga sempre in me la virtù della continenza e della castità").
Esso è quindi segno penitenziale e ricorda anche gli Ebrei che consumarono l'agnello pasquale con i fianchi cinti (Es 12,11).
Cingolo è detto anche il cordone che cinge ai fianchi il saio e che caratterizza, in genere, i religiosi appartenenti alla famiglia francescana. Quando il cingolo fa parte dell'abito francescano è solitamente contraddistinto dalla presenza dei tre nodi, segno dei voti di povertà, castità ed obbedienza.






 Clero.
Clero. Il Clero è l'insieme di tutti gli uomini che hanno ricevuto il Sacramento dell'Ordine in almeno uno dei quattro possibili gradi del sacerdozio che sono: sudiaconato, diaconato, presbiterato ed episcopato (pienezza del sacerdozio); questi ordini sacri sono detti ordini maggiori, non ne sono quindi incluse le suore e le monache, inoltre nel caso del sudiaconato, diaconato e presbiterato si parla di ordinazione sacerdotale, mentre nel caso dell'episcopato si parla di consacrazione sacerdotale. Originariamente esistevano anche quattro ordini minori, l'ordine degli ostiari, dei lettori, degli esorcisti e degli accoliti, poi sopressi da Papa Paolo VI e trasformati nei corrispondenti ministeri.
In particolare, il Clero si può dividere in Clero regolare e Clero secolare o diocesano.
Il Clero regolare è composto da tutti i sacerdoti che appartengono ad istituti religiosi che vivono in comunità e che seguono una determinata regola ed emettono i voti religiosi (povertà, castità ed obbedienza). Fanno parte del Clero regolare i sacerdoti di vita religiosa che entrano a far parte di un ordine religioso (ad esempio l'Ordine dei Frati minori o Ordine Francescano), oppure i sacerdoti appartenenti ad una società di vita apostolica (ad esempio l'Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote od, ancora, la Fraternità sacerdotale San Pietro, ecc.).
Il Clero secolare, o diocesano, è composto da tutti i sacerdoti che appartengono ad istituti secolari che non vivono in comunità, non sono vincolati a seguire una particolare regola religiosa ed emettono i voti religiosi (povertà, castità ed obbedienza). Questi sacerdoti sono detti diocesani in quanto incardinati in una Diocesi.
Gli istituti religiosi e gli istituti secolari danno luogo agli istituti di vita consacrata. Ora, un istituto di vita consacrata si dirà clericale se è governato da chierici (uomini appartenenti al Clero, ossia diaconi, presbiteri/preti e vescovi) e se assume l'esercizio dell'Ordine Sacro, altrimenti si dirà laicale, ove le funzioni di governo sono espletate da persone religiose laiche. Dunque è chiaro che gli istituti di vita consacrata clericali sono costituiti esclusivamente da uomini, mentre quelli non clericali possono essere composti da soli uomini, da sole donne oppure essere misti; ovviamente anche tra gli istituti di vita consacrata non clericale esistono realtà in cui non si esclude la presenza di membri appartenenti al Clero e che quindi emettono voto di povertà, castità ed obbedienza. Esempi di istituti che si rivolgono a persone diverse sono le congregazioni dei Missionari della Carità fondate da Madre Teresa di Calcuta.
Per finire, un istituto di vita consacrata si dirà di diritto pontificio o di diritto diocesano a seconda che sia stato eretto e/o approvato rispettivamente dalla Santa Sede nel primo caso o da un Vescovo locale nel secondo. In particolare le istituzioni di diritto pontificio dipendono direttamente ed esclusivamente dalla Santa Sede Apostolica, quindi sono sottrate dal potere governativo del vescovo locale e sono soggette esclusivamente all'autorità del Papa, mentre le istituzioni di diritto diocesano sono soggette al potere governativo degli ordinari locali (vescovi).



 Colori liturgici.
Colori liturgici. I colori liturgici previsti nella Liturgia tradizionale sono il verde, il violaceo, il bianco, il rosso, il nero e il rosaceo.
Il verde è utilizzato nel tempo dopo l'Epifania e dopo Pentecoste, il violaceo in quello d'Avvento, quello di Settuagesima e quello quaresimale; il bianco, nel tempo natalizio, pasquale e nelle solennità, e può essere sostituito da paramenti dorati nelle celebrazioni delle feste più importanti; il colore rosso a Pentecoste e nelle feste dei Martiri, il nero nei funerali e nelle Messe di requiem e nell'azione liturgica del Venerdì Santo. Paramenti di colore rosaceo possono sostituire quelli violacei nella terza domenica di Avvento (domenica Gaudete) e nella quarta di Quaresima (domenica Laetare).
| COLORE LITURGICO | TEMPO LITURGICO |
|---|---|
| VERDE |
Tempo dopo l'Epifania e tempo dopo Pentecoste. In particolare:
|
| VIOLACEO |
Tempo d'Avvento, tempo di Settuagesima e tempo quaresimale. In particolare:
|
| BIANCO (anche ORO nelle celebrazioni delle feste più importanti) |
Tempo natalizio, tempo pasquale e solennità. In particolare:
|
| ROSSO |
Tempo di Pentecoste e Feste dei Martiri. In particolare:
|
| NERO |
Azione liturgica del Venerdì Santo, Messe da requiem e funerali. In particolare:
|
| ROSACEO |
|
Secondo l'ordine cronologico dell'anno liturgico, risulta:
| TEMPO LITURGICO | COLORE LITURGICO | DOMENICHE, FESTE, SOLENNITA' |
|---|---|---|
| Tempo d'Avvento | VIOLACEO |
- I domenica d'Avvento; - II domenica d'Avvento. |
| BIANCO | - Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria (8 dicembre). | |
| ROSACEO (o VIOLACEO) | - III domenica d'Avvento, o domenica Gaudete. | |
| VIOLACEO | - IV domenica d'Avvento. | |
| Tempo di Natale | BIANCO | - Natività del Signore (25 dicembre). |
| ROSSO | - Festa di S. Stefano Protomartire (26 dicembre). | |
| BIANCO | - Festa di S. Giovanni, Apostolo ed Evangelista (27 dicembre). | |
| ROSSO | - Festa dei Santi Innocenti Martiri (28 dicembre). | |
| BIANCO |
- Domenica tra l'Ottava di Natale; - Circoncisione del Signore (1° gennaio); - SS. Nome di Gesù. |
|
| Tempo di Epifania | BIANCO |
- Epifania di Nostro Signore (6 gennaio); - I domenica dopo l'Epifania, Sacra Famiglia; - Festa del Battesimo del Signore (13 gennaio). |
| Tempo dopo l'Epifania | VERDE | - II, III, IV, V e VI domeniche dopo l'Epifania. |
| Festa del Signore | BIANCO |
- Purificazione della Beata Vergine Maria (Presentazione di Gesù bambino al Tempio di Gerusalemme) (2 Febbraio - benedizione delle candele). Dopo la Festa della Candelora seguono le seguenti solennità: - San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria (19 marzo); - Annunciazione della Beata Vergine Maria o del Signore (25 marzo); |
| Tempo di Settuagesima | VIOLACEO |
- Domenica di Settuagesima; - Domenica di Sessagesima; - Domenica di Quinquagesima. |
| Tempo di Quaresima e di Passione | VIOLACEO |
- Mercoledì delle ceneri; - I, II e III domenica di Quaresima. |
| ROSACEO (o VIOLACEO) | - IV domenica di Quaresima o domenica Laetare. | |
| VIOLACEO |
- I domenica di Passione; - II domenica di Passione (o delle Palme). |
|
| Settimana Santa (Sacro Triduo Pasquale) | BIANCO | - Giovedì Santo, "In Coena Domini". |
| NERO | - Venerdì Santo, anticamente detto "In Parasceve". | |
| VIOLACEO | - Veglia di Pasqua. | |
| Tempo Pasquale, di Ascensione e di Pentecoste | BIANCO |
- Domenica di Pasqua di Resurrezione; - I domenica dopo Pasqua (dominica "In Albis"), II domenica dopo Pasqua, o del Buon Pastore, III, IV e V domenica dopo Pasqua; - Ascensione del Signore; - Domenica dopo l'Ascensione. |
| ROSSO | - Domenica di Pentecoste. | |
| Tempo dopo Pentecoste | BIANCO |
- I domenica dopo Pentecoste, SS. Trinità; - Giovedì dopo SS. Trinità, Corpus Domini. |
| VERDE | - II Domenica dopo Pentecoste. | |
| BIANCO | - Venerdì dopo la II domenica dopo Pentecoste, Sacratissimo Cuore di Gesù. | |
| VERDE | - Dalla III domenica dopo Pentecoste sino alla XXIV ed ultima domenica dopo Pentecoste. | |
| BIANCO | - Natività di San Giovanni Battista (24 giugno). | |
| ROSSO |
- SS. Pietro e Paolo, Apostoli (29 giugno); - Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo (1° luglio). |
|
| BIANCO |
- Visitazione della Beata Vergine Maria (2 luglio); - Trasfigurazione di Nostro Signore (6 agosto); - Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto); - Cuore Immacolato di Maria (22 agosto); - Natività della Beata Vergine Maria (8 settembre); - Santissimo Nome di Maria (12 settembre). |
|
| ROSSO | - Esaltazione della Santa Croce (14 settembre). | |
| BIANCO |
- Sette dolori della Beata Vergine Maria (15 settembre); - Sacratissimo Rosario della Beata Vergine Maria (7 ottobre); - Maria Santissima Madre di Dio (11 ottobre); - Festa di Nostro Signore Gesù Cristo Re (ultima domenica d'ottobre); - Ognissanti (1° novembre). |
|
| NERO | - Commemorazione di tutti i fedeli defunti (2 novembre). |
 Coltre.
Coltre. Drappo usato durante la cerimonia funebre per ricoprire il feretro o la parte del catafalco a forma di feretro. È di colori funerari, decorato da motivi funebri e spesso da una grande croce.

 Conchiglia battesimo con saliera e Oli Santi.
Conchiglia battesimo con saliera e Oli Santi. Corredo di oggetti utilizzati per la somministrazione del battesimo. È composto di una conchiglia per la raccolta dell'acqua nella somministrazione del battesimo, una saliera battesimale che contiene il sale benedetto da imporre sulle labbra del battezzando durante il rito e due vasetti per contenere gli Oli Santi (Olio dei catecumeni e Santo Crisma) anch'essi usati durante la somministrazione del sacramento.




 Confessionale.
Confessionale. Nelle chiese cattoliche è il luogo nel quale si amministra il sacramento della riconciliazione, il nucleo fondamentale prevede la postazione del sacerdote e quella del penitente (che spesso è un inginocchiatoio), tra il penitente ed il confessore può esservi anche una grata.

 Conopeo.
Conopeo. Con il termine conopeo si intende generalmente la copertura in tessuto rimovibile del tabernacolo nelle chiese cattoliche. L'origine della parola é da ricercare nel latino "conopeum" e nel greco "konopèion", con il significato originario di "zanzariera".
Il tipo di conopeo più conosciuto è quello che copre il tabernacolo e può essere di varie forme:
- può coprire integralmente il tabernacolo;
- può coprire solo la parte anteriore del tabernacolo (soluzione più diffusa);
- può coprire solo la parte intorno all'anta del tabernacolo.
Un altro tipo di conopeo é quello utilizzato a copertura della Pisside, per il quale valgono le stesse regole circa i colori liturgici sopra descritte.


 Corporale.
Corporale. DEFINIZIONE.
È un quadrato di tela sul quale, durante la celebrazione eucaristica, si posa la patena con l’ostia, il calice e l’ostensorio nelle funzioni in cui è previsto. Il corporale simboleggia la Sindone nella quale fu avvolto il corpo di Gesù; indica anche la Chiesa e, dal modo in cui in antico era piegato, le tre virtù teologali (Fides, Spes et Caritas - Fede, Speranza e Carità) e le quattro cardinali (prudentia-prudenza, iustitia-giustizia, fortitudo-fortezza e temperantia-temperanza).
È di lino e non reca particolari ricami a rilievo per non complicare l’appoggio dei vasi sacri. Ha il lato di cinquanta centimetri ed è solitamente inamidato; il suo colore è sempre bianco.
STORIA.
Un decreto di Papa Silvestro I dice che il sacrificio della Messa non deve essere offerto sopra un banco di seta o colorato, ma sopra un telo di lino, produzione della terra, come quello in cui fu avvolto il corpo del Signore nel sepolcro.
Nel tardo medioevo vi è qualche rara eccezione per la seta così come dice un inventario in San Pietro in Vaticano datato 1475: “Un piccolo corporale di seta bianca con un fiore ricamato d’oro”.

 Cotta.
Cotta. DEFINIZIONE.
E’ una veste corta che serve per l’amministrazione dei Sacramenti ed in altre circostanze liturgiche. Normalmente di tela bianca, ha una lunghezza che di poco si scosta dal ginocchio, con maniche larghe e corte; può essere ornata di merletti all’orlo inferiore e alle maniche, oppure è decorata con ricami, comunque disegnati alle estremità. Sul davanti ha uno sparato che si chiude con fettucce o con un gancio di metallo argentato, mentre nel rito ambrosiano è tutta chiusa attorno al collo.
Il suo significato simbolico si ricollega alle parole che un tempo il Vescovo diceva mentre l’imponeva ai chierici, ovvero: “Ti rivesta il Signore dell’uomo nuovo, che fu creato ad immagine di Dio, in giustizia e vera santità”.
Nella sua abbondante larghezza si può anche riconoscere l’amore del Padre e del prossimo che deve animare chi ne è rivestito e poiché si indossa sopra l’abito ordinario, simbolo dell’uomo peccatore, può simboleggiare la carità che si estende e di fatto copre i peccati.
STORIA.
La cotta si riscontra per la prima volta nell’XI secolo in Spagna, nel nord della Francia e in Inghilterra, ed è soprattutto diffusa grazie alla fondazione, nel sec. XI, dell’Ordine dei Canonici Regolari di Sant’Agostino che l’usava come veste corale oltre che come paramento liturgico.
All’inizio scende fino ai piedi poi, dal sec. XIII, si indossa come veste da coro ed è usata anche da chi serve all’altare. Alcuni autori la indicano come sopravveste festiva dei chierici inferiori.
Già nel sec. XII viene indicata con il nome di “superpelliceum” perché nei paesi nordici era indossata sopra vestiti di pelliccia; nel sec. XVI si inizia ad ornarla di pizzi che si diffusero in tono maggiore nel sec. XVIII, mentre nel Medioevo era ricca di pieghe per tutta la lunghezza e senza ornamenti.
La forma della cotta fu regolata dalle prescrizioni dei Sinodi, come pure il tipo di tessuto da usare per confezionarla. Oggi è adottato un disegno più o meno comune dappertutto, eseguito su tessuto di tela di lino bianca.

 Credenza.
Credenza. È una mensola posta al lato dell’altare, realizzata in legno o raramente in marmo. Era ed è destinata ad ospitare i Vasi Sacri necessari per le celebrazioni della Messa nelle chiese, nelle cattedrali durante le funzioni capitolari, e in presenza del Vescovo pontificante serviva per esporre il suo corredo da altare.
Occasionalmente era dotata di una alzata per meglio mostrare la suppellettile.
Nel caso di un semplice ripiano per appoggiare le ampolline e/o il calice, la credenza viene talvolta chiamata "Abaco".
La credenza di sacrestia è invece un mobile molto più ampio che viene usato per scopi pratici e per utilità funzionale del corredo liturgico.
L’origine è con ogni probabilità domestica, traendone spunto dal mobilio delle case civili già in uso nella antica Roma.




 Crepitacolo o Crotalo (detto anche raganella o troccola).
Crepitacolo o Crotalo (detto anche raganella o troccola). Il crepitacolo o crotalo (in latino crepitaculum o anche crotalum), è uno strumento liturgico in legno che sostituisce il campanello durante i funerali. Dal Giovedì al Sabato Santo, è usato in luogo degli stessi campanelli (in Chiesa) e campane, in particolare durante l'azione liturgica del Venerdì Santo (Liturgia dei Presantificati). Lo strumento, che corrisponde generalmente all'idiofono musicale detto raganella, rende un suono lugubre ed ingrato, particolarmente adatto alle liturgie penitenziali.

 Croce d'altare.
Croce d'altare. Il posto centrale e d’onore dell’altare ospita la croce, poiché questa è segno del supremo Sacrificio di Cristo. Tale ornamento è comunque obbligatorio durante la celebrazione della Messa; compare nell’uso liturgico verso il sec. XI-XII e fino all’epoca rinascimentale è spesso priva del Crocefisso.
Anche il Messale di S. Pio V prescriveva semplicemente una croce (crux), ma il Caeremoniale Episcoporum specificava “cum immagine SS.mi Crucifixi”.
Nel periodo delle basiliche è molte volte rappresentata a disegno nel mosaico della conca absidale, adorna di gemme; è la crux gemmata, elevata sul monte fra simboli liturgici.
Nella età romanica la croce dell’altare è poggiata sopra la tavola orizzontale dietro l’altare stesso, posta tra i candelieri ed è spesso di notevoli dimensioni.
È comunemente di metallo fuso o di legno rivestito di lamine metalliche con lavorazioni a sbalzo e con forma quasi esclusivamente latina.
In periodo gotico la croce, pur determinata nella classicità della forma, assume dimensioni di supporti architettonici, ed in quello rinascimentale offre spunto per ulteriori concessioni di natura decorativa.
Il barocco propone una croce d’altare in maggiore sintonia con la linea dei candelabri che la affiancano e, nella morbidezza delle linee, la presenta con accentuata priorità su tutto il corredo liturgico.
Gli odierni dettami prescrivono sempre la presenza del Crocefisso al centro della croce.


 Croce pettorale.
Croce pettorale. E' indossata sul petto dai Prelati e dal medesimo Pontefice ed è sorretta da una catena d'oro (se indossata sopra la veste talare) oppure da un cordone oro per il Papa, rosso e oro per i Cardinali, verde e oro per i Vescovi (se indossata sopra l'abito corale cioè talare con rocchetto e mozzetta). Normalmente la croce è di metallo prezioso e anche gemmata.
La croce destinata ai Prelati o al Pontefice ha un piccolo astuccio all'incrocio dei bracci, nel cui interno si collocano le reliquie dei santi o un piccolo frammento della croce di Cristo.
Nel rito romano la Croce pettorale viene portata di norma sotto l'abito liturgico (pianeta o casula), ma negli utlimi anni si è sempre più esteso l'uso di portarla "all'ambrosiana", cioè sopra i paramenti. A questo proposito, la Congregazione per il Culto Divino ha dato un responsum positivo in merito, pubblicato a pag. 280 del vol. XXIII di Notitiae, rivista ufficiale della Congregazione.
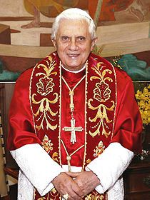




 Crocifero.
Crocifero. Secondo un antico uso cristiano la croce, come vessillo di Cristo, precede tutte le sacre processioni dei fedeli, e l'ufficio di portarla è specialmente affidato al suddiacono.

 Crotalo o Crepitacolo (detto anche raganella o troccola).
Crotalo o Crepitacolo (detto anche raganella o troccola). Il crotalo o crepitacolo (in latino crotalum o anche crepitaculum), è uno strumento liturgico in legno che sostituisce il campanello durante i funerali. Dal Giovedì al Sabato Santo, è usato in luogo degli stessi campanelli (in Chiesa) e campane, in particolare durante l'azione liturgica del Venerdì Santo (Liturgia dei Presantificati). Lo strumento, che corrisponde generalmente all'idiofono musicale detto raganella, rende un suono lugubre ed ingrato, particolarmente adatto alle liturgie penitenziali.

D
 Dalmatica.
Dalmatica. È il paramento che contraddistingue il diacono e nell’antichità, prima ancora di essere un parato liturgico, fu veste civile romana. È una tunica di media lunghezza, con manica larga, che il diacono porta sopra il camice e la stola, nell’assistenza alla celebrazione della Messa e in altre particolari funzioni religiose. Nel Rito Ambrosiano il diacono porta la stola sopra la dalmatica.
La dalmatica è il simbolo della salute, della gioia e della giustizia. Indica ancora la novità dell’uomo al servizio di Dio. Alcuni autori, invece, la considerano come il simbolo della Passione e della Morte di Cristo.
Le misure correnti sono le seguenti: lunghezza 115 [cm]; larghezza alle spalle 50 [cm]; larghezza al fondo 100 [cm]. È necessario aggiungere che i colori della dalmatica sono originariamente identici a quelli della casula (o pianeta) e del piviale che, con la tunicella (dalmatica indossata dal suddiacono), compongono il parato solenne.
Il vescovo può portare nelle celebrazioni solenni, sotto la casula (o pianeta), sia la dalmatica che la tunicella, ciò ad indicare la pienezza del sacerdozio.
STORIA.
Come veste liturgica è adottata a Roma verso la metà del secolo IV e introdotta da Papa Silvestro. In un primo tempo usata solo dal Pontefice, venne successivamente concessa ai diaconi nella sola urbe romana.
Nei secoli V e VI la concessione si allarga ai vescovi, che con essa manifestano il completamento gerarchico ecclesiale ed è in uso anche fuori Roma.
In Italia conserva la lunghezza originale fino al secolo XII, per accorciarsi un poco in quello successivo; ai lati ha grandi sparati, chiusi per comodità da cordoni con nappe.
Nei secoli XVI e XVII la dalmatica assume la definitiva forma che ancora oggi mantiene.
La seguente preghiera, tratta dal Messale del 1962, viene recitata dal Vescovo mentre indossa la dalmatica. Può essere utilizzata anche dal diacono.
"Indue me, Dómine, induménto salútis et vestiménto lætítiæ; et dalmática iustítiæ circúmda me semper." (Traduzione: Coprimi, o Signore, con l'indumento della salvezza e il vestito della letizia; e circondami sempre con la dalmatica della giustizia).





E
 Elevazione Eucaristia.
Elevazione Eucaristia. Rito della Messa con cui il celebrante innalza le specie sacramentali per esporle all'adorazione dei fedeli.
Ad esempio, la consacrazione Eucaristica, che avviene attraverso il tempo centrale della Messa, detta Liturgia Eucaristica, nel quale, elevando le Sacre Specie e pronunciando le parole di Gesù nell'Ultima cena, si ottiene, per grazia di Dio, che il pane ed il vino offerti dalla comunità diventino Corpo e Sangue di Cristo, secondo il mistero che la teologia cattolica ha denominato transustanziazione, o transubstanziazione, ovvero il cambiamento "oltre la sostanza" (trans-substantia) del pane e del vino in Corpo e Sangue di Cristo.
Secondo la Chiesa Cattolica, nelle specie consacrate del pane e del vino, dette anche Santissimo Sacramento dell'Altare, vi è la presenza reale di Cristo stesso, in Corpo, Sangue, Anima e Divinità. In particolare, del pane e del vino restano solo le specie (dette anche apparenze o accidenti), ossia la forma, l'odore, il sapore, il colore, il peso, ecc.. La continua riattualizzazione di questo mistero avviene, mediante l'azione dello Spirito Santo, attraverso il sacerdote che agisce in persona Christi.




 Epistola.
Epistola. Nella Chiesa Cattolica, nella liturgia della Messa, è il brano delle Lettere degli Apostoli o di qualche altro libro della S. Scrittura che il sacerdote legge prima del Vangelo. L'epistola può riferirsi ad un brano degli Atti degli Apostoli od a qualche altro libro della S. Scrittura, ma mai ai quattro Vangeli. Infatti le epistole sono lette fra il Gloria in excelsis Deo e la lettura del Vangelo. Il corrispondente canto Gregoriano ha uno speciale tono (tonus epistolae).
 Esequie.
Esequie. L'antichissima tradizione di suffragare con particolari preghiere l'anima dei morti è stata ininterrottamente sostenuta dalla Chiesa e osservata quasi istintivamente dalla pietà dei parenti dei defunti. Il Rituale Romano parla delle esequie al titolo VI. Le esequie strettamente parlando cominciano con le preghiere stabilite per l'ingresso del defunto in chiesa e finiscono con quelle che ne accompagnano l'uscita dalla medesima. Nello svolgimento delle esequie, pur avendo un posto di preminenza la celebrazione della Messa e la recita dell'Ufficio divino che ne sono la parte principale, non mancano altre preghiere tra le quali quelle che accompagnano l'ingresso del defunto in chiesa e la sua uscita.
Nella tradizione cattolica, il funerale si divide generalmente in tre parti principali:
- La "contemplazione" o "veglia" durante la quale il corpo del defunto è esposto nella cassa da morto o bara. Partecipano alla veglia funebre gli amici e i parenti, e normalmente si tratta di una partecipazione non rigidamente codificata. La veglia termina con una preghiera comune, di norma il Santo Rosario, recitato anche da un sacerdote in chiesa o nell'abitazione del defunto.
- La cerimonia funebre. Il sacerdote officia la Messa esequiale in chiesa durante la quale la bara viene aspersa con l'acqua benedetta ed incensata. Al termine di questa, in alcune particolari occasioni un amico o un parente della persona scomparsa, può leggere un elogio funebre riguardo alla vita e alle attività del defunto (spesso si tende a scoraggiare l'uso degli elogi funebri durante il funerale vero e proprio).
- La cerimonia comprende di solito anche il pio officio della sepoltura, che segue il funerale e si tiene di solito a fianco alla tomba o cappella, nelle vicinanze del luogo ove il corpo della persona deceduta verrà sepolto. Spesso il percorso dalla chiesa al cimitero è seguito, maggiormente a piedi, dai partecipanti al funerale o da alcuni di questi. Al rito può seguire la presentazione delle "condoglianze" agli intimi del defunto (in genere i familiari e gli amici più stretti).
La Chiesa Cattolica, ai sensi del canone 1184 del Codice di diritto canonico, si riserva il diritto di negare il rito delle esequie:
- qualora il defunto sia notoriamente apostata, eretico, scismatico o abbia provveduto a cancellare gli effetti civili del battesimo;
- qualora si tratti di peccatori manifesti, le cui esequie darebbero pubblico scandalo dei fedeli.
La negazione delle esequie è applicabile se prima della morte i defunti non danno alcun segno di pentimento.

 Esposizione del Santissimo Sacramento.
Esposizione del Santissimo Sacramento. Rito, con il quale si espone all'adorazione dei fedeli l'Ostia consacrata, o scoperta nell'ostensorio o racchiusa nella pisside. L'esposizione, che è sempre seguita dalla benedizione, si distingue in pubblica e privata, secondo che si fa con l'ostensorio o con la pisside. L'esposizione pubblica è solenne o solennissima ed ha una certa durata, mentre l'esposizione privata è quella propria delle Quarantore.


 Eucaristia.
Eucaristia. Per i cristiani l'Eucaristia è il Sacramento istituito da Gesù durante l'Ultima Cena, alla vigilia della sua Passione e Morte.
Nell'Ultima Cena, secondo il racconto dei vangeli, Gesù distribuì ai suoi discepoli il pane ed il vino come suo Corpo e suo Sangue, offerti come Sacrificio per la salvezza degli uomini, incaricandoli di fare lo stesso in sua "memoria". La Chiesa Cattolica, dunque, fin dalla sua origine, celebra l'atto sacramentale dell'Eucaristia come uno degli impegni lasciatigli da Gesù stesso, suo Dio fondatore e salvatore. L'Eucaristia è l'azione sacrificale durante la quale il sacerdote (che agisce in persona Christi) offre il pane e il vino a Dio, che, per opera dello Spirito Santo, diventano realmente il Corpo ed il Sangue di Cristo (transustanziazione), lo stesso Corpo e lo stesso Sangue offerti da Gesù stesso sulla croce.
L'altare è la croce sul quale in ogni Messa si riattualizza lo stesso e identico Sacrificio (in questo caso incruento) della stessa vittima: l'Agnello pasquale, cioè Gesù, cosicché chiunque partecipa alla Santa Messa è esattamente come se fosse dinnanzi alla crocifissione di Cristo e alla Sua Passione.
Con la distribuzione della Comunione, in cui sono presenti il Corpo, il Sangue, l'Anima e la Divinità di Gesù, i fedeli entrano in comunione con Dio e pregustano i suoi beni, chiedono espiazione dei propri peccati, implorano la benedizione di Dio e chiedono il suffragio per le anime dei defunti.


 Evangeliario.
Evangeliario. È il libro che contiene il testo dei Vangeli che si usa nel corso delle funzioni liturgiche.
L’Evangeliario ha una copertina molto ricca di ornamenti che riproducono principalmente le immagini simboliche dei quattro evangelisti, rispettivamente rappresentati da un’aquila per san Giovanni, l’angelo per san Matteo, il leone per san Marco, il bue per san Luca.


 Exultet.
Exultet. L'Exultet è un canto liturgico proprio della Chiesa Cattolica che viene cantato la notte di Pasqua nella solenne Veglia Pasquale, da un diacono o un cantore. Con esso si proclama la vittoria della luce sulle tenebre, simbolizzata dal cero pasquale che viene acceso, ed annuncia la risurrezione di Cristo ed il declamante invita tutta l'assemblea a gioire per il compiersi della profezia del mistero pasquale, ripercorrendo nel canto i prodigi della storia della salvezza.
Dal punto di vista stilistico si tratta di un preconio, ovvero, secondo l'etimologia latina di praeconium, di un testo poetico di annuncio solenne o di encomio e lode solenne. Per questo motivo viene chiamato anche preconio pasquale (praeconium paschale) o laus cerei.
L'elevazione della forma e del contenuto fa di esso un autentico capolavoro.

F
 Falda.
Falda. Veste pontificale propria del Papa che veniva indossata esclusivamente nelle solenni funzioni sopra l’abito talare.
È di seta bianca ed ha uno lungo strascico sia davanti che dietro, sostenuto dai Protonotari apostolici e dai Principi assistenti al Soglio.
Oggi la falda non è più usata benchè, di fatto, non sia mai stata abolita.


 Faldistorio.
Faldistorio. Il faldistorio è uno speciale tipo di sedia usato nella liturgia cattolica dai Vescovi o alti prelati durante cerimonie particolari. Il termine deriva dal latino medioevale faldistorium.
La sedia è pieghevole, provvista di braccioli (ma sprovvista di schienale fisso), di un sedile dotato di cuscino ed è tradizionalmente rivestita di seta rossa. Solitamente, è coperta di stoffa del colore liturgico del giorno. Viene adoperata quando non è possibile servirsi del Trono episcopale, seppur dopo la Riforma liturgica l'uso di tale sedia sia divenuto piuttosto raro. Il suo uso è prescritto per la somministrazione del Battesimo e del sacramento dell'Ordine ed in altre occasioni solenni quali la benedizione dell'Olio Santo nella Messa Crismale del Giovedì Santo, nella cerimonia del Venerdì Santo, ed in genere in tutte quelle situazioni nelle quali la posizione del Vescovo celebrante risulta laterale rispetto a quella dell'altare ed impedisce quindi l'utilizzo della Cattedra episcopale. Viene posto davanti alla gradinata d'altare dal lato dell'Epistola. Esso viene anche usato a modo di appoggio delle braccia del celebrante quando si inginocchia davanti. Il materiale costruttivo può essere di varia natura, come ad esempio il legno, il ferro e l'avorio.


 Fanòne.
Fanòne. Il fanòne papale è un paramento liturgico riservato al Papa ed usato nella Messa pontificale.
Si tratta di un ornamento omerale: una doppia mozzetta circolare di sottilissima seta tessuta a strisce parallele di colore rosso, bianco, giallo-oro ed amaranto. Viene indossato in modo che la parte inferiore sia sotto la stola e la superiore sopra la pianeta o la casula. Per praticità le due mozzette, una volta unite nel girocollo, vennero staccate e indossate separatamente ed unite tramite un'abbottonatura.
Oggi, dopo la riforma liturgica, il fanòne è utilizzato più raramente. Gli ultimi pontefici ad aver usato il fanòne sono stati il Santo Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI.
Il simbolismo del fanòne rappresenta lo scudo della fede che protegge la Chiesa Cattolica, rappresentata dal Papa. Le fasce verticali di colore oro e argento, rappresentano l'unità e l'indissolubilità della Chiesa latina e orientale.


 Faro.
Faro. È un globo ricoperto di bambagia che viene appeso all'ingresso del presbiterio nelle feste dei martiri. Il sacerdote gli dà fuoco all'inizio dell'Eucaristia come segno della vita consumata dall'amore di Cristo nel momento del martirio.

 Fascia.
Fascia. È una striscia di stoffa, normalmente di seta per i cardinali e per i nunzi apostolici, per i vescovi e i prelati, di lana per gli altri ecclesiastici, che cinge in vita l’abito talare del clero ed è distintiva del grado gerarchico: nera per i sacerdoti, paonazza per i prelati, porpora per i cardinali, bianca per il Papa, il quale ha il privilegio di far apporre alla parte terminale delle bande che cadono sul davanti al lato sinistro, il proprio stemma.
La fascia, che terminava con vistosi fiocchi del medesimo colore, ora è completata da una frangia. La fascia per i cardinali e per il Papa è di seta marezzata, il paonazzo marezzato è solo per i nunzi apostolici.



 Feretro.
Feretro. Il feretro o bara, popolarmente detta cassa da morto, è un contenitore usualmente in legno e zinco, o anche di altro materiale, atto alla conservazione, al trasporto e alla tumulazione di un defunto. La bara può essere molto semplice, o anche molto elaborata. Vi sono bare imbottite con cuscini in seta, ed altre in legno grezzo. Durante la cerimonia funebre il feretro viene ricoperto dalla coltre, drappo di colore nero, decorato da motivi funebri e spesso da una grande croce.


 Ferraiolo.
Ferraiolo. È un ampio mantello di seta o di tessuto leggero, di vario colore in relazione a chi lo indossa; nero per i sacerdoti, paonazzo per i vescovi e arcivescovi, porpora per i cardinali. Il Papa non indossa il ferraiolo.
Si usa sopra la talare solo in particolari occasioni, quando viene indossato a completamento dell’abito ordinario.
Il mantello si limita a ricoprire la parte posteriore, scendendo fino al tallone da un ampio colletto con taglio a carrè.
Oggi il ferraiolo è poco usato se non dagli addetti alla diplomazia vaticana in cerimonie ufficiali.


 Ferula.
Ferula. La ferula è il pastorale che viene portato durante le celebrazioni dal Papa. È simile al bastone pastorale del vescovo ma, a differenza di quest'ultimo, ha all'estremità una sfera di metallo prezioso sormontata, a seconda del tipo, da una croce (di diversa tipologia) o da un crocefisso.
Anziché essere ricurvo, come il comune pastorale episcopale, è dotato, all'estremità superiore, di una croce. A lungo, come visibile nelle rappresentazioni artistiche ed iconografiche, è stata prerogativa papale una ferula con croce tripla, ossia un bastone con all'estremo una croce a tre braccia. Una ferula di tale tipologia, appartenente a Papa Leone XIII e da egli utilizzata per l'apertura della Porta Santa in occasione del Giubileo del 1900, è stata usata per l'ultima volta dal Santo Papa Giovanni Paolo II in occasione del Giubileo del 1983.
L’uso della ferula non ha mai fatto parte della liturgia papale, tranne in alcune occasioni come l’apertura della Porta Santa e le consacrazioni delle chiese, nelle quali il Papa prendeva la ferula per bussare per tre volte alla porta e per disegnare l'alfabeto latino e greco sul pavimento della chiesa. Generalmente, infatti, tali croci erano abitualmente utilizzate come croci astili in capo al corteo papale, come simbolo pontificale. È dal pontificato di Paolo VI che la ferula è entrata a pieno titolo nell'ambito della liturgia e delle celebrazioni papali, diventando l'analogo della pastorale per i vescovi.
Nel periodo medievale, il bastone pastorale del Vescovo era anche una verga di legno ricoperta di velluto rosso che veniva consegnata in segno di autorità. In epoca successiva quel bastone fu riservato solo alla persona del Papa che lo riceveva nel giorno della sua incoronazione a testimonianza della sua assoluta supremazia sulle corti temporali.
A partire dal XIII sec., la ferula fu segno distintivo del Cardinale che aveva l’incarico di reggere le sorti della Sede Apostolica durante la vacanza del pontificato, per cui il Cardinale Camerlengo aveva la ferula come simbolo di comando durante l’interregno tra un Papa e l’altro. La ferula è stata usata anche in tempi recenti allo stesso scopo dal Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa.
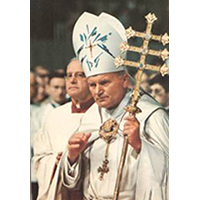 |
 Santo Papa Giovanni Paolo II - Karol Wojtila Oristano, Venerdì, 18 Ottobre a.d.S. 1985. Foto: Bruno Atzori |
 |
 |
 Fiocco.
Fiocco. È un ornamento usato per decorare gli abiti liturgici o quelli ordinari del clero; in questo caso era collocato a completamento della fascia portata alla vita.
Il fiocco si usa anche come decoro della berretta clericale (tricorno) il cui colore indica il grado gerarchico di chi la indossa; il fiocco nero su berretta nera per i sacerdoti; il fiocco paonazzo su berretta nera per i monsignori, paonazzo su berretta paonazza per i vescovi e gli arcivescovi.
Un fiocco del colore liturgico del giorno è collocato ad ogni estremità del cingolo.




 Fistola.
Fistola. È una piccola cannula aurea con la quale si sorbiva il vino consacrato nel calice al momento della comunione.
In seguito la fistola fu riservata all’uso delle Messe celebrate dal Pontefice e utilizzata dal Sacrista del Palazzo Apostolico che assistendo alla funzione papale, prima dell’offertorio, assumeva una piccola quantità di vino dal calice. Questo rito avveniva mentre il coro della Cappella Sistina cantava Terza ed era una forma di garanzia sull’accertamento della qualità del vino usato per la celebrazione eucaristica officiata dal Sommo Pontefice.



 Flabelli.
Flabelli. Era un ornamento molto usato durante le cerimonie solenni presiedute dal Papa. Il flabello era composto da un’asta di legno stuccato in oro, alla cui sommità era inserito un grande ventaglio di piume di struzzo bianche tenute insieme da un supporto sul quale era riprodotta l’arma araldica della Santa Sede, cioè le chiavi incrociate.
Anche nelle processioni di trasferimento del Pontefice dal Palazzo Apostolico alla basilica di San Pietro, ai lati della sedia gestatoria sulla quale stava assiso il Papa, venivano portati due flabelli la cui origine era riconducibile allo sfarzo della corte pontificia rinascimentale.
Oggi l’uso dei flabelli è stato abrogato e gli ultimi due, usati ancora durante il pontificato di Paolo VI, sono conservati presso la cattedrale di Roma, cioè la Basilica di San Giovanni in Laterano.
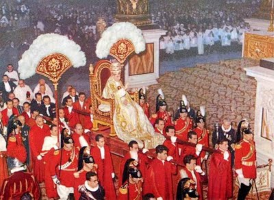

 Fonte battesimale.
Fonte battesimale. Il fonte battesimale è una vasca marmorea (ma talvolta anche in metallo) in cui viene raccolta l'acqua, ed è presente nei battisteri o nelle chiese: tale struttura è funzionale all'amministrazione del sacramento del battesimo, che può avvenire per infusione dell'acqua sul capo (forma più diffusa) o per immersione.
Il fonte battesimale è solitamente sormontato da una copertura metallica a cupola.


 Forbici.
Forbici. Tradizionale strumento da taglio che veniva usato per le cerimonie di tonsura del clero.
Particolari forbici, ricche di ornamenti, furono elaborate per i Pontefici, i quali le usavano in occasione della Consacrazione Episcopale dei Vescovi oppure usate sul capo dello stesso Papa in occasione della tonsura che il Sacrista del Palazzo Apostolico compiva nei confronti dello stesso Pontefice.
Forbici in argento furono eseguite per l’uso della rifilatura della circonferenza delle ostie da inserire nella teca dell’ostensorio, naturalmente prima della consacrazione.

 Formale o Razionale (detto anche Pettorale).
Formale o Razionale (detto anche Pettorale). Chiamato anche razionale o pettorale, è una lamina di metallo, d'oro o d'argento, gemmata, della grandezza di una mano, che si porta sul petto dove si ferma ed affibia il piviale dei vescovi nella propria diocesi.
Al presente il Papa ha tre formali diversi: uno di perle che usa quando porta la mitra a lama d'argento, ossia nei funerali e nelle domeniche di Avvento e Quaresima (Da notare che le pigne di perle sono disposte in triangolo). Il secondo, comune, che usa in tutte le funzioni, eccettuati i Vespri e le Messe pontificali, quando cioè il Papa usa la mitra di lama d'oro; ed infine il prezioso che usa in tutte le funzioni più solenni e in tutti i Vespri e Messe pontificali, quando cioè mette la mitra preziosa. Questi due hanno la stessa forma: la lamina di forma ovale rappresenta lo Spirito Santo sotto forma di colomba raggiante, decorata di perle e di una guida di frondi di vite con grappoli d'uva, tra cui sono disposte in giro dodici pietre preziose: differiscono tra loro solo per la ricchezza e la varietà delle pietre.
Da notarsi infine il formale che si mette al piviale della statua di S.Pietro nella Basilica Vaticana il giorno della sua festa: è una lamina di argento dorato avente al centro una colomba dalle ali spiegate con raggi, rappresentanti lo Spirito Santo.


 Funzioni sacre.
Funzioni sacre. (Funzione, da fungor, cioè esercizio, esecuzione) sono le funzioni della potestà di Ordine, che per istituzione di Cristo o della Chiesa sono ordinate al culto divino e che si possono compiere dai soli chierici.
G
 Galero.
Galero. Il galero è un cappello di forma rotonda con un diametro variabile dai 60 ai 100 [cm], di vari colori con un sottogola e nappe pendenti dalle falde.
Si distinguono tre tipi di Galero:
-
Il galero usuale.
Il galero usuale è sempre nero tanto che per i cardinali che per i vescovi o prelati. E' ornato da corde di seta con due fiocchi alle estremità, o da un nastro largo 4 [cm]. Le cordicelle sono rosse e dorate per i cardinali, verdi e dorate per i patriarchi, verdi per gli arcivescovi e i vescovi, rosa per i protonotari apostolici o violacee per gli altri prelati della Curia Romana. E' parte sia dell'abito prelatizio sia dell'abito piano, e si deve usare obbligatoriamente quando il prelato, in mozzetta o in mantelletta, si reca ad una chiesa per una funzione liturgica, o quando da essa esce; giunto alle porte della chiesa consegna il galero ad un suo familiare laico ed assume la berretta. -
Il galero pontificale.
Il galero pontificale si suddivide in due categorie:
- Il galero pontificale usuale quanto alla forma è simile a quello comune, ed ha una tesa di 15 [cm], ma ornato di corde e fiocchi che si legano sotto il mento. E' rosso per i cardinali, ed anche le corde ed i 15 fiocchi sono rossi; quello dei vescovi è nero all'esterno e verde all'interno, con cordicelle e 6 o 10 fiocchi verdi a seconda che sia vescovo od arcivescovo. Per i protonotari è nero all'esterno e rosa all'interno, con corde e 6 fiocchi rosa. Si usa con la cappa magna e il cappuccio sul capo. Quando il prelato non lo indossa, va portato davanti a lui in processione da un familiare laico. Al decesso del prelato, va posto ai sui piedi, e poi andrà lasciato appeso in alto al di sopra della sua tomba (tranne per i Cardinali ed i protonotari, che adibiscono a questo scopo il galero pontificale simbolico).
- Il galero pontificale simbolico è quello imposto ai Cardinali in concistoro. E' rosso e piatto con una piccola coppa, ha corde e 15 fiocchi rossi. Veniva usato, prima di venir abrogato da Paolo VI, solo per il concistoro, e per l'utilità funebre di cui sopra. Ce n'è uno simile, utilizzato nella creazione dei protonotari apostolici numerari e ad instar: in questo caso è di lana nera al di sopra, e di seta color rubino al di sotto, e rubino sono anche le cordicelle coi 6 fiocchi.
-
Il galero araldico.
Il galero araldico è l'insegna principale dei Cardinali, dei protonotari, dei vescovi e degli altri prelati; ai cardinali ed ai protonotari è consegnato nella loro creazione. La forma è uguale per tutti, cambia solo il colore ed il numero di fiocchi. Per i cardinali è rosso con 15 fiocchi, per gli arcivescovi è verde con 10 fiocchi, per i prelati di fiocchetto si usa galero violaceo e 10 fiocchi color rubino; per i vescovi ed gli abbati o prelati nullius, cappello e 6 fiocchi verdi; per i protonotari numerarii, sovrannumerarii e ad instar, e per coloro che godono dei loro stessi privilegi, cappello violaceo e 6 fiocchi rubino.


 Gigliuccio.
Gigliuccio. Costituisce una variante del pizzo per la decorazione degli abiti liturgici.






 Giubileo.
Giubileo. Nella tradizione cattolica il Giubileo è un grande evento religioso. E' l'anno della remissione dei peccati e delle pene per i peccati (indulgenza plenaria), è l'anno della riconciliazione tra i contendenti, della conversione e della penitenza sacramentale e, di conseguenza, della solidarietà, della speranza, della giustizia, dell'impegno al servizio di Dio nella gioia e nella pace con i fratelli. L'anno giubilare è soprattutto l'anno di Cristo, portatore di vita e di grazia all'umanità.
Il Giubileo ha origine dalla tradizione ebraica che fissava, ogni 50 anni, la celebrazione di un anno particolare che comportava il riposo della terra, la restituzione delle terre confiscate agli antichi proprietari, la remissione dei debiti e la liberazione degli schiavi, questo affinché non ci fossero il troppo ricco od il troppo povero. Dunque, le sue origini si ricollegano all'Antico Testamento; la legge di Mosé aveva fissato per il popolo ebraico un anno particolare: "Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nel Paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo; non farete né semina, né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate. Poiché è il giubileo, esso vi sarà sacro; potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi. In quest'anno del giubileo, ciascuno tornerà in possesso del suo" (Libro del Levitico). La tromba con cui si annunciava l'inizio del Giubileo era un corno d'ariete, che in ebraico si dice "Yobel" (caprone, in riferimento al corno di montone utilizzato nelle cerimonie sacre), da cui deriva la parola "Giubileo". Ma l'anno giubilare è soprattutto l'anno di Cristo; nel Nuovo Testamento Gesù si presenta come Colui che porta a compimento l'antico Giubileo, essendo venuto a "predicare l'anno di grazia del Signore" (Isaia).
Il Giubileo, comunemente, viene detto "Anno Santo", non solo perché si inizia, si svolge e si conclude con solenni riti sacri, ma anche perché è destinato a promuovere la santità di vita. E' stato istituito infatti per consolidare la fede, favorire le opere di solidarietà e la comunione fraterna all'interno della Chiesa e nella società, richiamare e stimolare i credenti ad una più sincera e coerente professione di fede in Cristo unico Salvatore.
Il Giubileo può essere: ordinario, se legato a scadenze prestabilite; straordinario, se viene indetto per qualche avvenimento di particolare importanza. Gli Anni Santi ordinari che sono stati celebrati sono 26 con quello del 2000. La consuetudine di indire Giubilei straordinari risale al XVI secolo: la loro durata è varia, da pochi giorni ad un anno. Gli ultimi Anni Santi straordinari dello scorso millennio sono quelli del 1933, indetto da Pio XI per il XIX centenario (ossia 1900 anni) della Redenzione, e del 1983, indetto da Giovanni Paolo II per i 1950 anni della Redenzione. Nel 1987 Papa Giovanni Paolo II ha indetto anche un Anno Mariano.
Il primo Giubileo ordinario fu indetto nel 1300 da Papa Bonifacio VIII con la Bolla Antiquorum habet fida relatio. Con questa bolla si concedeva l'indulgenza plenaria a tutti coloro che avessero fatto visita trenta volte, se erano romani, e quindici se erano stranieri, alle Basiliche di San Pietro e San Paolo fuori le mura, per tutta la durata dell'anno 1300; questo Anno Santo si sarebbe dovuto ripetere in futuro ogni cento anni.
Dante Alighieri riferisce nella Divina Commedia che l'afflusso di pellegrini a Roma fu tale che divenne necessario regolamentare il senso di marcia dei pedoni sul ponte di fronte a Castel Sant'Angelo:
«come i Roman per l'essercito molto, l'anno del giubileo, su per lo ponte hanno a passar la gente modo colto, che da l'un lato tutti hanno la fronte verso 'l castello e vanno a Santo Pietro, da l'altra sponda vanno verso 'l monte».
Nel 1350 Papa Clemente VI, per parificare l'intervallo a quello del Giubileo ebraico, decise di accorciare la cadenza a 50 anni. In seguito l'intervallo fu abbassato a 33 anni da Urbano VI, periodo inteso come durata della vita terrena di Gesù, e ulteriormente ridotto a 25 anni durante i papati di Niccolò V e di Paolo II.
L'ultimo Anno Santo ordinario è stato il Grande Giubileo del 2000, mentre il prossimo sarà nel 2025.
Dal 28 giugno 2008 al 29 giugno 2009 Papa Benedetto XVI proclamò l'Anno Paolino, un Anno Santo straordinario, ossia uno speciale anno giubilare dedicato all'apostolo Paolo di Tarso, in occasione del bimillenario della nascita del santo (collocata dagli storici tra il 7 e il 10 d.C.).
Il 13 marzo 2015 Papa Francesco ha annunciato il Giubileo straordinario della misericordia.
Esattamente il Giubileo dura un anno più alcuni giorni, infatti inizia con il Natale precedente (25 dicembre) e termina con l'Epifania successiva (6 gennaio).
Il rito più conosciuto del Giubileo è l'apertura della Porta Santa: si tratta di una porta che viene aperta solo durante l'Anno Santo, mentre negli altri anni rimane murata. Hanno una Porta Santa le quattro basiliche maggiori di Roma: San Pietro, San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore. Il rito della Porta Santa esprime simbolicamente il concetto che, durante il Giubileo, è offerto ai fedeli un "percorso straordinario" verso la salvezza.
L'inizio ufficiale del Giubileo avviene con l'apertura della Porta Santa della basilica di San Pietro. Le Porte Sante delle altre basiliche vengono aperte nei giorni successivi. In passato la porta veniva smurata parzialmente prima della celebrazione, lasciando un diaframma che il Papa rompeva con un martelletto (martelletto per la Porta Santa); quindi gli operai completavano la demolizione. In occasione del Giubileo del 2000, invece, il Papa Giovanni Paolo II ha introdotto un rito più semplice e immediato: il muro è stato rimosso in anticipo lasciando solo la porta chiusa, che il Papa ha aperto spingendo i battenti.
Le Porte Sante rimangono aperte (a parte la normale chiusura notturna attraverso semplici e disadorne porte in legno) fino al termine dell'Anno Santo, poi vengono murate di nuovo nel rito di chiusura della Porta Santa.
Il rito di apertura e chiusura della Porta Santa secondo la tradizione prevede le seguenti azioni (Cerimoniale del XVI secolo):
Apertura della Porta Santa.
- Il Papa si veste in una stanza del Palazzo Apostolico e poi, insieme con i Cardinali, si reca nella Cappella Sistina. Qui ha luogo l’invio dei Cardinali legati per l’apertura delle altre porte e l’adorazione del SS.mo Sacramento.
- La processione si dirige alla Porta Santa al canto del Iubilate Deo o del Veni Creator Spiritus;
- il Papa dice l’orazione Deus qui per Moysem;
- poi riceve il martello, dice i versetti Aperite mihi portas iustitiæ e percuote tre volte il muro della Porta Santa;
- il Papa ritorna alla sede e dice l’orazione Actiones nostras;
- i muratori proseguono l’opera di apertura mentre si canta il Salmo Iubilate Deo omnis terra;
- il Pontefice genuflette sulla soglia della Porta Santa;
- il Papa passa per primo per la Porta Santa mentre il coro canta il Te Deum laudamus;
- la processione si dirige verso l’altare per la celebrazione dei Vespri.
- Il Papa entra processionalmente nella basilica attraverso la Porta Santa e presiede i Vespri nella basilica;
- il Pontefice invia quindi i Cardinali legati per la chiusura delle porte delle altre basiliche;
- segue la processione prima verso le reliquie e poi verso la Porta Santa mentre si eseguono canti adatti;
- si compie l'ostensione e adorazione delle reliquie del Sudario e della Lancia;
- il Papa esce per ultimo dalla Porta Santa;
- poi benedice le pietre e i mattoni;
- il Pontefice con la cazzuola spalma la calce sulla soglia della Porta Santa e vi mette sopra tre mattoni e alcune monete d’oro e d’argento;
- vengono quindi messi altri mattoni e poi i muratori, fuori e dentro la basilica, concludono l’opera di chiusura mentre il coro canta l’inno Cælestis Urbs Ierusalem;
- il Papa dice la preghiera Deus qui in omni loco e sale alla Loggia delle benedizioni per impartire la solenne Benedizione Apostolica.
Il segno della Porta Santa, che caratterizza così fortemente il Giubileo del 2000 evoca il passaggio che ogni cristiano è chiamato a compiere dal peccato alla grazia. Gesù ha detto: "Io sono la porta" (Gv 10, 7), per indicare che nessuno può avere accesso al Padre se non per mezzo Suo. Questa designazione che Gesù fa di se stesso attesta che Egli solo è il Salvatore inviato dal Padre. C’è un solo accesso che spalanca l’ingresso nella vita di comunione con Dio: questo accesso è Gesù, unica e assoluta via di salvezza. Solo a Lui si può applicare con piena verità la parola del Salmista: "È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti" (Sal 117 [118], 20).
L’indicazione della porta richiama la responsabilità di ogni credente ad attraversarne la soglia. Passare per quella porta significa confessare che Gesù Cristo è il Signore, rinvigorendo la fede in Lui per vivere la vita nuova che Egli ci ha donato. È una decisione che suppone la libertà di scegliere ed insieme il coraggio di lasciare qualcosa sapendo che si acquista la vita divina (cfr. Mt 13, 44-46). È con questo spirito che il Papa per primo varcherà la Porta Santa nella notte tra il 24 ed il 25 dicembre 1999. Attraversandone la soglia mostrerà alla Chiesa e al mondo il Santo Vangelo, fonte di vita e di speranza per il terzo millennio che viene. Attraverso la Porta Santa, simbolicamente più ampia al termine di un millennio, Cristo ci immette più profondamente nella Chiesa, suo Corpo e sua Sposa. Comprendiamo in questo modo quanto ricco di significato sia il richiamo dell’apostolo Pietro quando scrive che, uniti a Cristo, anche noi veniamo impiegati "come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio" (1Pt 2, 5).
"Gli occhi di tutti erano fissi sopra di Lui" (Lc 4, 20). Così si dice dell'assemblea sinagogale di Nazaret dove Gesù ha letto la profezia di Isaia.
Gli occhi di tutti i fedeli furono fissi sul Papa e sulla Porta Santa che si stava per aprire per celebrare nella gioia il Grande Giubileo che ricordava i venti secoli dalla nascita di Cristo. Tutti furono in attesa di vedere colui che iniziò il pontificato con il grido "Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo", e aprire lui stesso la Porta Santa.
Tutti sono in attesa di vedere colui che ha scritto Varcare la soglia della speranza, varcare la soglia del Grande Giubileo. Egli varcò per primo questa soglia per guidare una moltitudine di fedeli ad entrare più profondamente nel mistero della salvezza presente nella Chiesa che celebrava con gioia il bimillenario della nascita del suo Sposo e Signore Gesù Cristo.






 Gradinata d'altare.
Gradinata d'altare. La Chiesa si suddivide in due spazi principali: presbiterio, che è la parte dei Ministri Sacri, è navata o luogo dei fedeli. I confini sono resi visibili grazie alla presenza delle balaustre. Inoltre, l'area del presbiterio risulta rialzata rispetto a quella della navata ed e raggiungibile grazie ad una prima gradinata e dopo aver oltrepassato le balaustre.
L'altare maggiore sta al centro del presbiterio ed è ulteriormente rialzato rispetto ad esso ed è raggiungibile grazie ad una ulteriore serie di gradini (generalmente tre). L'altare è spesso elevato sulla gradinata d'altare, così come prescritto dal Cærimoniale Episcoporum.
In particolare, l'area del presbiterio che sta al livello delle balaustre, ovvero ai piedi della gradinata d'altare, è detta planum, mentre, superati il primo ed il secondo gradino della serie, il terzo gradino dell'altare è detto predella; quest'ultimo è raggiunto dal solo sacerdote celebrante.

 Gradini d'altare.
Gradini d'altare. Si innalzano sopra l'altare, nella parte posteriore, e su di essi sono collocati la Croce d'altare, i candelieri d'altare e altri oggetti; in particolare un altare ha solitamente due gradini, nel primo gradino, quello più basso, vengono posti i candelabri da accendere per le Messe Basse, due in tutto, uno per lato. Nel secondo gradino, il più alto, vengono posti la Croce, che occupa il centro dell'altare, e sei candelabri da accendere durante le Messe cantante, tre per parte, che affiancano la Croce; tra i candelabri si possono collocare fino a tre reliquiari per lato; il gradino in cui sono poste le reliquie è anche detto gradino-reliquiario.

 Gremiale.
Gremiale. È un'insegna pontificale che consiste in una stoffa di forma rettangolare, che ha le caratteristiche di un vero e proprio grembiule che può presentare nastri o fettucce cucite agli spigoli del lato superiore del rettangolo di stoffa, utili per essere allacciato alla vita del celebrante, ed una decorazione di merletto lungo i bordi. Può essere usato dal Papa, i Cardinali, i Patriarchi, Primati, Arcivescovi e Vescovi ed Abbati quando celebrano al trono o al faldistorio. Ne usufruiscono anche i protonotari apostolici numerari e soprannumerari, ed i prelati che hanno gli stessi privilegi; quanto ai protonotari ad instar, non possono utilizzarlo perchè possono celebrare solo il pontificale ad scamnum (forma di pontificale che risale a Pio IX).
Ci sono due tipi di gremiale:
- Il gremiale di seta, del colore delle vesti liturgiche, che il prelato posa sulle sue ginocchia ogni volta che siede al trono o al faldistorio. Le norme sopra descritte si riferiscono a questo gremiale.
- Il gremiale di lino o rude, chiamato anche cincticulum, che il prelato indossa quando deve conferire delle unzioni come l'ordinazione sacerdotale e la consacrazione episcopale, per proteggere gli abiti liturgici del celebrante durante l'unzione del capo e delle mani dell'ordinato o consacrato. Ancora, viene usato durante il Battesimo, nella Messa del Mercoledì delle Ceneri quando il celebrante cosparge i fedeli con la cenere, nella Messa in Coena Domini del Giovedì Santo per non sporcare la pianeta quando il celebrante esegue il rito della Lavanda dei piedi, durante la distribuzione delle candele e delle palme ed anche nei riti di consacrazione di chiese o altari.
Come specifica Pontificalis Rituus di Paolo VI, è ancora in uso, e facoltativamente si concede l'utilizzo del colore bianco per tutte le funzioni.




H
- Nessuna voce -
I
 Immixtio Manuum.
Immixtio Manuum. È il gesto che indica ubbidienza filiale e fedeltà: consiste nel porre la propria mano (o entrambe) all'interno di quella di colui al quale si promette obbedienza. Ha nascita feudale in quanto era un atto che suggellava il rapporto di vassallaggio tra un feudatario e un suo superiore. In contesto liturgico, il gesto viene eseguito dagli ordinandi nei confronti del Vescovo durante le ordinazioni diaconali e presbiterali al momento della promessa di fedeltà al Vescovo stesso.
 Incenso.
Incenso. Sostanza resinosa, che bruciata emette un gradito odore aromatico e fumo. L'uso dell'incenso nel culto è attestato dalla più remota antichità presso tutti i popoli orientali. Probabilmente entrò nell'uso liturgico cristiano a partire dalla seconda metà del secolo IV.
DEFINIZIONE E UTILIZZO.
Aroma in grani utilizzato per le celebrazioni liturgiche solenni o per le funzioni nelle quali è prevista l’esposizione eucaristica.
L’incenso si utilizza anche nel rito dei funerali per rendere ossequio alla salma del defunto che è stata, in vita, tempio dello Spirito Santo.
Per essere bruciato, l’incenso viene profuso sul carbone ardente collocato nel turibolo, mentre normalmente si conserva nella navicella.
SIGNIFICATO DELL'USO DELL'INCENSO E SUA IMPORTANZA NELLA LITURGIA.
L’uso dell’incenso è in sostanza un gesto semplice: si brucia in un apposito contenitore (turibolo) una resina che provoca fumo profumato. Il suo simbolismo è tuttavia complesso e articolato.
- Il salire verso l’alto è visto dalla Bibbia come immagine della preghiera del credente che sale verso il cielo, il “luogo simbolico” di Dio (cfr. Sal 141, 1-2), o delle preghiere dei “santi” che si elevano verso il Suo trono (cfr. Ap 8, 1-4): incensare è dunque sia preghiera in azione, sia lode e supplica presentate all’Altissimo dal suo popolo che totalmente a Lui si affida.
- Da questo fondamentale significato dipende poi anche l’uso dell’incenso come espressione di onore e di adorazione (Mt 2, 2), e quindi come riconoscimento di una qualche particolare forma di presenza di Dio in chi o in ciò che si incensa: per esempio il sacerdote, il libro della Parola o l’altare nella celebrazione eucaristica, ma anche la stessa assemblea riunita, vera immagine della Chiesa in cui è presente il Suo Capo e Signore.
- Il fatto che questo “fumo che sale” abbia un buon odore, poi, viene interpretato dalla Scrittura come un’immagine del fatto che esso è come un “sacrificio gradito a Dio” (Lv 2, 1-2 e per il contrario in Ger 6, 20 dove “sacrifici” e “incenso” sono in parallelo, ed entrambi “non graditi”); spesso il Nuovo Testamento identifica con i credenti e con la loro vita questo “sacrificio gradito e profumato” (2Cor 2, 15). Dunque, sotto questo profilo, l’incenso viene utilizzato come espressione dell’accettazione di Dio e, soprattutto, dell’atteggiamento di offerta di sé dei credenti davanti a Lui, ad imitazione del loro Signore e Maestro; sempre nel caso della celebrazione eucaristica, questo è ben visibile nell’uso dell’incenso al momento della presentazione dei doni […].
- Collaterale a questo significato fondamentale dell’essere profumato, l’incenso assume talvolta nella Scrittura anche il valore di purificazione ed espiazione (Nm 17, 12): come infatti il profumo allontana i cattivi odori, così l’incenso può anche indicare la cacciata e l’allontanamento del maligno da ciò che si incensa/offre; in questo senso, incensare può anche essere inteso nel senso di “benedire”, specialmente se il gesto avviene tracciando segni di croce.

 Infule.
Infule. Sono due fasce in tessuto attaccate alla parte posteriore della Mitria e della Tiara, pendenti sulle spalle di colui che indossa questo copricapo. Possono essere dotate di frange e decori più o meno preziosi.


 Infusione.
Infusione. Indica l'azione di "versare" (per esempio il vino e l'acqua nel calice oppure l'acqua sul capo dei battezzandi nel rito del Battesimo) o di "introdurre" (per esempio l'incenso nel turibolo).
 Inginocchiatoio.
Inginocchiatoio. L'inginocchiatoio è un piccolo mobile utilizzato per pregare in ginocchio, specialmente davanti al tabernacolo.
L'inginocchiatoio viene anche detto con termine improprio, o comunque non preferibile, "pregadio".
STORIA.
L'inginocchiatoio ha avuto origine in Italia nel XV secolo, diffondendosi poi in tutta Europa. I primi esempi erano costituiti da una base e da un corpo verticale, realizzati con assi sagomati.
Nel XVI secolo, il corpo verticale venne munito di cassetti e scomparti, presentando forme sobrie e diritte, corredata solo di modanature e, talvolta, d'intarsi, mentre nel XVII-XVIII secolo la sua struttura si arricchì di elementi decorativi e parti intagliate, comprendenti spesso vere e proprie sculture (angeli, fogliami, ecc.). Inoltre, da quest'ultimo periodo in poi, furono costruiti modelli nei quali al legno erano uniti altri materiali (avorio, bronzo, ecc.), secondo il variare degli stili ed introducendovi le nuove tecniche decorative.
DESCRIZIONE.
L'inginocchiatoio è normalmente in legno, ed è costituito da un gradino, a volte mobile, sul quale inginocchiarsi, e da un piccolo ripiano, detto "alzata", su cui posare le mani conserte in preghiera. Questo ripiano consente anche di appoggiarvi il testo di preghiera senza essere obbligati a sostenerlo con le mani.
Può presentare anche uno scaffale, un armadietto o dei cassetti, generalmente sotto il piano d'appoggio o sotto il leggio o, più raramente, sopra il leggio.
Nei modelli più preziosi è corredato da una copertura.
TIPOLOGIE PARTICOLARI.
Tipologie particolari di questo arredo sacro sono:
- Inginocchiatoio da sacrestia: mobile utilizzato dal sacerdote per recitare le preghiere di preparazione per la Messa prima di entrare in chiesa; presenta talora un’alzata nella qual è inserita un'immagine sacra e spesso una tabella con le preghiere da recitare come preparazione prima della Messa e ringraziamento dopo la stessa.
- Inginocchiatoio da Comunione: mobile a forma d’inginocchiatoio munito di piano d'appoggio che serve ad inginocchiarsi per ricevere la Comunione in assenza del ripiano della balaustrata d'altare, della balaustra di una cappella o del coro.
- Inginocchiatoio nominativo: mobile riservato ad una determinata persona per uso proprio; può essere contrassegnato da un'iscrizione con il nome o le insegne d'appartenenza.
- Inginocchiatoio (sgabello): banchetto basso per inginocchiarsi. Può essere un arredo mobile, oppure parte integrante di un banco da chiesa o di un arredo più complesso, detto anch'esso inginocchiatoio, che presenta spesso un piano d'appoggio od un ripiano per i libri.
- Sedia-inginocchiatoio: sedia con basso sedile che funge, anche da inginocchiatoio, e con un'alzata dotata spesso di un piano d'appoggio e talora decorata con motivi sacri.
- Sedia-inginocchiatoio a ribalta: sedia con inginocchiatoio collocato sotto il sedile ribaltabile e con alzata dotata di un piano d'appoggio.




 Insegna priorale (di confraternita).
Insegna priorale (di confraternita). Le insegne delle Confraternite dei pii sodalizi - immagini sacre e simboli - costituiscono una apprezzabile documentazione della pietà, della devozione, delle tradizioni, di usi e di culti nell'età medievale.
Quegli emblemi infatti furono dipinti o ricamati sui gonfaloni processionali, scolpiti nelle cappelle delle Confraternite e sulle pietre tombali, miniati sui frontespizi dei libri delle Regole e sugli elenchi dei confratelli, intagliati nei sigilli. Furono altresì sbalzati in placchette di metallo che si applicavano sul mantello, sull'abito o sulla "pellegrina" che i confratelli indossavano nelle sacre funzioni (in qualche caso furono ricamati).
Sotto l'aspetto iconografico, convien distinguere le insegne di tali sigilli in figurate e simboliche.
Generalmente una insegna di confraternita consiste in un pannello rigido, solitamente dipinto su entrambe le facce con un'iconografia relativa al titolo della confraternita. Retta da un'asta e sormontata da una croce, viene portata in processione dai confratelli. Se ad esempio presenta sul recto la Vergine della Misericordia, allora viene detta insegna di confraternita della Misericordia.


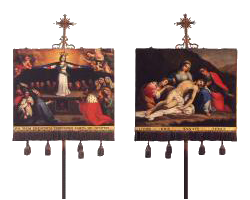
 Introito.
Introito. Nella liturgia cattolica, l'introito, spesso chiamato anche col suo nome latino introitus o antiphona ad introitum, è il canto che accompagna la processione di ingresso del celebrante e dei suoi ministri ed introduce alla celebrazione eucaristica.
L'introito appartiene al proprio della Messa: il suo testo quindi varia a seconda dell'occasione liturgica celebrata.
L'introito è un canto funzionale: accompagnando la processione dei ministri all'altare, ha lo scopo di dare inizio alla celebrazione, favorire l'unità dei fedeli riuniti, introdurre il loro spirito nel mistero del tempo liturgico o della festività.
Il testo è generalmente preso dai salmi, talvolta da un altro libro scritturistico, raramente è una composizione ecclesiastica, comunque manifesta uno stretto legame con le letture che seguiranno.
L'introito può essere cantato o letto, in funzione della solennità della Messa o a giudizio del celebrante. Quando la celebrazione non richiede una processione di ingresso, come nella veglia pasquale, l'introito viene omesso.
Spesso è il canto dell'introito a dare il nome alla Messa del giorno: la Messa dei defunti è detta Requiem e la seconda Messa della festa del Sacro Cuore di Gesù è detta Exordium. La prima domenica dopo Pasqua è detta domenica Quasimodo dall'introito Quasi modo geniti infantes. Si ricordano anche le domeniche Gaudete (III domenica d'Avvento) e Laetare (IV domenica di Quaresima), in cui il colore viola dei paramenti si può attenuare con il rosaceo.
 Ite, missa est.
Ite, missa est. La locuzione latina Ite, missa est è la formula di congedo con cui si conclude la Santa Messa Romana celebrata dai cattolici di rito latino. Il presbítero congeda i fedeli, che rispondono «Deo gratias».
J
- Nessuna voce -
K
 Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison. Il Kýrie, eléison è una preghiera antica della liturgia cristiana.
L'espressione è greca e "Kýrie, eléison" è la traslitterazione dell'espressione in latino. Nella liturgia italiana è stata tradotta con Signore, pietà!.
Vi sono espressioni simili in alcuni salmi e all'interno dei Vangeli: la Kýrie è la più antica testimonianza di uso liturgico cristiano, risalente al IV secolo nella chiesa di Gerusalemme, e al V secolo nella Messa di Rito Romano. È usata come preghiera litanica e risposta a determinate invocazioni.
USO LITURGICO.
Nel Rito Tridentino viene pronunciato dopo l'atto penitenziale e subito dopo l'antifona di introito.
Il Kýrie, come viene generalmente abbreviato, fa anche parte delle Messe cantate, essendone la parte immediatamente successiva all'introito.
Nella Messa, ogni invocazione viene ripetuta per tre volte ed è recitata alternativamente con Christe, eléison (O Cristo, pietà!), nel modo seguente:
Kýrie, eléison --- Signore, pietà!
Kýrie, eléison --- Signore, pietà!
Kýrie, eléison --- Signore, pietà!
Christe, eléison --- O Cristo, pietà!
Christe, eléison --- O Cristo, pietà!
Christe, eléison --- O Cristo, pietà!
Kýrie, eléison --- Signore, pietà!
Kýrie, eléison --- Signore, pietà!
Kýrie, eléison --- Signore, pietà!
per un totale di nove invocazioni.
L
 Lampada per Santissimo Sacramento.
Lampada per Santissimo Sacramento. È stabilito che accanto al tabernacolo che custodisce l’Eucarestia arda perennemente una lampada ad olio o di cera. Quando arde questo lume significa che è presente il Santissimo Sacramento nel tabernacolo. La lampada può essere appoggiata sopra o accanto all’altare, oppure può essere pensile, cioè appesa su un apposito portalampada dotato di catene discendenti dalle pareti del presbiterio. La lampada è contenuta in un contenitore di vetro rosso.

 Lampadario da chiesa.
Lampadario da chiesa. Sistema di illuminazione di forma e materiali vari a più luci (ad olio, con candele, ecc.) da appendere al soffitto.
Presenta spesso decorazioni di carattere religioso.


 Lanterna per processione.
Lanterna per processione. Lanterna portatile issata su un'asta utilizzata durante le processioni o per il trasporto del SS. Sacramento o del Viatico. Presenta spesso decorazioni con motivi religiosi. Le lanterne sono spesso a coppia o in più esemplari di numero pari. Per accompagnare il Viatico (sacramento dell'Eucaristia), la lanterna può essere fornita di una campanella processionale (vedi lanterna-campanella processionale).

 Lanterna-campanella processionale.
Lanterna-campanella processionale. Per accompagnare il Viatico (sacramento dell'Eucaristia), la lanterna può essere fornita di una campanella processionale.
Presenta spesso decorazioni con motivi religiosi.

 Lauda Sion.
Lauda Sion. La sequenza Lauda Sion Salvatorem è una preghiera della tradizione cattolica. In essa, dopo la lode all'Eucaristia, viene espresso il dogma della transubstanziazione e spiegata la presenza completa di Cristo in ogni specie.
L'autore è san Tommaso d'Aquino, che la compose attorno al 1264, su richiesta di papa Urbano IV.
Viene codificata dalla liturgia come una sequenza, una delle cinque conservatesi dopo il Concilio di Trento, e viene recitata o cantata prima del Vangelo nella Messa della solennità del Corpus Domini. Ne sono state tramandate più versioni, unificate solo nel Missale Romanum del 1570.
È ritenuto tra i vertici della poesia religiosa di ogni tempo, per profondità dottrinale e sapienza estetica. Alcuni versi richiamano, quanto al contenuto ed alle espressioni utilizzate, l'inno Pange Lingua.
Il Lauda Sion è stato tradotto in musica da molti compositori; molto noto è il canto del Lauda Sion composto da Federico Caudana in occasione del Congresso Eucaristico di Cremona del 1924.

 Lavabo.
Lavabo. E' detto lavabo (da sacrestia) la vasca situata nella sacrestia, spesso sormontata da una riserva fornita di un rubinetto (fontana di sacrestia), e utilizzata per le abluzioni del sacerdote prima e dopo la celebrazione della Santa Messa e per versare l'acqua della purificazione nonché per eliminare i residui delle sostanze benedette ridotte in cenere, purchè lo scarico del lavabo sia collegato esclusivamente con il Sacrario della chiesa che mette a contatto direttamente con la terra di fondazione della chiesa stessa.
Si noti che il termine lavabo, è propriamente una parola latina, che proviene da una frase che il celebrante recita durante la Messa, nel corso dell'Offertorio e prima di toccare le Sacre Specie dell'Eucaristia, al momento della purificazione delle mani che avviene attraverso un lavabo portatile composto di brocca con catino e munito di manutergio. La frase recita così: "Lavàbo inter innocèntes manus meas: et circùmdabo altàre tuum, Dòmine [...]" (traduzione: Lavo le mie mani nell'innocenza e mi muovo attorno al tuo altare, o Signore [...] - Salmo 25, 6-12).

 Leggio.
Leggio. In sostituzione al tradizionale cuscino di seta che reggeva il messale sull'altare della celebrazione, si introdusse il leggio, pare già in epoca tardo-gotica.
Il leggio si presenta come un supporto con piano inclinato con forma che può variare in rapporto alle dimensioni del libro liturgico che deve reggere. Può essere in legno o in metallo e le decorazioni sono ispirate dalla fantasia dell’artista o dalle necessità del luogo in cui si inserisce.
In epoca rinascimentale furono realizzati leggii per lo più in legno e dimensione notevole ma scarsamente manovrabili da parte dei ministri addetti al servizio dell’altare. Il barocco, invece, ha introdotto oggetti molto pratici nonostante la ricchezza di fregi e di finizioni aggiunte.
Il leggio costituisce parte del corredo d’altare per la celebrazione della Santa Messa; può essere utile anche in altre funzioni religiose.
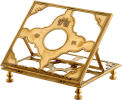
 Liber Usualis.
Liber Usualis. Il Liber usualis Missae et Officii, ma più comunemente Liber Usualis, è un libro liturgico che contiene una raccolta dei canti gregoriani utilizzati dalla Chiesa Cattolica Romana. Dei canti vengono trascritti i testi e la melodia nella sola notazione quadrata.
La prima edizione risale al 1896, effettuata dai monaci dell'Abbazia di Solesmes. Sono seguite diverse edizioni e dopo il Concilio Vaticano II non ha avuto più nuove edizioni.
Il Liber Usualis è diffuso in tutto il mondo in latino, anche se attualmente viene sostituito dal più aggiornato Graduale Triplex dove nel repertorio, oltre alla notazione quadrata, viene trascritta anche la notazione sangallese e metense e dove la scelta dei brani è più meditata.
Dopo l'Ordo Missae, cioè il testo della Messa, è presente una piccola guida al canto gregoriano indirizzata ai cantori meno esperti con indicazioni nell'esecuzione della salmodia.
Seguono i canti dell'Ordinario della Messa e tutti i salmi nei loro otto toni e il Magnificat, che vengono impiegati nella recita del Breviario Romano.
Si prosegue con il Proprio del Tempo: per ogni giorno del calendario liturgico sono segnati tutti i canti che devono essere eseguiti nella Messa e nella Preghiera Liturgica.
I canti che riguardano la Messa sono contenuti nella parte dei "Gradualia", mentre quelli che riguardano la Preghiera Liturgica sono contenuti in quella parte del libro detta "Antiphonarium".
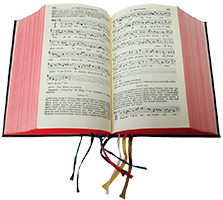
 Libri liturgici.
Libri liturgici. Sono i libri che contengono le formule ufficiali, con le relative prescrizioni rituali o rubriche, che i sacerdoti della Chiesa Cattolica usano per la celebrazione della Santa Messa, l'amministrazione dei Sacramenti e dei Sacramentali, e l'ufficiatura divina. Le rubriche (scritte in rosso) forniscono le istruzioni relative ai rituali attraverso i quali si sviluppa la liturgia del Rito Romano.
- Il Missale Romanum (Messale Romano) è il messale del Rito Romano della Chiesa Cattolica. Questo è il maggiore libro liturgico e contiene tutte le formule e le informazioni (testi, orazioni, canti, gli stessi gesti e le rubriche) necessarie al celebrante per la celebrazione della Santa Messa durante tutto l'anno liturgico. Esso è dotato di segnacoli che permettono di segnalare le pagine che servono per la celebrazione.
In particolare, nel Missale Romanum sono contenuti: l'Ordinario della Messa, che contiene le parti fisse (invariabili) dette ad ogni Messa, ossia i riti e le preghiere che appartengono all'essenza del Sacrificio dell'altare e che non possono cambiare; il Proprio della Messa, che contiene le parti variabili di ogni Messa del giorno, ossia le tre orazioni (Orazione, Secreta e Dopocomunione), le tre antifone (all'Introito, all'Offertorio ed alla Comunione), le due letture (Epistola e Vangelo) e le parti salmodiche che separano le letture (Graduale, Alleluia o Tratto); il Proprio del Tempo o ciclo temporale, rappresentato dall'alternarsi dei tempi liturgici che compongono l'intero anno ecclesiastico, attraverso il quale riviviamo i grandi misteri dell'Incarnazione (Natale) e della Redenzione (Pasqua) di Cristo; il Proprio dei Santi o ciclo santorale, composto dalle feste dei Santi, validi esempi di imitatori di Gesù e sui quali si è compiuta la redenzione; il Comune dei Santi, che racoglie le preghiere che sono in comune nel Proprio dei Santi; le Messe Votive, le Messe dei Defunti, Salmi, Cantici, Inni, Sequenze e Canti, Feste del Signore, Feste della Beata Vergine Maria, Feste dei Santi, Orazioni, l'amministrazione dei Sacramenti, ecc..
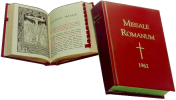
- Il Breviarium Romanum (Breviario Romano) è un libro liturgico che contiene l'Ufficio Divino della Chiesa Cattolica, in altre parole in esso è codificata la Preghiera Liturgica che tutti i sacerdotti debbono recitare ogni giorno (Mattutino, Lodi, Ora Prima, Terza, Sesta e Nona (rispettivamente alle ore 6:00, 9:00, 12:00 e 15:00 della giornata), Vespri e Compieta).
La Chiesa invita lodevolmente anche i fedeli laici alla recita del Breviario; infatti esso ha lo scopo di aiutare il Cristiano a vivere in Cristo la giornata, santificandone i vari momenti. Viene recitato sia nei luoghi di culto, in modo comunitario, sia in modo personale nelle proprie case. La Preghiera Liturgica trae la sua origine dal precetto di Gesù di pregare senza interruzione.
Il Breviarium Romanum ha una articolazione molto simile a quella del Missale Romanum; è composto da un Ordinario, che comprende le parti fisse che si recitano uguali ogni giorno, il Proprio del Tempo, che comprende le parti variabili che dipendono dal tempo liturgico, il Proprio dei Santi, che comprende le parti variabili in funzione delle singole feste dei santi, il Comune dei Santi, che comprende le parti variabili relative alle feste dei santi, ma che non si trovano nel Proprio dei Santi e sono accorpate per classi omogenee di santi, infine il Salterio che comprende il ciclo dei 150 salmi che si ripete identico ogni settimana.

- Il Rituale Romanum (Rituale Romano) è un libro liturgico che contiene le formule e le istruzioni necessarie al sacerdote per amministrare i Sacramenti e Sacramentali non riservati esclusivamente al Vescovo (Battesimo, Confessione o Penitenza, Comunione o Eucarestia, Matrimonio e Unzione degli infermi), per presiedere i funerali, le processioni, praticare i riti degli esorcismi, ecc.. Inoltre sono contenute orazioni e altre funzioni sacre come le benedizioni delle persone e delle cose, ecc..
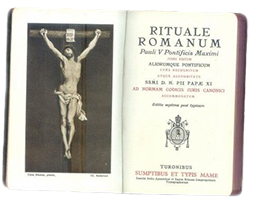
- Il Pontificale Romanum (Pontificale Romano) è un libro liturgico, riservato ai Vescovi, che raccoglie il rituale (formule e rubriche) delle funzioni episcopali, eccetto la Santa Messa e l'Ufficio Divino della Chiesa Cattolica (rispettivamente implementati nel Missale Romanum e nel Breviarium Romanum), celebrati dai Vescovi.
Esso contiene le formule e le rubriche per l'amministrazione dei Sacramenti e Sacramentali riservati ai Vescovi; in particolare include l'amministrazione del Sacramento della Cresima o Confermazione e dell'Ordine Sacro (ordini minori: ostiario, lettore, esorcista, accolito; ordini maggiori: suddiacono, diacono, presbitero), la consacrazione di un Vescovo, la benedizione di un Abate, la consacrazione delle vergini, benedizione del sale e dell'acqua, la consacrazione del Santo Crisma e la benedizione dell'Olio dei catecumeni e dell'Olio degli infermi fatte il Giovedì Santo nella Messa Crismale - si tenga presente che il Crisma è il più importante dei tre Oli Santi e, dopo la Messa Crismale, viene distribuito (insieme agli altri due Oli) ad ogni parrocchia per l'amministrazione dei Sacramenti e Sacramentali non riservati al Vescovo (ad esempio nel Battesimo o nell'Unzione degli infermi); i Vescovi lo usano per l'amministrazione dei Sacramenti e Sacramentali ad essi riservati (Cresima o Confermazione ed Ordine Sacro), nella dedicazione e consacrazione di una Chiesa per ungere le pareti e gli altari, e nella benedizione dei Vasi Sacri (Calice e Patena) usati per la celebrazione dell'Eucarestia. Nelle parrocchie i tre Oli Santi (Crisma, Olio dei catecumeni e Olio degli infermi) vengono di solito custoditi in un'apposita sede chiamata "armadietto degli Oli Santi" o "tabernacolo degli Oli Santi" - nel Pontificale Romanum sono inoltre contenute altre importanti azioni liturgiche presiedute da un Vescovo come la benedizione di una nuova Croce da esporre alla pubblica venerazione, il rito per l'incoronazione di una immagine della Beata Vergine Maria, la benedizione di un cimitero, la benedizione di una campana, l'ordo per celebrare un sinodo, l'ordo per la visita pastorale delle parrocchie, il ministero del salmista o cantore, le formule e le norme liturgiche per la benedizione delle persone e delle cose, ecc..

- Il Cæremoniale Episcoporum (Cerimoniale dei Vescovi) è un libro liturgico che raccoglie le regole delle cerimonie episcopali, ossia regola lo svolgimento delle liturgie presiedute dal Vescovo o celebrate alla sua presenza.
A titolo esemplificativo, nel Cæremoniale Episcoporum, si può trovare: l’abito e le altre cose che deve fare un Vescovo appena eletto; il primo ingresso di un Vescovo nella sua diocesi; l’abito ordinario che un Arcivescovo indossa nella sua provincia; benedizioni e altre prerogative...; le mansioni del sacrista; le mansioni del cerimoniere; le mansioni del sacerdote “assistente” durante i vespri e la Santa Messa; l'"assistenza" di due canonici in veste diaconale mentre il Vescovo, in abito ordinario, presiede o non presiede; le mansioni del diacono durante la Messa solenne; le mansioni del suddiacono durante la stessa solenne Messa pontificale; il numero, la qualità e le mansioni dei ministri che servono il Vescovo nelle celebrazioni liturgiche, in particolare circa il libro, la candela, il pastorale...; l’ornamentazione della chiesa e dei preparativi in vista della venuta del Vescovo; il luogo dove devono prendere posto in chiesa i vescovi, i legati, i cardinali...; l’uso dell’ombrello ossia del baldacchino; l’abito ecclesiastico del Vescovo e dei canonici; il loro ingresso in chiesa e la loro uscita dalla chiesa; il pallio; la mitria e il (bastone) pastorale; le reverenze e le genuflessioni...; l'incensazione, l’ordine e il modo di congiungere le mani, disgiungerle, alzarle, tenderle da parte dei Vescovi...; le preghiere o collette e i diversi toni per cantarle; l’organo, l’organista e i musici, e le norme che essi devono osservare; la Messa senza canto presieduta dal Vescovo; la Messa senza canto celebrata alla presenza di un Vescovo nel territorio di sua giurisdizione; le cerimonie da osservare nei sinodi provinciali e diocesani. Ancora: i primi vespri solenni; la compieta; il mattutino alla presenza del Vescovo; le lodi e le altre ore canoniche; la Messa solenne presieduta dal Vescovo; la Messa solenne celebrata alla presenza del Vescovo; i vespri e il mattutino dei defunti; la Messa pontificale per i defunti presieduta dal Vescovo, l’omelia e l’assoluzione dopo la Messa; le celebrazioni dei Misteri del Signore durante l'anno liturgico, il tempo di Avvento e della Natività del Signore, le feste tra Natale e la Purificazione che devono essere celebrate solennemente, la festa della Purificazione della Beata Vergine Maria, la benedizione e la distribuzione delle candele, la festa della Purificazione nelle cattedrali, con il Vescovo assente, e nelle collegiate, il tempo di Quaresima, l’Ufficio e la Messa il mercoledì delle ceneri, quando presiede il Vescovo oppure quando non presiede ma è presente, il tempo di Passione, la Veglia Pasquale, il tempo Pasquale, il tempo Ordinario; le Rogazioni e le Quattro Tempora...; i Sacramenti, Cresima o Confermazione e Ordine Sacro...; i Sacramentali, benedizione dell'Abate, consacrazione delle vergini, istituzione dei Lettori e degli Accoliti, dedicazione e benedizione di una Chiesa, benedizione dei Vasi Sacri (Calice e Patena), benedizione di una nuova Croce da esporre alla pubblica venerazione, rito di incoronazione di una immagine della Beata Vergine Maria, benedizione della campana, benedizione di un cimitero, le Processioni, esposizione e benedizione Eucaristica, benedizioni impartite dal Vescovo...; visita pastorale di una parrocchia; ingresso di un nuovo parrocco; la malattia, la morte e il funerale di un Vescovo e le preghiere per ottenere da Dio un’opportuna elezione del nuovo Vescovo; ecc. ...

- Il Liber usualis Missae et Officii, ma più comunemente Liber Usualis, è un libro liturgico che contiene una raccolta dei canti gregoriani utilizzati dalla Chiesa Cattolica Romana. Dei canti vengono trascritti i testi e la melodia nella sola notazione quadrata.
La prima edizione risale al 1896, effettuata dai monaci dell'Abbazia di Solesmes. Sono seguite diverse edizioni e dopo il Concilio Vaticano II non ha avuto più nuove edizioni.
Il Liber Usualis è diffuso in tutto il mondo in latino, anche se attualmente viene sostituito dal più aggiornato Graduale Triplex dove nel repertorio, oltre alla notazione quadrata, viene trascritta anche la notazione sangallese e metense e dove la scelta dei brani è più meditata.
Dopo l'Ordo Missae, cioè il testo della Messa, è presente una piccola guida al canto gregoriano indirizzata ai cantori meno esperti con indicazioni nell'esecuzione della salmodia.
Seguono i canti dell'Ordinario della Messa e tutti i salmi nei loro otto toni e il Magnificat, che vengono impiegati nella recita del Breviario Romano.
Si prosegue con il Proprio del Tempo: per ogni giorno del calendario liturgico sono segnati tutti i canti che devono essere eseguiti nella Messa e nella Preghiera Liturgica.
I canti che riguardano la Messa sono contenuti nella parte dei "Gradualia", mentre quelli che riguardano la Preghiera Liturgica sono contenuti in quella parte del libro detta "Antiphonarium".
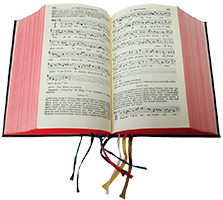
 Lingua liturgica.
Lingua liturgica. La lingua della Chiesa è il latino. Tuttavia essa non ha mai escluso l'uso della lingua vernacola (del popolo), si noti infatti che il Concilio di Trento - dal quale è scaturita la Liturgia Romana, oggi nota come Forma Extraordinaria del Rito Romano - non ha mai ufficialmente proibito l'uso della lingua vernacola nella Liturgia e nella Paraliturgia (esempi di Paraliturgia sono, nella tradizione sarda, il canto dei "is coggius" in ogni periodo dell'anno, oppure "su scravamentu" il Venerdì Santo). A riprova di questo fatto, già prima del Concilio Vaticano II possiamo notare che un fedele che frequentava la Santa Messa poteva è può tuttora, col permesso del celebrante, oltrepassare le balaustre e leggere in contemporanea al sacerdote (che legge sottovoce dal messale in latino) la relativa traduzione dell'Epistola e del Vangelo nella lingua locale.
 Lipsanoteca.
Lipsanoteca. È una piccola custodia, generalmente metallica, destinata a contenere una reliquia dei beati o dei santi. La parte in esposizione è chiusa da un cristallo trasparente, mentre il fondo viene assicurato alla parte superiore con una chiusura di sicurezza ottenuta tramite fili serici tenuti all’altezza della loro annodatura con ceralacca rossa, sulla quale viene impresso il sigillo del postulatore o dell’ordinario diocesano che ha facoltà di autenticare le reliquie.
Inoltre si deve aggiungere che talune lispanoteche sono sigillate con l’impronta del sacrista del Palazzo Apostolico che era il custode del Sacrario papale o, attualmente, con quella del Maestro delle Celebrazioni liturgiche del Santo Padre che ne è diventato il responsabile.

 Litanie.
Litanie. La litania è una forma di preghiera della religione cristiana basata su di una successione di affermazioni (di lode o di richiesta) enunciate da un sacerdote, un diacono o un cantore alle quali l’assemblea risponde in maniera predefinita. In epoca pre cristiana la litania era una invocazione generica di aiuto.
Si presenta in forma breve (come l'Agnus Dei) od in forma lunga.
In particolare, le litanie approvate dalla Chiesa Cattolica e riportate nel Rituale Romanum del 1962 sono:
- Litanie del Santissimo Nome di Gesù;
- Litanie del Sacro Cuore di Gesù;
- Litanie del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo;
- Litanie della Beata Vergine Maria o Litanie Lauretane, le più celebri litanie che si pregano alla fine del Santo Rosario;
- Litanie di San Giuseppe;
- Litanie dei Santi, le più lunghe litanie liturgiche;
 Liturgia.
Liturgia. La Liturgia Cattolica indica l'insieme degli atti, segni e simboli usati per rendere il culto dovuto a Dio.
Anzitutto la Santa Messa è la fonte ed il culmine della Liturgia Cattolica; inoltre, la Liturgia Cattolica comprende l'amministrazione dei sette Sacramenti (Battesimo, Confessione, Comunione o Eucarestia, Cresima o Confermazione, Matrimonio, Ordine Sacro ed Unzione degli infermi) e fa altresì parte di essa la Preghiera Liturgica, (Ufficio Divino) codificata nel libro liturgico detto Breviarium Romanum (Breviario Romano).
Con il Sacrificio della Messa, i Sacramenti e le preghiere pubbliche dell'Ufficio Divino, la Liturgia è il mezzo principale per cui ci vengono trasmesse quelle grazie di vita divina che, dal Padre, attraverso Gesù Cristo, sono riversate sui membri del suo Corpo mistico per portar loro la vita divina della grazia. La Liturgia rende possibile la santificazione del genere umano; la Chiesa, infatti, ci santifica per mezzo della Messa e dei Sacramenti, che formano l'essenza vera e propria della Liturgia, e con la preghiera ci istruisce continuamente nello spirito e nella pratica della vita cristiana. Insomma è chiaro che la Liturgia è la sorgente indispensabile della vita di ciascun cristiano.
Pio XII, nella sua lettera enciclica Mediator Dei, spiega succintamente la funzione della Liturgia: "la Chiesa, fedele al mandato ricevuto dal suo Fondatore, continua l'ufficio sacerdotale di Gesù Cristo soprattutto con la Sacra Liturgia. Ciò fa in primo luogo all'altare...; poi con i Sacramenti...; in fine col quotidiano tributo di lodi... La Sacra Liturgia è pertanto il culto pubblico che il nostro Redentore rende al Padre come Capo della Chiesa, ed è il culto che la società dei fedeli rende al suo Capo, e, per mezzo di Lui, all'Eterno Padre: è, per dirla in breve, il culto integrale del Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè del Capo e delle sue membra".
 Lucerna.
Lucerna. Lampada da chiesa ad olio utilizzata nel primo periodo cristiano per le funzioni liturgiche, nei riti funebri od offerta come ex voto. E' caratterizzata da un recipiente per la combustione dell'olio e da uno o più beccucci da cui fuoriescono gli stoppini.

 Lume da parete di chiesa.
Lume da parete di chiesa. Lume da fissare o da appendere al muro di una chiesa che può avere un supporto, spesso a forma di braccio (braccio portalumi da chiesa), per una o più lampade (portalampade da chiesa) o una o più candele (candeliere da parete di chiesa); può presentare decorazioni religiose.


 Lumino votivo.
Lumino votivo. Piccolo contenitore, generalmente di colore rosso (ma anche blu o bianco), talora decorato con immagini relative al tipo di devozione, contenente una materia combustibile (cera, olio) e uno stoppino. Viene acceso e posto generalmente su un portaceri votivo davanti alle immagini del Cristo, della Vergine Maria, dei Santi o davanti a reliquie in segno di preghiera o come ex voto.


 Lunetta.
Lunetta. È un supporto d'oro o d'argento dorato indispensabile all’ostensorio in quanto regge l’Ostia magna consacrata. Essa ha forma di mezza luna ed è inserita nella parte centrale dell'ostensorio per l'esposizione dell'Ostia consacrata, ma più volte assume la configurazione di una testina d’angelo alato montata su un piede che viene inserito in un piccolo binario fissato alla base della teca dell’ostensorio.
La lunetta è costituita da due parti tenute da una vite che consente di poter collocare con sicurezza l’Ostia consacrata.
Quando non è utilizzata per l'esposizione può essere riposta in un opportuno portalunetta.



M
 Manichetti (o polsini).
Manichetti (o polsini). Polsino o tessuto che adorna le maniche del camice dei sacerdoti.

 Manicotto.
Manicotto. Nell'unzione per la consacrazione di un altare il Vescovo può usare una protezione per non ungere i paramenti con il Crisma. Questa protezione si mette sopra il polso come una sovrammanica.


 Manipolo.
Manipolo. Il manipolo è un paramento liturgico adoperato nel Rito Romano della Chiesa Cattolica. Durante la celebrazione eucaristica il presbitero, il diacono e il suddiacono lo portano nell'avambraccio sinistro.
Il manipolo era, fra tutti gli ordini maggiori, l’insegna tipica del suddiacono. Infatti è consegnato durante la cerimonia di ordinazione suddiaconale e la preghiera Ad Manipulum per la vestizione recita:
"Merear, Domine, portare manipulum fletus et doloris: ut cum exultatione recipiam mercedem laboris." (traduzione: Che io sia degno, o Signore, di portare il manipolo di pianto e dolore: così con orgoglio raccoglierò la mercede del lavoro.)
Anticamente era un tovagliolino portato sul braccio sinistro; ora è diventato una striscia di stoffa ornata da tre croci rispettivamente al centro ed alle due estremità. E' portato solamente dal celebrante, dal diacono e dal suddiacono.
Dalla riforma liturgica del Concilio Vaticano II il manipolo non è più in uso anche se formalmente non è stato abolito da alcun documento.


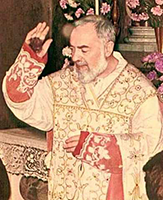


 Mantelletta.
Mantelletta. È una veste ecclesiastica, non liturgica, che fa parte dell'abito corale proprio di alcuni prelati della Chiesa Cattolica; si presenta come una mantella corta dalle spalle al ginocchio, senza maniche, aperta sul davanti, che viene indossata da Cardinali, Vescovi e Prelati. In particolare si indossa sopra la talare ed il rocchetto, inoltre i Cardinali e i Vescovi vi pongono sopra la mozzetta.
Naturalmente il tipo del tessuto e il colore sono in funzione della dignità ecclesiastica, quindi nera per i prelati elevati a tale rango da un ordine religioso, paonazza per i Vescovi eletti dal clero secolare e porpora per i Cardinali non provenienti da ordini religiosi.
Negli anni ’70 va in disuso e rimane utilizzata quasi esclusivamente dai Protonotari apostolici e dai Canonici di quei Capitoli che ne ebbero privilegio per concessione pontificia.



 Mantello rosso papale.
Mantello rosso papale. Mantello di colore rosso, allacciato al collo con opportuni cordoncini, senza maniche, aperto sul davanti e ricadente sino alle caviglie, che il Papa indossa sopra la talare bianca, sua veste ordinaria.
Si noti che l'uso dei colori bianco e rosso sono distintivi della dignità pontificia. Il binomio vesti bianche e sopravvesti rosse ha da sempre caratterizzato il tradizionale vestiario del Papa; le vesti bianche significano la purezza, ossia l'integrità di Cristo e del suo rappresentante (non a caso i valori di purezza ed innocenza legati al bianco sono associati all'abito dei battezzati), mentre le sopravvesti rosse alludono alla carità e al Sacrificio della Passione, ossia al Sangue versato da Cristo e infatti il Papa rappresenta la persona di Colui che per noi rese rosso il suo indumento.
In sostanza, dunque, i colori bianco e rosso rendono visibile ciò che il Papa rappresenta: la persona di Cristo e la Chiesa suo Corpo Mistico.





 Mantellone.
Mantellone. Mantello indossato da alcuni Prelati della Chiesa Cattolica; si presenta senza maniche, aperto sul davanti e ricadente sino alle caviglie ed è portato sopra la veste talare da Cardinali, Vescovi e Prelati. Naturalmente il tipo del tessuto e il colore sono in funzione della dignità ecclesiastica, quindi nero per i prelati elevati a tale rango, paonazzo per i Vescovi e porpora per i Cardinali. Tale mantello è indossato generalmente da alcuni canonici e beneficiati o da alcuni monaci come i francescani od ancora per la predicazione da alcuni chierici regolari, quali i gesuiti.





 Manto papale.
Manto papale. Il manto papale è un paramento liturgico simile ad un ampio piviale, molto ricco e sontuoso e di notevole lunghezza che superava quella dell’altezza della persona, riservato al Papa ed indossato nelle cerimonie più solenni, quando veniva usata la sedia gestatoria e quando il Pontefice vestiva la falda.
È di colore bianco o rosso ed, essendo più ampio e più lungo del piviale, è tale da formare uno strascico.
Il manto papale recava, al termine di ogni parte dello stolone frontale, l’arma araldica del pontefice.
Oggi il manto non viene più usato, nemmeno nelle funzioni più solenni, in quanto non viene più usata la sedia gestatoria.
Il primissimo riferimento all'utilizzo del manto è attestato da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Infatti, il Papa Niccolò III si presenta al poeta con queste parole, indicando il manto come prerogativa caratterizzante del pontefice:
«Se di saper ch'io sia ti cal cotanto, che tu abbi però la ripa corsa, sappi ch'io fui vestito del gran manto».
Il manto aveva una lunghezza superiore alla statura del papa (le dimensioni sono variabili a seconda del modello e del periodo storico, ma poteva essere anche di parecchi metri), e quindi, quando il Papa camminava, i bordi dovevano essere sorretti da appositi incaricati detti caudatari. Quando il Papa sedeva (sul trono o sulla sedia gestatoria), poneva i piedi sulla fodera interna e gli incaricati chiudevano le falde appoggiandole in modo che, oltre alla persona del Papa, venissero coperti completamente anche i gradini del trono.
L'ultimo Papa che indossò il manto fu Paolo VI. Come altri paramenti liturgici non è stato abolito, ma è caduto in disuso. Un manto appartenuto al Papa San Giovanni XXIII è stato tagliato, accorciato e trasformato in un comune piviale ed è stato indossato da San Giovanni Paolo II in occasione della chiusura della porta santa per il giubileo del 1983. Lo stesso è stato indossato da Benedetto XVI in occasione della benedizione Urbi et Orbi del 25 dicembre 2007 e per il Te Deum del 31 dicembre dello stesso anno e di quelli successivi.




 Manutergio.
Manutergio. Piccolo asciugamano bianco, generalmente di lino o canapa, di forma rettangolare, spesso bordato di pizzi e merletti e che presenta una piccola croce in uno o ambedue gli angoli, che il sacerdote utilizza durante la Santa Messa nel rito del lavabo per asciugare le mani dopo l'abluzione (alla fine dell'offertorio e prima di toccare le Sacre Specie per la consacrazione), ma anche nelle abluzioni fatte in Sacrestia dallo stesso sacerdote prima e dopo la Santa Messa. Ora, le dimensioni di tale oggetto possono variare: in Sacrestia, il sacerdote usa un manutergio di grandi dimensioni, per la purificazione delle mani nel lavabo della Sacrestia poco prima della celebrazione della Santa Messa ed eventualmente nelle abluzioni dopo la Messa. Durante la Messa, invece, il sacerdote fa uso di un manutergio di dimensioni minori, abbinato ad una brocca con catino utili nel rito del lavabo per la purificazione delle mani prima che egli tocchi le Sacre Specie. Un manutergio di grandi dimensioni si adopera anche per l'offerta dei pani consacrati dal vescovo.

 Martire (o martirio).
Martire (o martirio). Il martire è colui che ha testimoniato la propria fede o ideale nonostante la persecuzione, senza quindi abiurarla, anche a costo di eventuali pene corporali o morte.
Il martirio secondo il cristianesimo è la condizione che il seguace subisce per difendere la propria fede in Cristo o per difendere la vita di altri cristiani. In altre parole indica i fedeli che hanno sacrificato la propria vita per testimoniare la religione cristiana. Infatti, nella storia della chiesa primitiva, i martiri cristiani venivano torturati o uccisi tramite lapidazione, crocifissione e morte sul rogo, da coloro che nutrivano odio verso la fede cristiana.
All'inizio il martirio nel cristianesimo indicava la sopportazione di sacrifici, stenti e privazioni fisiche per onorare Dio, ma in seguito il termine venne applicato per indicare quasi esclusivamente i cristiani che venivano uccisi per la loro fede. I primi martiri cristiani in assoluto furono gli apostoli di Gesù, fatta eccezione per Giovanni, che morì in esilio. Il periodo del cristianesimo primitivo precedente al regno di Costantino viene considerato "l'era dei martiri".
Il "martire" è il "santo" per eccellenza nella concezione della Chiesa antica e solo in seguito altre categorie di santi si sono aggiunte ai martiri.
Nei primi tempi, l'appellativo di martire era usato per designare gli apostoli, ancora viventi, come testimoni delle opere e della risurrezione di Gesù. Poi il nome venne esteso a tutti quelli che con la propria condotta avessero dato dimostrazione di fede e infine fu riservato a coloro che fossero morti in seguito alle persecuzioni. Il nome corrispondente in latino era confessor.
Nel Cattolicesimo vengono individuati tre tipi di martirio:
- Martirio bianco, che consiste nell'abbandono di tutto ciò che un uomo ama a causa di Dio.
- Martirio verde, che consiste nel liberarsi per mezzo del digiuno e della fatica dai propri desideri malvagi, o nel soffrire angustie di penitenza e conversione.
- Martirio rosso, che consiste nel sopportare la Croce o la morte a causa di Gesù Cristo. La morte in martirio di un cristiano veniva considerata un tempo il "battesimo nel sangue", nel senso di una purificazione totale dell'anima, simile all'effetto del battesimo in acqua: subendo il martirio la santità era assicurata, non potendo più peccare. Questa è la ragione per la quale il martirio nell'antichità era non solo accettato, ma addirittura ricercato.
Secondo il catechismo cattolico la figura del martire è contraria a quella dell'apostata, di colui cioè che ha tradito la fede. I martiri sono onorati come santi o beati e mediante preghiere, funzioni e celebrazioni eucaristiche, se ne commemora il dies mortis o il giorno della morte.
La lista dei martiri cattolici è riportata in un opportuno libro liturgico detto Martirologio Romano.
 Martirologio Romano *** Martyrologium Romanum.
Martirologio Romano *** Martyrologium Romanum. Il Martyrologium Romanum (Martirologio Romano) è un libro liturgico e costituisce la base dei calendari liturgici che ogni anno determinano le feste religiose. La prima edizione ufficiale risale al XVI secolo e fu approvata da Papa Gregorio XIII nel 1586.
Nei primi tempi della storia del Cristianesimo si prese uso di conservare memoria di coloro che morirono per causa della loro fede: i Martiri. Ogni chiesa particolare aveva un suo martirologio, cioè un elenco di martiri; ben presto si diede importanza al giorno del loro passaggio dalla morte alla vita eterna, detto il dies natalis, e si prese a commemorare il giorno della loro morte per celebrare la loro memoria, particolarmente nel luogo ove riposavano le loro spoglie.
Nel XVI secolo si decise di unificare i vari martirologi in un solo elenco nel quale trovassero posto tutti i santi e i beati riconosciuti come tali dall'Autorità della Chiesa Cattolica: la grande opera di revisione fu affidata da Papa Gregorio XIII e dal cardinale Guglielmo Sirleto al cardinale Cesare Baronio che la completò nel 1586: venne allora pubblicato il primo Martyrologium Romanum. Successivamente vi furono apportate aggiunte e modifiche per via delle numerose canonizzazioni e beatificazioni fatte soprattutto durante il papato di Giovanni Paolo II.
Attualmente il martirologio è curato dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti.
Il libro è strutturato in un elenco di informazioni; il nome dei santi è accompagnato da una breve nota comprendente il luogo di morte, la qualifica di santo o beato, il titolo denotante il suo "status" ecclesiale (apostolo, martire, dottore della Chiesa (maestro della fede), missionario, confessore, vescovo, presbitero, vergine, coniuge, vedovo, figlio), l'attività e il carisma.

 Mausoleo.
Mausoleo. Monumento funebre e solenne eretto in memoria di un defunto. E' una tomba di eccezionale monumentalità.
Di seguito l'immagine del mausoleo della Basilica di San Bernardino a l'Aquila, eretto in onore di San Bernardino da Siena. Il mausoleo conserva al suo interno le spoglie del santo vissuto tra il 1380 e il 1444, religioso italiano appartenente all'Ordine dei Frati Minori e proclamato santo nel 1450 da papa Niccolò V. Inoltre, nel maggio del 1946, papa Pio XII ha elevato tale basilica alla dignità di basilica minore.

 Mazza corale.
Mazza corale. Insegna usata dal gran maestro del coro durante le funzioni solenni. È impugnata nella mano destra in segno d'autorità e per dirigere il canto, ma anche per fare rispettare l'ordine nel coro. È generalmente in materiale prezioso. La parte terminale può presentare diverse tipologie (a ferula, a tau) o può recare alla sommità un pomo, una statuetta, un gruppo scultoreo o anche una decorazione assai elaborata avente talora l'aspetto di una lanterna.

 Mazza processionale.
Mazza processionale. Bastone portato durante le processioni dai membri di una confraternita religiosa, di una corporazione o di una parrocchia. Alla sommità dell'asta figura generalmente un pomo con una croce od una statuetta, spesso entro un'edicola, raffigurante il santo patrono o l'emblema della confraternita, della congregazione o della parrocchia.


 Medaglia devozionale.
Medaglia devozionale. Medaglia con appiccagnolo da portare in segno di devozione appesa al collo o a volte appuntata alle vesti o sospesa ad un arredo (culla, ecc.). È decorata con soggetti religiosi di vario tipo e spesso con iscrizioni (medaglia-scapolare, medaglia miracolosa, medaglia di pellegrinaggio, medaglia giubilare, medaglia pontificia, ecc.). Talvolta è commemorativa di un evento privato di significato religioso (medaglia battesimale, medaglia della comunione, ecc.). Se di grandi dimensioni, si definisce medaglione devozionale.

 Mensa.
Mensa. Con il termine "mensa" si vuole indicare il piano dell'altare maggiore o di un altare minore, generalmente realizzati in marmo (ma anche in legno), su cui il sacerdote celebra la Messa; in altre parole è il piano su cui si realizza il Santo Sacrificio. A questo proposito si usa anche il termine "mensa d'altare". Al centro della mensa d'altare vengono sigillate, all'interno di una pietra, le reliquie dei martiri. Questa Pietra Sacra vi viene inclusa dal Vescovo durante la consacrazione dell'altare, e vuole significare l'unione di Cristo e dei suoi membri nell'offerta del Santo Sacrificio.
Spesso col termine "mensa" si indica anche il piano della balaustra, ideata per favorire la distribuzione della comunione in ginocchio ai fedeli. In tal caso è detta "mensa da Comunione".
 Messa.
Messa. La Santa Messa è il rito che celebra il sacrificio eucaristico; in questo rito si rinnova realmente, in modo non cruento, quindi senza spargimento di Sangue, il Sacrificio di Cristo Gesù sulla Croce. L'unico e perfetto Sacrificio che Nostro Signore Gesù Cristo ha compiuto di se stesso sul Golgota, offrendosi al Padre per la nostra Salvezza e per riacquistarci l’adozione a Figli di Dio e la vita eterna, perdute a causa del peccato originale (colpa realmente commessa dai nostri primogenitori, da noi contratta, non commessa, ma della quale portiamo tutte le conseguenze, anche dopo che viene cancellata per mezzo del santo Battesimo); questo Sacrificio, si riattualizza sull’altare (che rappresenta il Golgota), dove Nostro Signore, durante la Santa Messa, si offre nuovamente in Sacrificio a Dio Padre (in unione ai nostri) per tramite del sacerdote (che agisce in persona Christi).
Ogni membro del Corpo mistico (ossia della Chiesa) riceve col Battesimo il diritto ed il dovere di «prendere parte» al Sacrificio del Capo di quel Corpo, che è Cristo. È dovere e privilegio dei fedeli di non restare inattivi alla Messa; nessun atteggiamento passivo, che si limiti a guardare ed ascoltare, ma la loro partecipazione deve essere completa, di anima e di corpo.
Anzitutto di anima, facendo atti di pentimento, di lode, di fede, per mezzo di suppliche e ringraziamenti, come viene suggerito dalle preghiere e letture recitate o cantate all’altare, ma soprattutto attraverso l’offerta a Dio del più grande dono: Cristo stesso, in memoria della sua Santa Passione, della sua Resurrezione da morte e della sua Ascensione alla gloria celeste, offrendo anche il mistero della nostra Redenzione che viene commemorato, o gli atti di virtù praticati dai santi di cui si celebra la festa. Questa offerta è fatta al Canone della Messa e non è possibile comunicarsi prima di averla compiuta, poiché per mezzo della nostra Comunione noi siamo associati, uniti all’offerta fatta sull’altare a nostro nome.
Mentre, la partecipazione del nostro corpo consiste nell’usare occhi, labbra e membra per vedere e seguire ciò che avviene sull’altare, leggendo silenziosamente le preghiere che il celebrante recita a nome nostro, prendendo parte con la nostra voce per quanto ci è possibile (cantando alla Messa cantata le parti dell’Ordinario e rispondendo al Sacerdote nella Messa letta) e stando in piedi, inginocchiati o seduti secondo il momento. I fedeli, con le loro risposte, canti e gesti devono dimostrare che essi sono fisicamente una parte dell’assemblea di cui sono membri.
Merita una particolare importanza la Messa domenicale, ossia la Messa celebrata la Domenica, giorno del Signore (dies Domini - giorni del Signore). Nella vita della Chiesa, la Domenica è come una Pasqua settimanale. In questo modo il Mistero Pasquale, che domina tutto l’anno liturgico, compenetra ogni settimana la vita dei battezzati, evitando così che tale Mistero Pasquale sia celebrato una sola volta all’anno nel giorno della Pasqua di Resurrezione. Sta proprio in questo l’importanza della Messa domenicale e la ragione per cui è dovere assistere alla Messa festiva!
La pratica della Messa dialogata è certamente uno dei modi migliori per partecipare alle Messe non cantate. Non tutti i testi della Messa devono essere letti ad alta voce dai fedeli; molti competono solo al sacerdote; tuttavia è bene seguire in silenzio anche queste parti, non con una ripetizione meccanica, ma con una riverente e seria riflessione, meditandone i pensieri espressi. Le altre parti della Messa furono originariamente, ed anche tuttora lo sono, designate per essere recitate dai fedeli.
Una Istruzione della Sacra Congregazione dei Riti («De Musica sacra, 3 sett. 1958») specifica i quattro stadi o gradi della partecipazione alla Messa dialogata, percorrendo i quali i fedeli possono essere portati alla piena adesione ai sacri misteri.
Primo grado: i fedeli rispondono al celebrante, quasi “dialogando” con lui ed a chiara voce, le risposte liturgiche più facili: Amen; Et cum spiritu tuo; Deo gratias; Gloria tibi, Domine; Laus tibi, Christe; Habemus ad Dominum; Dignum et iustum est; Sed libera nos a malo.
Secondo grado: i fedeli recitano anche le parti che, secondo le rubriche, spettano al serviente; prima della distribuzione della S. Comunione recitano con il celebrante, per tre volte, Domine, non sum dignus.
Terzo grado: i fedeli recitano con il celebrante le parti dell’Ordinario: Gloria in excelsis; Credo; Sanctus-Benedictus; Agnus Dei.
Quarto grado: i fedeli recitano con il celebrante anche le parti del Proprio: antifona all’Introito; graduale, alleluia o tratto; antifona all’Offertorio; antifona alla Comunione. Quest’ultimo grado si può usare con la dignità conveniente soltanto in adunanze di persone ben istruite e più colte.
I fedeli, infine, possono recitare con il celebrante tutto il Pater noster; però solo in lingua latina e terminando da parte di tutti con Amen.
La partecipazione alla Messa, nel modo qui sopra indicato, costituisce la preparazione ideale alla Santa Comunione. Sviluppa infatti nell’anima quei sentimenti di contrizione (dall’inizio all’Orazione), di fede (dall’Orazione al Credo), di speranza (al Canone), di amore (alla Comunione) e di gratitudine (dalle abluzioni alla fine), che sono indispensabili per ricevere degnamente e con profitto l’Eucaristia.
Dunque, sostanzialmente è possibile fare le seguenti differenze per le Messe:
- Nella Messa letta (o bassa), tutte le parti della Messa che richiedono la risposta dei fedeli, dove presenti, sono dialogate con il sacerdote. Possono esserci dei canti, ma non nelle parti dell'Ordinario (le parti fisse: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei). Vengono accese solo le due candele che nell'altare sono collocate più in basso. Prima che il sacerdote torni in Sacristia, dopo l'ultimo Vangelo (prologo di S. Giovanni che si legge alla fine di ogni Messa) si recitano le preghiere leonine, così chiamate perché volute da Papa Leone XIII per chiedere a Dio, mediante l'intercessione di Maria Santissima e di San Michele Arcangelo, protezione dalle insidie che il diavolo vorrebbe tendere alla Chiesa.
- Nella Messa cantata, tutte le parti dell'Ordinario della Messa citate sopra, sono cantate. La domenica si canta l'Asperges me (sostituito dal Vidi aquam nel tempo pasquale) ed il sacerdote benedice tutti i presenti con l'acqua benedetta, in ricordo del proprio battesimo. Si accendono le sei candele che stanno più in alto, ai lati del Crocefisso, che è sempre al centro dell'altare, a ricordarci che l'altare rappresenta il Golgota, luogo dove Nostro Signore offrì una volta per tutte se stesso in Sacrificio al Padre per salvarci dal peccato e dalla morte e riacquistarci l'adozione a figli di Dio. L'altare quindi rappresenta il Golgota perché sull'altare si rinnova realmente, senza spargimento di Sangue, lo stesso Sacrificio che è avvenuto sul Golgota.
- Nella Messa solenne, tutte le parti della Messa sono cantate, compresi il Vangelo, l'epistola, il confiteor ecc.. E' presente un sacerdote, un diacono ed un suddiacono, ed eventualmente un turiferario ed un cerimoniere. Si accendono le sei candele che stanno più in alto, ai lati del Crocefisso. Nella liturgia tradizionale non esiste la concelebrazione: chi celebra è solo il sacerdote.
Le Messe votive, sono Messe celebrate liberamente senza alcun rapporto col calendario liturgico e l'Ufficio Divino, in altre parole non esiste alcun rapporto né con un Santo od un Beato ricordato nel Martirologio del giorno, né con la commemorazione del giorno stesso. Esse sono celebrate sia in forza di una devozione (Sacro Cuore di Gesù, Beata Vergine Maria, ecc.), sia in senso più largo per una speciale intenzione. Possono essere di I, II, III e IV classe.
Le Messe dei defunti (o Messe da requiem), sono celebrate in suffragio delle anime dei fedeli defunti, non in conformità con i cicli liturgici.
In particolare, la Messa quotidiana dei defunti può essere celebrata soltanto nei giorni di IV classe.
La sequenza Dies iræ può essere omessa, eccetto nelle Messe dei funerali. Nel giorno dei morti (2 Novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti) essa è detta, come regola, solamente durante la Messa principale o la prima Messa.
SCHEMA DELLA MESSA.
Preparazione.
Preghiere ai piedi dell’altare.
I - Parte didattica.
Dall’antifona all’Introito al Credo: canti – preghiere – letture.
II - Il Sacrificio.
Offertorio: Dall’offerta del pane al prefazio.
Canone: Dal prefazio alla dossologia finale del Canone (Per ipsum).
Comunione: Dal Pater noster al dopocomunione.
Fine della Messa.
Congedo e benedizione – ultimo Vangelo.

 Messale Romano *** Missale Romanum.
Messale Romano *** Missale Romanum. Il Missale Romanum (Messale Romano) è il messale del Rito Romano della Chiesa Cattolica. Questo è il maggiore libro liturgico e contiene tutte le formule e le informazioni (testi, orazioni, canti, gli stessi gesti e le rubriche) necessarie al celebrante per la celebrazione della Santa Messa durante tutto l'anno liturgico. Esso è dotato di segnacoli che permettono di segnalare le pagine che servono per la celebrazione.
In particolare, nel Missale Romanum sono contenuti: l'Ordinario della Messa, che contiene le parti fisse (invariabili) dette ad ogni Messa, ossia i riti e le preghiere che appartengono all'essenza del Sacrificio dell'altare e che non possono cambiare; il Proprio della Messa, che contiene le parti variabili di ogni Messa del giorno, ossia le tre orazioni (Orazione, Secreta e Dopocomunione), le tre antifone (all'Introito, all'Offertorio ed alla Comunione), le due letture (Epistola e Vangelo) e le parti salmodiche che separano le letture (Graduale, Alleluia o Tratto); il Proprio del Tempo o ciclo temporale, rappresentato dall'alternarsi dei tempi liturgici che compongono l'intero anno ecclesiastico, attraverso il quale riviviamo i grandi misteri dell'Incarnazione (Natale) e della Redenzione (Pasqua) di Cristo; il Proprio dei Santi o ciclo santorale, composto dalle feste dei Santi, validi esempi di imitatori di Gesù e sui quali si è compiuta la redenzione; il Comune dei Santi, che racoglie le preghiere che sono in comune nel Proprio dei Santi; le Messe Votive, le Messe dei Defunti, Salmi, Cantici, Inni, Sequenze e Canti, Feste del Signore, Feste della Beata Vergine Maria, Feste dei Santi, Orazioni, l'amministrazione dei Sacramenti, ecc..
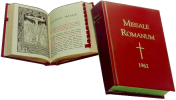
 Ministrante o chierichetto.
Ministrante o chierichetto. Il ministrante, o chierichetto, è colui che svolge un servizio di assistenza ai sacerdoti e ai diaconi durante la liturgia.
Questi possono ad esempio portare la croce, il messale, le ampolline e quanto concerne l'altare; portano il turibolo e la navicella ed inoltre portano i cantari.
L’abito proprio del ministrante è la veste (nera o rossa) e la cotta. Spesso tale abito viene sostituito impropriamente dall’alba (camice bianco chiuso da cerniera) o dalla “Tarcisiana” (veste bianca dotata di due fasce rosse). Il patrono dei chierichetti è San Tarcisio da cui deriva anche la parola “Tarcisiana”.


 Ministro Sacro.
Ministro Sacro. Nella Chiesa Cattolica i Ministri Sacri sono coloro che hanno ricevuto l'Ordine Sacro, ossia hanno ricevuto il Sacramento dell'Ordine in almeno uno dei quattro possibili gradi del sacerdozio che sono: sudiaconato, diaconato, presbiterato ed episcopato (pienezza del sacerdozio); in particolare, questi ordini sacri sono detti ordini maggiori e nel caso del sudiaconato, diaconato e presbiterato si parla di ordinazione sacerdotale, mentre nel caso dell'episcopato si parla di consacrazione sacerdotale. Originariamente esistevano anche quattro ordini minori, l'ordine degli ostiari, dei lettori, degli esorcisti e degli accoliti, poi sopressi da Papa Paolo VI e trasformati nei corrispondenti ministeri.
L'insieme di tutti gli uomini che hanno ricevuto l'Ordine Sacro è detto Clero e i loro membri sono chiamati chierici ed il loro compito è la cura e la santificazione delle anime, esercitando ognuno i doveri del proprio ministero sacerdotale.
«QUESTA SEZIONE E' ANCORA IN FASE DI REALIZZAZIONE»